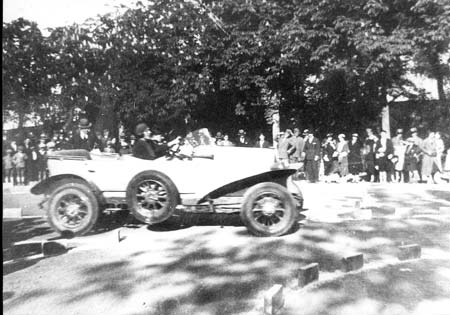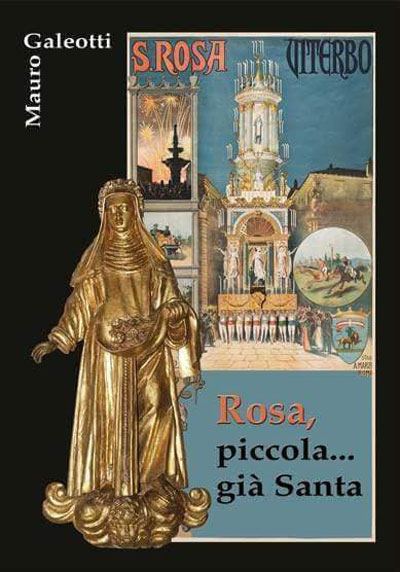Memorie romanzate di Giambattista Bugatti, detto Mastro Titta (1779 -1869), boia dello Stato Pontificio dal 1796 al 1864.
Pubblicato a dispense dall’editore Perini nel 1891, prende spunto però dal taccuino scritto dallo stesso Bugatti, ritrovato da Alessandro Demollo e stampato da Lapi, Città di Castello nel 1886.
Si pensa scritto da Ernesto Mezzabotta, l’autore più prolifico del Perini.
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso
VII.
L’assassinio di un Giudìo - Parricidio.
Le prime esecuzioni dell’anno 1802 furono in persona di grassatori. Il primo, Domenico De Cesare, lo impiccai sulla piazza di Ponte Sant’Angelo, il giorno 8 febbraio. E se vi fu mai uno che meritasse d’andarsene al diavolo colla fune intorno al collo, era lui. Aveva grassato un povero spazzino per togliergli i pochi baiocchi, coi quali doveva comprare il pane a’ suoi figliuoli. Arrestato, confessò il delitto cinicamente, senza mostrarsene menomamente pentito. Respinse il primo confortatore che gli si presentò, sputandogli in volto, e mentre io gli legavo le braccia, dissemi:
- Attento Mastro Titta, perché se non mi tieni saldamente, scappo e vengo a farti una visita di notte a Borgo Sant’Angelo.
Parimenti a Ponte, dodici giorni dopo, cioè il 20 febbraio 1802, impiccai e squartai Ascenzo Rocchi e Giovanni Battista Limiti, che avevano aggredito sulla strada di Bracciano alcuni carrettieri, tolti loro i denari, i ferraioli, e perfino due copelle di vino che portavano per il proprio consumo. Uno dei carrettieri aveva tentato di difendersi e gli diedero un colpo di bastone sulla testa che la mandò tramortito al suolo.
Sorpresi dai birri fuggirono, ma furono agguantati non guari dopo, processati, condannati e giustiziati. Morirono muniti dei religiosi conforti e sinceramente pentiti, mostrandosi coraggiosi anche in faccia al patibolo.
Più ardua bisogna fu quella che mi toccò il 15 marzo del 1802, nel qual giorno ebbi a mazzolare, scannare e squartare, sempre a Ponte Sant’Angelo, Giovanni Francesco Pace di Venanzio che aveva grassato ed ucciso un ebreo.
L’affare era andato così:
Il Pace, oriundo napoletano, aveva messo bottega di sartore a San Carlo ‘a Catinari e prendeva la roba a credito da un mercante giudìo di nome Abramo, in Ghetto. Non venendogli fatto di strappargli i denari, il mercante lo costrinse un giorno a firmargli delle obbligazioni a lunga scadenza. Una sera rincasando il Pace incontrò Abramo al ponte Quattro Capi: una triste idea lo assale. Si guarda attorno e non vede anima viva; faceva freddo, un fitto nevischio cadeva e nessuno usciva di casa. L’idea del sartore era di farsi restituire le obbligazioni. Non appena concepita volle tradurla in atto, e afferrandolo subitaneamente per il collo gli intimò:
- Fuori le carte.
- Non le ho - rispose atterrito, colla voce nella strozza il giudìo.
- Fuori le carte - ripete il Pace.
E l’altro pur sotto quella potente stretta si serra le mani al petto, per impedire all’aggressore di
frugargli addosso. Questo allora trae di tasca le forbici che portava sempre con sé e ne inferisce più colpi alla gola del giudìo.
Abramo cade, intriso del sangue che gli sgorgava dalle ferite, e muore colle braccia sempre conserte al petto e irrigidite.
Pace si china allora sopra di lui e gli toglie dal pastrano un portafogli pieno di valori fiduciari e una borsa con alcune monete. Quindi se ne va tranquillamente a casa a dormire.
Le aggressioni anche in città erano allora all’ordine del giorno, o più precisamente all’ordine della notte e non destavano gran rumore. Trattandosi poi d’un israelita la cosa pareva quasi naturale. Si fece qualche indagine dall’autorità e non essendosi potuto scoprire nulla non se ne parlò più.
Incoraggiato dall’impunità il Pace, dopo aver spese le monete, pensò di servirsi dei valori ed andò ad offrirli ad un cambiavalute al Corso. Questi insospettitosi avvertì il fiscale che fece una perquisizione alla bottega del sartore, gli trovò il portafogli con delle carte che ne indicavano il legittimo proprietario. Pace fu tratto in arresto e mandato alle carceri. Sulle prime negò sfrontatamente e disse che il portafogli lo aveva trovato per terra in via Rua. Ma messo alle strette finì per confessare ed ebbe come dissi, la ricompensa degna del suo misfatto. Il 3 aprile 1802, recatomi a Fermo, mazzolai e squartai Domenico Zeri, il quale aveva ucciso il proprio padre, in seguito ad un litigio insorto per la divisione di un piccolo fondo venuto loro in retaggio per la morte di un lontano parente.
Stavano entrambi cenando in cucina e accalorandosi né discorsi avevano bevuto di molto vino cotto, che dà al capo ed abbrutisce bestialmente. Da una parola acerba ad un’altra il padre minacciò Domenico Zeri di privarlo anco di quel poco che gli avrebbe dovuto lasciare alla sua morte.
- Voi non lo farete! - esclamò d’un tratto rizzandosi minaccioso, e cogli occhi iniettati di sangue Domenico Zeri.
- E perché no? - gli chiese il padre alzandosi pure lui, quasi in atto di sfida.
- Perché non ve ne lascerò il tempo - rispose allontanandosi qualche passo dalla tavola, accostandosi all’ampio camino, e stendendo la mano dietro di sé, per cercare qualche cosa.
Il vecchio sempre più irritato afferrò il boccale di terraglia ormai vuoto, che si trovava sul desco e lo scagliò al figlio ferendolo alla fronte. Sentendosi il volto irrigato di sangue questi perdette il lume della ragione e afferrata la pala del fuoco ne assestò un terribile colpo sulla testa al padre, che cadde boccheggiante al suolo. A quel truce spettacolo, Domenico Zeri fuggì; errò parecchi giorni per le campagne e finì coll’essere arrestato dai birri a Recanati.
Ricondotto a Fermo più morto che vivo per la paura e lo strazio del rimorso, confessò subito il suo misfatto e manco tentò difendersi. I giorni trascorsi fra la condanna e l’esecuzione furono per lui una continua agonia, lenta e crudele. Delirava giorno e notte in preda a violentissima febbre, refrattaria ai più potenti antipiretici. Convenne affrettare l’esecuzione della sentenza, per tema che se ne andasse all’altro mondo defraudando l’umana giustizia. Agli ultimi momenti confortato dai cappuccini parve riaversi alquanto e s’avviò al patibolo recitando preghiere e raccomandazioni alla pietà dei fedeli. Ma era una vita, dirò così, fittizia la sua; quando gli bendai gli occhi era diaccio, e giurerei che non ha sentito il colpo della mazzola.
Squartato, i suoi resti rimasero esposti sul palco per tutta la giornata, appesi ai ganci infissi nella travatura.
Durante la notte furono distaccati ed ebbero sepoltura, per opera dè cappuccini stessi, in un appezzato di terreno vicino al cimitero, non potendo essere in questo inumato.
(Continua)
Le memorie precedenti:
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "1. Le prime opere"
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "II. L’assassinio di un prete"
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "III. Un bargello e due guardie assassini"
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "IV. La grassazione della Principessa"
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "V. Lo stupro d’una vergine"
Mastro Titta, il boia di Roma Memorie di un carnefice scritte da lui stesso "VI. La vendetta di un marito oltraggiato"