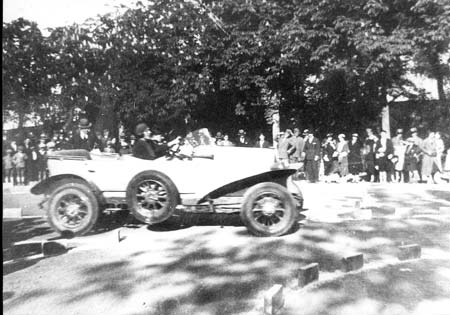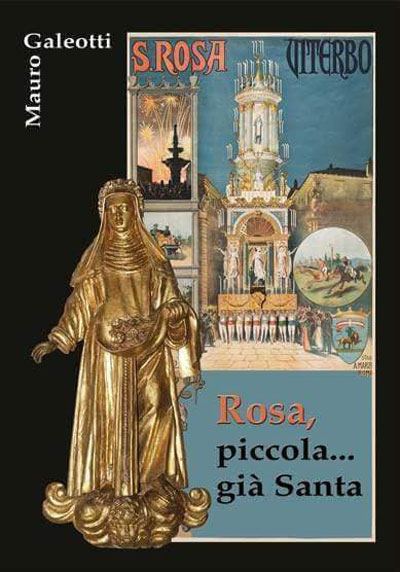Bruno Matteacci
Questa è la storia, una storia lunga, lunga una vita, di mio zio, Bruno Matteacci, nato a Gubbio nel 1936, ma viterbese sin da piccolo.
Una storia di ogni giorno, perché basta cambiare i nomi ed ognuno di noi, in più parti della narrazione, ci si ritrova.
Oh sì! I ragazzi di oggi non la vivranno come chi, negli anni descritti ne è stato partecipe, erano davvero altri tempi, ma certo servirà loro, per comprendere quanto è bella la Vita, quanto è importante il Ricordo, quanto è educativo il Dolore.
Tre brevi parole che allungano la memoria, quella memoria che ci ha consentito di conoscere, crescere, migliorare per l'unico nostro fine: amare il prossimo.
Mauro Galeotti
Ai miei genitori Giuseppe e Maria
A mia sorella Bruna
Ai miei figli Patrizia e Giuseppe.
Ai miei adorati nipoti: Federica, Daniela, Iacopo, Viola e Fiammetta
PERCHE' NON VENGA DIMENTICATO
CIO' CHE E' STATO
In questo modesto scritto, privo di alcuna pretesa letteraria sono, senza dubbio,
presenti ripetizioni di concetti religiosi, ma non di avvenimenti, episodi e fatti.
Io non me ne dolgo, perché in questo mondo, egoista e desideroso solo di benessere del corpo, ci vivo male.
Spesso la mia mente ritorna all'infanzia e rimpiange certe situazioni che, seppure vissute nel poco, in quel poco c'era tanta felicità, tanto amore, tanta serenità, c'era quello che si chiama "famiglia".
Bruno Matteacci
_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_°_
Alle ore sette e trenta di venerdì 10 luglio 1936 vidi, per la prima volta, la luce del mondo, di questo magnifico mondo, dove è stato bello vivere e mi auguro di continuare, ancora, fino a che Dio vorrà. Intanto sono giunto alla bella età di sessantanove anni, quarantatré giorni e due ore; momento in cui mi sono seduto nel mio studio, davanti ad un computer, con lo scopo di scrivere quanto ricordo della mia vita; con la speranza che qualcuno dei miei successori, un giorno, dedichi del tempo per sapere qualcosa in più di Bruno Matteacci e dei suoi familiari, che sono poi le radici.
La mia famiglia, che abitava nel Comune di Gubbio (Perugia), in località Casamorcia, al numero 62 era composta da mio padre Giuseppe, mia madre Maria Ceccarelli e dalla mia amata sorella Bruna, di anni tre. La mia era una famiglia, come ce ne erano tante, modesta, operatrice, serena, religiosa che amava vivere anche con quel poco, spesso troppo poco, che era possibile guadagnare onestamente.
Mio padre, nato a Pietralunga (PG), vocabolo "Ronzano", il 3 Marzo 1906, figlio di un colono, perse la madre Rosa all'età di sei anni rimanendo con la sorella Letizia di anni undici, i fratelli Salvatore di anni tredici, Eugenio di otto e Tommaso di due. Il nonno Luigi, che amava molto la moglie Rosa Cecchini, tra stenti e sacrifici, tirò, come soleva dire, "la baracca verso il domani".
La vita era dura viverla con i proventi della terra, erano tempi in cui i prodotti del sudato lavoro venivano accaparrati, per la maggioranza, dai proprietari del fondo agricolo che tenevano sotto il giogo l'operaio e che da questi pretendevano oneri e onori. Mio nonno Luigi era, come mi raccontava mia madre, il "timbro" della persona di mio padre: stessa taglia, uguale portamento, identico carattere; era uno che diceva "pane al pane e vino al vino"! Era un'epoca in cui la maggioranza degli uomini, per non dire la totalità, portava il cappello.
Mio nonno rinunciò a questa usanza con lo scopo di evitare di togliersi il cappello, come era uso fare, non nel senso di saluto, ma nel senso di sottomissione davanti al proprietario terriero; quindi il nonno non portando, volutamente, il cappello, non aveva questo non gradito dovere.
In una notte fredda del 1929, nel periodo di carnevale, in una festa da ballo, Maria e Giuseppe si incontrarono.
Giuseppe, che era un bravo ballerino, chiese, a mio nonno Cesare Ceccarelli, il permesso di poter ballare con la figlia Maria. Ottenuto il consenso la coppia si fece rapire da un valzer, suonato da un esperto fisarmonicista della zona di Sioli. Quello non fu che l'inizio di un grande amore che si coronò col matrimonio l'8 febbraio 1930. L'ingresso di mia madre nel nucleo familiare dei Matteacci cambiò, totalmente, il modo di vita della famiglia; ella portò un raggio di sole che illuminò il futuro di tutti.
Nel momento della trebbiatura del grano, nell'anno 1930, la mamma dovette affrontare, da sola, quello che era l'organizzazione e la gestione del pranzo che aveva carattere di gran festa e quasi, quasi si potrebbe dire: era un'occasione per fare, di un momento di lavoro, sfoggio di cibi, di stoviglie e tovaglie.
La mamma, visto che la gestione della casa era allo sbando perché la zia Letizia, sorella di mio padre, non era in buona salute e il resto della famiglia era composto solo da cinque uomini che badavano, maggiormente, al lavoro dei campi, alla custodia degli animali, alla disponibilità di un buon sigaro, di un pacchetto di sigarette "Alfa" e di un buon bicchiere di vino, prese, come era solita dire "le redini della casa" e affrontò la riorganizzazione di quanto necessario per fare la giusta, dovuta, bella figura agli occhi di tutti e del proprietario della trebbiatrice.
Era usanza consolidata che al proprietario della trebbiatrice e delle altre macchine necessarie per la trebbiatura venisse riservato un tavolo separato a quello grande, a ferro di cavallo, destinato agli altri lavoratori, che normalmente erano vicini coloni con i quali c'era lo scambio della mano d'opera.
La mamma, in previsione di quanto voleva fare, prese una certa quantità di polli, di conigli ed un cesto contenente uova fresche e, a piedi, s'incamminò, con passo sicuro, su una strada incerta per andare ad Umbertide per vendere il tutto.
Mentre mamma mi raccontava questo episodio, eravamo a bordo di una fiammante Alfa Romeo Turbo 155 di 1990 cc., percorremmo il tratto che ella fece "a piedi" 60 anni prima, con un non indifferente peso.
Era ed è una strada assai lunga; quel giorno, ricordo, che fermai l'auto in prossimità del ponte a Umbertide, punto dove la mamma si fermò a vendere i prodotti del lavoro della famiglia, tra una mia lacrima e lo stato di commozione di mamma, ci abbracciammo e ci baciammo.
La mamma vendette tutto ciò che aveva portato e con il ricavato integrò il contanti che aveva ed acquistò tovaglie, piatti, posate, bicchieri e quant'altro utile per la famiglia; non dimenticando sigari e sigarette per gli uomini di casa.
I Matteacci, nella zona, erano conosciuti con l'appellativo: "i Moravola" perché così si chiamava la località dove abitavano. Detto soprannome fu quindi riservato ai Matteacci e loro eredi.
Infatti, tuttora, se mi reco in una zona limitrofa a Pietralunga o Gubbio, per far sapere chi sono, devo dire: "sono Bruno Matteacci, figlio di Giuseppe di Moravola" e tutto è facile, per gli "anziani", per mettere a fuoco la persona che hanno davanti.
Il tempo trascorreva tra il lavoro e le tante difficoltà che trovava mio padre perché non amava lavorare la terra. Lui è stato sempre un bravo artigiano, sapeva fare anche il fabbro.
Mi raccontava che all'età di tredici anni costruì uno "schioppo" che utilizzò una sola volta, perché in una battuta solitaria di caccia si incontrò con dei carabinieri che gli tolsero l'arma, promettendogli che non avrebbero detto nulla al nonno Luigi, il quale era scarso di complimenti.
A casa del nonno Luigi, come in molte case di contadini, si uccideva il maiale e, in occasione di quella giornata, si faceva una bella cena con i parenti più vicini e qualche amico del circondario.
Mio padre raccontava che per lui non era una festa perché per "festa" lui intendeva, in quella occasione, mangiare la carne del maiale.
C'era l'usanza di fare la "padellata", molto piccante a base di pepe a volontà, perché il tutto così piccante aiutava e spronava il bere del buon vino della zona.
Mio padre aveva in quella circostanza circa sette anni e di cibi piccanti non ne voleva sentire.
Stante il fatto che l'abitazione era lontana dal paese e quindi dal luogo dove era possibile acquistare sali, spezie e quant'altro necessario per una famiglia, al ritorno del nonno dallo "spaccio", mio padre, di soppiatto, prese il "cartoccio" di carta paglia, di colore giallo, pieno di acini di pepe e lo gettò, spargendolo a tipo di semina, nell'orto che si trovava davanti alla propria abitazione, dicendo tra sé e sé: "vedrai che questa volta la padellata la mangio pure io!".
Nell'ora della cena, il sole era calato dietro il monte, la persona addetta alla cucina disperatamente si mise alla ricerca del "cartoccio" contenente il pepe. Tutto fu invano, il pepe non venne trovato; lo spaccio era lontano e quindi la soluzione ultima fu quella di cucinare il tutto senza pepe.
Giuseppe ebbe ragione, quella volta anche lui mangiò, con gusto, la padellata di maiale che non aveva il difetto di "piccare".
Ricordo altri episodi giovanili della vita di mio padre che mi sono stati raccontati da lui o da qualche amico che ho avuto modo di conoscere nelle varie escursioni fatte nei luoghi dove il babbo ha vissuto.
Mi è stato raccontato, da più persone, che il babbo era un ottimo cavaliere, tanto che andava a cavallo senza sella, cioè a "pelo".
Una volta fece una gara che consisteva nel cavalcare la propria cavalla, senza sella, tenendo per ogni mano un fiasco, pieno di vino.
La partenza ebbe luogo tra due ali di popolo festante e il babbo, forte della sua esperienza, salì in groppa alla sua cavalla e, dopo una sferzata data all'animale da un organizzatore, partì come un razzo percorrendo la bianca strada, al centro della stessa, fino a quando, nell'abbordare una curva, intuì che la cavalla aveva stretto troppo, sulla destra, facendogli correre il rischio che, a causa della presenza del parapetto di un sottostante ponte, la gamba destra venisse schiacciata contro il muretto.
A quel punto, al babbo non rimase che tentare l'incredibile, cioè alzare la gamba destra e restare seduto sulla cavalla, per quanto sufficiente ad evitare la collisione. Chi assistette alla scena disse: "solo Peppe di Moravola poteva fare una mattata del genere".
Non sempre le cose andarono per il senso giusto. In occasione di una scommessa, sempre sullo stile di quella che lo rese famoso, nell'abbordare una curva, con un fiasco per mano e senza sella, a causa di una improvvisa impennata della cavalla, cadde e si ruppe il braccio destro che poi, nel corso della vita, detto incidente lo salvò da pericoli maggiori.
All'età di venti anni, il babbo si arruolò nell'Esercito italiano, scegliendo il corpo del Bersaglieri e fu destinato al 1° Reggimento Bersaglieri a Napoli.
Di quel periodo custodisco gelosamente la sua fotografia in divisa col piumetto di cui era orgoglioso, mi raccontava che: "penna su penna aveva fatto il cappello con le piume più lunghe del reggimento".
Come ho brevemente accennato, mio padre non amava lavorare la terra, diceva: "la terra è bassa".
Sin da giovane, si dedicò all'arte del calzolaio anche se, per necessità di sopravvivere, non disdegnava effettuare qualsiasi, pur umile, lavoro allo scopo di dare un decoroso sostegno alle esigenze della famiglia.
In epoca di trebbiatura era un ottimo "imboccatore", cioè era colui che stava sulla trebbiatrice e riceveva i "fasci" di grano legati che, dopo aver tagliato la "legatura", "imboccava" nella macchina dove i potenti denti della trebbiatrice dividevano il grano dalla "pula" e dalla paglia.
Ricordo che i miei genitori; in occasione di una gita fatta, negli anni cinquanta, a bordo della loro Fiat Topolino 500 cc., di colore verde, con la capotte bianca alla "fiorentina", mezza balestra, mi dissero, allorché percorrevamo la strada che porta alla Basilica di Sant'Ubaldo, sul monte Ingino a Gubbio, che qualche pianta di abete che faceva bella mostra di sé, era stata messa a dimora da mio padre, in occasione di qualche giornata di lavoro che egli fece con la Forestale.
Una delle prime grandi gioie dei miei genitori fu la nascita della figlia che avvenne, in località Montelovesco, il giorno 25 marzo 1933, alla quale, stante il fatto che era una bella bambina con i capelli neri, fu imposto il nome Bruna.
La famiglia di Giuseppe, Maria e Bruna era felice, mancava la realizzazione di un sogno, quello di andare ad abitare in un centro abitato, stare in comunione con altri, vivere i privilegi e i problemi del paese.
Decisero, di trasferirsi a Gubbio, nella frazione di Casamorcia, in un appartamento composto da camera, cucina, sala ed un maga¬zzino a piano terra. Il lavoro di calzolaio lasciava a desiderare infatti, nelle campagne, la gente camminava scalza. I miei genitori mi raccontavano che la gente portava le scarpe adagiate sulla spalla e le indossava solo all'ingresso del paese, per poi toglierle quando uscivano dalle porte del paese stesso per recarsi nelle campagne dove avevano la propria abitazione.
Il consumo e la necessità di riparare le scarpe era quindi sempre molto limitata e chi ne pagava le conseguenze era il calzolaio, fra i quali mio padre che, come detto, si adattava a qualsiasi lavoro pur di non far mancare il necessario alla mamma e a Bruna. Nel 1936 il babbo, in epoca di mietitura del grano andò, con la mamma, ad effettuare qualche giornata di lavoro presso proprietari di terra in zona Pierantonio.
In quel periodo mamma era in attesa della mia nascita, quindi poco poteva lavorare, ma la gentilezza e l'umanità dei datori di lavoro, stante la condizione di mamma, le risparmiarono la faticosa opera della mietitura, dandole l'incarico di provvedere a trasportare piccoli recipienti, pieni di acqua, per dissetare le operaie e gli operai che sotto i bollenti raggi del sole mietevano le dorate spighe di grano.
La sera del 9 luglio del 1936, mentre i miei genitori rientravano a casa ebbero il primo cenno del mio arrivo; portarono mia sorella Bruna dalla nonna Assunta, madre di mia madre, dove la lasciarono e i due, con tanta stanchezza nel corpo, ma con tanto amore nel cuore si diressero all'ospedale di Gubbio dove il giorno successivo nacqui.
Prima di prendere in esame l'epoca successiva alla mia nascita mi corre l'obbligo dire quanto ricordo della famiglia di mia madre, Maria Ceccarelli.
I nonni materni si chiamavano: Cesare Ceccarelli (22-2-1881 / 22-4-1946) e Assunta Grelli (22-6-1888 / 26-7-1979); avevano otto figli: Maria, mia mamma, (17-1-1913 / 14-2-1996); Ubaldo (23-1-1915 / 18-2-2000); Dante (18-7-1916 / 6-10-1998); Giuseppe (8-3-1919 / 9-11-1991); Ida (1-4-1922); Anna 1924; Emilio 1927; Giuseppa (13-4-1930 / 11-7-1962). In verità i nonni ebbero altri quattro figli dei quali, purtroppo, due non nacquero e due, Nello e Nella, morirono.
Il nome di Nella fu imposto, come terzo nome, a mia sorella Bruna la quale aveva anche il nome di nonna Rosa; mentre il nome Nello fu imposto a me che ho anche il nome del nonno paterno, Luigi.
Anche la famiglia Ceccarelli aveva radici agricole; viene ricordata, nella zona Camporeggiano - Pisciano - Nerbici, come gli "Orconi"; soprannome che tuttora è richiesto per dare, agli anziani, la possibilità di riconoscere un soggetto ed attribuirlo a quella casata.
Dei nonni materni ricordo i volti, il loro amore che avevano per i nipoti come del resto ho scolpito nel cuore e nella mente l'immagine di tutti gli zii, fra i quali Giuseppe, mio compare e zio Emilio, quasi coetaneo, che più che zio era ed è un caro amico con il quale ho fatto delle birbonate e tuttora faccio delle belle gite nei territorio eugubino. Relativamente alle zie ricordo zia Pina con la quale avevo un rapporto amichevole poiché ella aveva sei anni più di me, quindi era una cara amica più che zia, mentre con zia Ida, residente a Gubbio e zia Anna residente a Roma, spesso ci vediamo o ci sentiamo.
Con i cugini c'è solo rispetto; essendo io il più grande, avrei tanto gradito tenere rapporti più da parenti che da semplici conoscenti. Purtroppo nella vita non si può avere tutto!
Avrò occasione di parlare, in seguito, più dettagliatamente, dei vari componenti le famiglie Matteacci e Ceccarelli; per ora ritengo più giusto parlare della mia presenza nella famiglia Matteacci e raccontare quanto mi è possibile.
Appena mamma ebbe partorito, nella famiglia, ci fu un'esplosione di gioia: la femmina c'era da tre anni e si chiamava Bruna, era bella e mora. Ora è arrivato il maschio che, anche se con i capelli biondi, fu chiamato Bruno, con l'augurio che i due, forti pure di avere lo stesso nome, si amassero sempre di più durante la loro vita, che veniva guardata da Maria e Giuseppe, con tanto amore e dolcezza.
Il babbo dopo essersi accertato che il nascituro era "veramente" maschio pretese che al figlio fossero tolte le "fasce" allo scopo di dare un bacio sul "pipo", come lo chiamava il babbo.
Soddisfatto e tanto contento che, avrebbe voluto, se potuto, far suonare il "campanone di Gubbio" per esternare la sua gioia di avere un "maschio", ma dovette reprimere questa gioia e partire per andare a lavorare.
Mi raccontava il babbo che, mentre lavorava, non sentiva la fatica, ma un senso di gioia e, per un attimo, tanto quanto necessitava per effettuare un sospiro, a voce alta diceva: "Ho un figlio maschio"! Questa nenia si ripeteva tutti i giorni, il babbo era alle stelle e gli amici, che con lui prendevano parte a questa gioia, lo assecondavano.
I giorni trascorrevano sereni, ma il babbo si dimenticò di denunciare la mia nascita, correndo così il rischio di dover pagare una certa somma, nelle casse del Comune, per tale omissione.
Per evitare la multa gli fu suggerito di dichiarare che il figlio Bruno era nato il 15 luglio 1936 allo scopo di rientrare nei termini stabiliti dalla legge.
Il babbo così fece: fatta la legge, trovato l'inganno!
Io sapevo di essere nato il 10 luglio, ma all'età di sei anni, in occasione della consegna della prima pagella scolastica della mia vita notai la data del 15 luglio. Subito mi presentai alla mia ancora amata maestra Forti per contestare l'errore.
Fu necessario l'intervento dei miei genitori per chiarire, alla maestra ed al sottoscritto, quanto accadde nel lontano 1936.
Il babbo aveva necessità di lavorare, la sua passione era fare il calzolaio, attività per la quale si sentiva trasportato essendo, ogni giorno, più convinto che quello era il suo mestiere perché in esso vedeva rappresentate tutte le sue capacità artigianali.
Dopo averne parlato con mamma e con i suoceri e aver trascorso qualche notte insonne prese contatti con il suo caro amico, Renato Monacelli, che aveva la stessa necessità di lavoro.
Di comune accordo decisero di partire e, come diceva il babbo: "in bicicletta, con due lire in tasca, tanta buona volontà, via alla scoperta del mondo".
La notte che precedette la partenza fu trascorsa insonne, mamma e babbo parlarono a lungo, la conversazione verteva sui figli, sul domani della famiglia, sulla certezza che il babbo, quanto prima, avrebbe trovato un alloggio nel "nuovo sconosciuto mondo" e si sarebbe fatto raggiungere. Giunse il momento dell'arrivederci; un bacio ai figli ed alla moglie, uno sguardo alla immagine religiosa di Sant'Ubaldo e giù per le scale.
Era una mattinata fresca e leggermente coperta da un manto di nebbia.
Aperto il magazzino e indossato lo zaino, contenente quanto possibile, dopo aver controllato, ancora una volta, l'efficienza dei freni della sua bicicletta Legnano', dato un bacio ed un abbraccio a mamma, Giuseppe Matteacci partì; destinazione la tanto reclamizzata Littoria.
Nel raccontare il viaggio da Gubbio a Littoria, città fondata da Mussolini nelle Paludi pontine, mi limiterò a narrare, solo, quanto riguarda mio padre perché nei confronti di Renato Monacelli ho solo tanto rispetto perché, in momenti tristi e difficili, hanno diviso problemi e guai; di gioie non ne ho sentito mai parlare se non quando parlavano dei familiari.
Il babbo, infatti, diceva che gli unici momenti di felicità erano quelli che affioravano alla sua mente soltanto quando pensava ai figli, alla moglie e ai luoghi della sua Gubbio.
I chilometri da percorrere erano tanti, la forza nelle gambe non mancava e la speranza, di un domani migliore, era immensa, specialmente se si raffrontava alle sofferenze passate e alle incertezze che si ripetevano tutti i giorni.
Le ore passavano lentamente, le soste erano tante a causa delle forature delle gomme. All'interno, i copertoni delle ruote delle biciclette, avevano una camera d'aria, così chiamata, perché essa doveva contenere aria che veniva immessa, a pressione, con una pompa a mano.
Il babbo mi diceva che era arrivato ad un punto che, stante le numerose pezze incollate, al fine di poter continuare il viaggio, non sapeva più di quale colore fosse la camera d'aria, perché per i buchi riparati venivano usati pezzi di vecchie camere d'aria di vari colori.
Il babbo, prudentemente, evitava di sostituire, interamente, la gomma allo scopo di garantire il più possibile la prosecuzione del viaggio, perché la riserva di camere d'aria era limitatissima e i soldi erano pochi.
Dopo aver affrontato, sotto un sole cocente, ripide salite, spianate polverose e tentato di gustare qualche discesa, che consentiva il temporaneo riposo delle gambe, giunsero a Settebagni, in provincia di Roma.
L'appetito, per non dire la fame, era tanto; durante il loro andare, l'unica cosa che ogni tanto facevano era quella di raccogliere, lungo le campagne che fiancheggiavano la strada, qualche frutto che serviva loro come cibo e rinfrescante della bocca.
Il primo pensiero che ebbero, all'ingresso della borgata, fu quello di acquistare, in uno "spaccio", un chilo di spaghetti, per poi recarsi in un punto di ristoro, detto "vino e cucina", dove si fecero cuocere gli spaghetti che dovevano essere conditi con olio e sugo di pomodoro, innaffiati, poi, da del buon vino.
Mentre una robusta signora, moglie del titolare dell'osteria, si apprestava a cucinare quanto richiesto, il babbo ed il suo amico Renato parlavano dei propri famigliari ed il loro ricordo era un incitante stimolo a continuare il viaggio.
L'attesa non fu lunga, il carbone, usato per cucinare, era leggermente bagnato, causava quindi del noioso fumo che anneriva, ancor più, il tetro locale.
Gli spaghetti, ben conditi e fumanti, furono presentati, a Giuseppe e Renato, in un grosso bacile, mentre il proprietario del locale portava un fiasco di vino e due bicchieri.
Non restava altro che mettere nei piatti il tanto desiderato cibo; cosa che fece Renato. Il babbo, è stato sempre una buona "forchetta" e, a tale proposito, ricordo che lui usava una forchetta ai quali allargava i denti di presa, allo scopo di raccogliere dal piatto più pasta possibile.
Ho, e la tengo gelosamente, per mio uso, la forchetta che il babbo ha usato fino al giorno che è stato chiamato in cielo.
Con i due piatti pieni di pastasciutta e qualche rimasuglio nel "bacile" il babbo, con un gesto a me noto, infilzò il cumulo di spaghetti, pronto ad arrotolare la forchetta e portare il tutto alla bocca, ma la felicità durò un solo istante!
Nel momento di portare la forchetta alla bocca, il babbo vide che, tra uno spaghetto e l'altro, c'era una grossa mosca morta.
Tutto crollò in quell'attimo, la fame sparì, la rabbia salì al massimo.
Il babbo, con un plateale gesto, spinse lontano da sé il piatto e dichiarò che non avrebbe mangiato.
Renato, non se lo fece dire due volte; invitò il babbo a mangiare qualcos'altro chiamando la cuoca per sentire cosa poteva dare, in sostituzione di ciò che veniva rifiutato.
La risposta del babbo fu secca e definitiva: "Renato, ti ringrazio, mi si è chiuso lo stomaco, anche se facessi uno sforzo, nel mio stomaco, non entrerebbe nemmeno uno spillo; ti prego mangia tu". Renato mangiò tutta la pasta!
Il cielo, che fino a quel momento era soleggiato, agli occhi di mio padre divenne buio e, senza dire una parola, ripresero il cammino verso sud.
All'imbrunire non era prudente continuare, ulteriormente, il viaggio; erano giunti a Monterotondo e la stanchezza si faceva sentire.
Gli "spacci" avevano chiuso i battenti; per fortuna ne trovarono uno ancora aperto, entrarono e decisero di acquistare un po' di ventresca di maiale, di quella salata; un fiasco di vino, un "filone" di pane, il tabacco "trinciato", delle "cartine" e due pacchetti di sigarette.
Prima di mettersi a mangiare cercarono un punto in cui era possibile trascorrere la notte, sotto un tetto, allo scopo di difendersi dalla umidità e dalle zanzare.
Fatte poche centinaia di metri, sul ciglio di una curva era un casolare che aveva dipinte sul fianco, verso la strada, delle strisce bianche e nere, atte a segnalare la costruzione, che aveva un angolo rasente la strada stessa.
Il babbo e Renato oltrepassarono il cancello di legno, che era semiaperto, ma si dovettero subito fermare perché un grosso cane pastore, bianco, con grossi denti, si mise ad abbaiare.
Si fece avanti un uomo che, sopra i pantaloni, indossava i cosciali di pelle di pecora; aveva in mano un frustino di nervo con il quale, alla vista dei due, ordinò al cane di andare a cuccia.
I due nel salutare quel "signore", così il babbo ha sempre definito quella persona di Monterotondo, chiesero se era possibile trascorrere la notte sotto la tettoia che si trovava nell'aia.
La risposta fu migliore di quella sperata ed attesa dai due; il "signore" li invitò ad andare a dormire in un locale, sito al piano terra, adibito a magazzino.
Detto e fatto entrarono, insieme al colono del fondo, spostarono degli attrezzi, lì depositati, misero della paglia in terra e la coprirono con della balle di juta.
Il babbo e Renato invitarono l'ospite a bere insieme, un bicchiere di vino; questi gradì e, augurando una buona notte, se ne andò, dopo aver detto che nella zona, dove i due erano diretti, c'era la malaria, a causa delle paludi esistenti.
Prima di coricarsi, il babbo e Renato si avvicinarono ad un abbeveratoio dove era un pozzo con una pompa a mano. Presero dell'acqua, che risultò essere freschissima; si dettero una sciacquata alle mani e al viso, ne bevvero un paio di sorsi e si misero, poi, a mangiare pane e ventresca.
Mi raccontava il babbo che, in quella occasione, fu più gradita l'acqua che il vino.
Fu una notte da non dimenticare! C'è da premettere che, all'altezza del soffitto del magazzino, erano appesi tanti, tanti pomodori maturi che, ogni tanto, se ne staccava uno e, poveretto chi stava sotto.
Comunque, un poco dormirono, fu una notte trascorsa con tanta speranza perché, l'indomani, i due eugubini sarebbero giunti a Littoria, sebbene risuonasse, fortemente, nel loro cervello la notizia relativa alla "malaria".
Non totalmente scoraggiati vollero, di fatto, accertare la situazione mettendosi nuovamente in viaggio percorrendo una strada molto dritta, in terra battuta, che poi fu chiamata "fettuccia di Terracina".
Non ci volle molto per capire che la zona era letteralmente invasa da zanzare e di venire a conoscenza che molte persone erano affette di malaria e curate con il chinino.
La decisione fu immediata; il babbo disse: "mai porterò mia moglie e i miei due figli in questo putridume" e, sentito l'amico, si salutarono e, con il cuore amareggiato, partì verso il nord, più precisamente verso Tarquinia dove sperava di poter fare il tanto desiderato mestiere di calzolaio.
Il viaggio divenne molto più faticoso, la solitudine era imperante, ma la speranza di un domani migliore, era sempre presente, speranza che dal babbo era considerata il "carburante" idoneo a percorrere, in bicicletta, altre centinaia di chilometri.
Tra una sbuffata, tante forature ed una rottura della catena, il babbo arrivò a Tarquinia, dove si fermò a mangiare i rigatoni, una salsiccia, e bere un goccio di vino che, come diceva lui: "mi sentii rinato".
Durante il pasto ebbe modo di parlare con delle persone le quali, saputo che il babbo cercava lavoro da calzolaio, lo dissuasero di fermarsi a Tarquinia e lo consigliarono di andare a Viterbo, dove era in costruzione un aeroporto che sarebbe divenuto un centro con molti militari dove, sicuramente, tutti avrebbero indossato le scarpe; contrariamente a quanto avveniva a Tarquinia, che come a Gubbio, la gente indossava le scarpe solo nell'approssimarsi alla città.
Il babbo, saputo che Viterbo era a circa quaranta chilometri da Tarquinia, visto che erano circa le ore quindici, decise di partire con la sua fedele bicicletta Legnano.
Sull'imbrunire giunse a Viterbo, oltrepassò Porta Fiorentina; all'altezza della fontana del Vignola, fu avvicinato da un signore il quale, tra l'altro, gli disse: "Quel matto di Piazza Venezia ci porta alla rovina".
Mio padre, che era una persona di poche parole, rispose: "Io non m' interesso di queste cose, so che devo lavorare per la famiglia e per la Patria; la politica la faccia chi la sa fare".
Quel signore ebbe un attimo di esitazione, domandò a mio padre quale era il suo paese d'origine, al che il babbo rispose: "Gubbio".
Lo sconosciuto soggiunse: "A... siete di Gubbio, Perugino quindi... brava gente, siete dei veri lavoratori, e a Viterbo, che siete venuto a fare?".
Il babbo, turbato, rispose dicendo che gli sembravano già troppe le domande fatte.
Quello sconosciuto signore, abbozzando un sorrisetto, gli offrì un lavoro, come guardiano, alle dipendenze della ditta Vaselli, che stava costruendo l'aeroporto di Viterbo.
Il babbo gli disse che svolgeva l'attività artigianale di calzolaio, ma che per il momento, avendo l'urgente necessità di trovare una casa e di stabilirsi a Viterbo, accettava l'offerta fattagli.
A questo punto avvenne quello che dette a mio padre una certa serenità; quel signore scrisse, su un biglietto, quanto necessario per presentare mio padre ad un tecnico della ditta Romolo Vaselli per la sua assunzione, come guardiano notturno.
I due continuarono a parlare del più e del meno, il babbo parlò della famiglia, che aveva lasciato a Gubbio e che, quanto prima, desiderava riunirsi ad essa; ringraziò quel signore il quale, prima di allontanarsi, disse: "Perugino, se avete bisogno, mi potete trovare alla G.I.L. (Gioventù italiana del littorio) auguri!".
Il babbo, il mattino successivo, si recò al cantiere dove incontrò il capo operaio, Angelo Valeri, che lo accompagnò da un ingegnere, al quale consegnò il biglietto di presentazione; fu subito assunto come guardiano notturno.
Successivamente il babbo riuscì a trovare un appartamento in affitto, in Località Le Zitelle, in prossimità del costruendo aeroporto, precisamente in Strada Valore, di proprietà del signor Peruzzi.
Un altro, importante, adempimento da fare, per il babbo, fu quello di chiedere la residenza al Comune e farsi prendere in carico dall'Ufficio Annona, ufficio che provvedeva a dare, ad ogni cittadino, la tessera per l'acquisto, controllato, di generi alimentari.
Il babbo si presentò in quell'ufficio comunale e vi trovò un impiegato, non tanto alto, con una foltissima capigliatura, con l'unghia del mignolo molto lunga.
Questo fu un particolare che colpì l'attenzione del babbo, che chiese di avere più bollini per l'acquisto di pasta e pane e, meno bollini per l'acquisto di carne; anche se lui era un "cicciaiolo", cioè gli piaceva moltissimo la carne; il babbo fu accontentato.
Dopo, circa venticinque anni, mi sono trovato a lavorare, nell'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, prima come impiegato, poi come direttore, con quel carissimo, impagabile, onesto e leale impiegato, che si chiama Enzio Cherchi, abitante a Viterbo in via del Cunicchio e che il babbo conobbe il giorno che venne a Viterbo all'Ufficio Annona.
Il babbo, aveva a Gubbio un caro amico che si chiamava Ubaldo Pascolini detto "Vinciarone" (31/8/1909 - 8/12/1978), marito di Elisa Brestolli detta Lisetta (23/3/1913), che oggi ha la venerata età di anni 92, amica e coetanea di mamma, che tuttora vado a trovare nella sua abitazione al numero 2 di Zangolo, frazione di Gubbio, dove Lisetta mi accoglie con tanto affetto.
Il problema del lavoro lo aveva anche "Vinciarone", così il babbo fece del tutto per far sì che Ubaldo potesse venire a lavorare a Viterbo. Gli scrisse e lo fece venire a lavorare presso il costruendo aeroporto; Ubaldo si fermò per un certo periodo di tempo, poi ritornò a Gubbio.
Passarono pochi giorni di assestamento ambientale. Mio padre si preoccupò subito di scrivere una lettera alla moglie, che era rimasta a Gubbio con due figli, Bruna di anni quattro e Bruno di anni uno.
La mamma, nell'arco della sua vita, ha sempre dimostrato tanta gratitudine al babbo per averla portata a Viterbo, dove poi furono raggiunti dalla famiglia di nonno Cesare e nonna Assunta che andarono ad abitare in via San Girolamo n. 48 in un appartamento di proprietà del signor Renato Latilla.
Successivamente vennero gli zii paterni: Salvatore, Eugenio e Tommaso con la famiglia, composta da lui, la moglie Elisa ed dal figlio Luigi.
La mamma mi diceva che sulla lettera che le inviò il babbo c'era scritto: "che lui era giunto a Viterbo, che stava bene, che chiedeva notizie di noi tutti e che la mamma si doveva preparare perché, al più presto, sarebbe ritornato a Gubbio per trasferire tutti a Viterbo".
Nel contesto della lettera il babbo tentò di fare una esposizione, direi che tentò di fare quasi una fotografia della zona, infatti scrisse: "Viterbo si trova a pochi chilometri da due laghi; vicino ci sono le montagne e, a quaranta chilometri, c'è il mare; poi sai che ti dico: Viterbo è una città che non si allagherà mai...".
Questo, secondo me, voleva dire che, oltre che essere "la città più bella del mondo", come soleva dire il babbo, era una città sicura, sotto ogni punto di vista, in particolare da eventuali alluvioni.
Mi raccontavano i miei genitori che, in una domenica di giugno del 1938, intorno alla casa, sita in Località Le Zitelle, era un campo di grano, talmente giallo che sembrava un mare d'oro nel quale, in un attimo di distrazione, mi nascosi tra le spighe senza rispondere ai loro richiami.
Il colore dei miei capelli, che erano biondi come l'oro, si confondeva con il colore delle spighe rendendo difficile la mia individuazione che, per un attimo, creò uno stato di paura alla famiglia.
Con il crescere avvenne a Bruna e a me una strana metamorfosi. Bruna, da scura che era, divenne una bellissima bionda, mentre io, che ero biondo sono divenuto nero, anzi, ero nero oggi sono "cacio e pepe"!
Il babbo aspirava sempre fare il calzolaio, la situazione della famiglia era in fase statica e le ore libere del giorno, alle Zitelle, non potevano essere utilizzate per svolgere l'attività artigianale di calzolaio perché l'abitazione si trovava in un contesto agricolo lontano dal flusso del traffico e dalle altre abitazioni.
In quel periodo, il babbo conobbe il signor Bruno Gibellini, allevatore di bovini, che aveva un figlio, Bernardo detto Nando, con il quale, dopo tanti anni, diventammo amici e compagni di scuola; amicizia che dura tuttora.
Di notte, il babbo faceva il guardiano nel costruendo aeroporto militare, aveva così una sicura entrata economica che gli permetteva di vedere il futuro con uno sguardo più sereno.
Ricordo, vagamente, che una notte, con mamma e Bruna andammo a cena giù, in una caserma in costruzione, dove mangiammo patate in umido, con grossi pezzi di carne, che mamma aveva cucinato con tanto amore.
Intanto, come si suol dire: una tegola, grossa come una casa, cadde sulla testa dei miei genitori; fui colpito da una malattia che mi faceva andare al bagno dalle venti alle venticinque volte al giorno.
La situazione era allarmante, fui preso sotto il vigile occhio clinico del professor De Antoni, primario all'Ospedale Grande degli Infermi "Renato Capotondi Calabresi", qui fui urgentemente ricoverato.
I medici avevano poche speranze sulla mia guarigione; la mamma, che mi assisteva giorno e notte, un giorno si sentì chiedere, da una sprovveduta signora che non conosceva, "quale fosse il bambino, di poco più di due anni, che stava per morire". Per mia madre fu una pugnalata al cuore, corse dal professore De Antoni gridando: "Me lo salvi, me lo salvi!".
Il professore tranquillizzò la mamma dicendole che era nella sua intenzione fare una trasfusione di sangue da madre al figlio, una trasfusione totale come se volesse cambiare totalmente il sangue a Bruno. La trasfusione fu fatta nella mattinata e i risultati si notarono circa ventiquattro ore dopo; le evacuazioni intestinali si ridussero subito a circa una quindicina al giorno, con una successiva, costante, riduzione, sino alla totale guarigione.
Tornata la normalità del vivere, i miei genitori si misero alla ricerca di un nuovo alloggio, che fu trovato non tanto lontano dalle "Zitelle"; qualche chilometro più vicino a Viterbo, per la precisione la zona si chiama Occhi Bianchi, sulla strada Tuscanese.
Per primo abitammo in un appartamento al piano terra, al numero civico n. 1, vicino a dove è oggi il ristorante "La Villetta". L'appartamento era di proprietà della famiglia di Nestore Leoni con il quale, con lui prima e con gli eredi poi, abbiamo avuto sempre ottimi rapporti d'amicizia.
Successivamente, essendosi liberato un appartamento al numero 7, al secondo piano, con ingresso sul lato nord, con una grande scalinata e con le finestre verso Viterbo, ci si trasferimmo e vi rimanemmo fino al 1943, ossia fino a quando, a causa della guerra, ci trasferimmo a Camporeggiano-Pisciano di Gubbio, dove ho trascorso, senza dubbio, il periodo più bello della mia infanzia, con la mia amata sorella Bruna e il compianto cugino Luigi, che era nato a Pisciano, dove restammo, come "sfollati", per oltre due anni.
Nel nuovo domicilio, di strada Tuscanese, 7, al babbo fu possibile esercitare la tanto amata professione di calzolaio, mentre la mamma, per aiutare "la baracca", come era solita dire, faceva occasionali lavori di lavanderia, stireria e sarta.
Giunse il momento di mandare Bruna a scuola, eravamo nel 1939.
Bruna fu iscritta alla classe prima della Scuola elementare "Edmondo De Amicis", che si trova in zona "Le Monachelle", oggi via Emilio Bianchi, sotto il magistrale insegnamento della maestra Enrica Facchinetti, deceduta a Viterbo il 29 maggio 1953.
Bruna ha sempre ricordato, la sua insegnante, con amore e per tanti anni è andata a trovarla, nella sua ultima dimora, a pochi passi dall'ingresso principale del cimitero San Lazzaro di Viterbo.
Del periodo, in cui abbiamo abitato agli Occhi Bianchi, sulla strada Tuscanese, ho ricordi che spesso ritornano alla mia mente.
Elencherò solo quelli che hanno lasciato una traccia indelebile, sia nel mio cuore che in quello di Bruna e dei miei genitori.
In quel periodo gli svaghi per far riposare il corpo e la mente ce n'erano pochi, chi si soffermava all'osteria a giocare a carte, chi in un cortile adiacente all'osteria per fare alla "Morra" o chi preferiva uno sport povero e popolare come "il ruzzolone", che veniva giocato all'aperto.
La gara si svolgeva, normalmente, nelle giornate festive, quando i carri agricoli erano fermi sulle aie e i robusti contadini cercavano uno svago, tra una buona colazione o una succulenta merenda, accompagnata con un buon bicchiere di vino.
La strada preferita era il "Vicoletto" o meglio la strada Castiglione, che ha inizio agli Occhi Bianchi e procede verso l'aeroporto, era una strada percorsa normalmente da carri agricoli ed era quello il posto dove si davano appuntamento i vari contendenti. L'attrezzo che usavano era una grossa ruzzola costruita con legno di acero o frassino, che acquistavano dal tornaro; uno dei quali, molto noto, era il signor Sensi, padre del Cavaliere del Lavoro, Socrate, con laboratorio artigiano in via San Cristoforo.
Il babbo, conosciuto come "il Perugino", era un accanito giocatore di ruzzolone, gioco che faceva pure a Gubbio con una piccola ruzzola di ferro o con piccole forme di formaggio ben stagionato.
A Viterbo gareggiava con vari sportivi, fra i quali ricordo: i fratelli Armando e Umberto Isidori, Valentino detto "Bravocristiano", Flavio Feliziani, Candido Piacentini, i fratelli Biscetti della Quercia ed altri, che non ricordo.
Tutti usavano un grosso ruzzolone che veniva lanciato con l'ausilio di una corda, detta "sparacina", avvolta intorno allo stesso, mentre il babbo usava una piccola ruzzola di ferro che riceveva la spinta dalla forza del braccio.
A tale proposito, sulla rivista dell'E.P.T. di Viterbo "Tuscia" del 26 dicembre 1981, a pagina 17, in un articolo di Giorgio Falcioni sul "ruzzolone" è scritto: "...Negli anni successivi ci fu una novità che colpì notevolmente i praticanti viterbesi, perché da Gubbio venne Giuseppe Matteacci che impiegava una ruzzoletta di ferro più leggera, secondo l'usanza umbra; ma l'innovazione non attecchì".
Qualche volta anch'io ho accompagnato il babbo quando giocava a ruzzolone; ricordo che andavo molto più avanti dal punto di lancio della ruzzola, in modo di vedere dove terminava la corsa della stessa.
A volte capitava che il ruzzolone, o la ruzzola del babbo, nel roteare, cozzavano contro qualche sasso, più grosso del normale, prendendo un percorso diverso da quello voluto dal lanciatore, andando a fermarsi nei campi; per questo noi bambini eravamo utili, perché potevamo seguire la traiettoria del ruzzolone ed evitare che si perdesse.
Lungo il "Vicoletto", mia sorella Bruna imparò ad andare in bicicletta.
Bruna imparò subito ma, ad un certo punto girò la testa in dietro, per vedere se la sua amica era vicina e, nel riprendere la guida della bicicletta, non fece in tempo ad evitare un cumulo di pietre, e cadde riportando una escoriazione ad un ginocchio.
Per i più giovani voglio ricordare che le strade erano quasi tutte senza asfalto, in particolare quelle secondarie, per non parlare poi di quelle consorziali, interpoderali e vicinali le quali erano strade cosiddette "bianche" e venivano ogni tanto imbrecciate.
A tale proposito con mezzi di trasporto che potevano essere un camion, a gomme piene, ossia senza camera d'aria, o qualche carro agricolo, venivano trasportate grosse pietre e lasciate, in cumuli, lungo i margini delle strade, in attesa dello "spaccapietre".
Il lavoro dello spaccapietre, come dice la parola, consisteva nel mettersi seduto a cavallo sul cumulo di pietre e, con un martello, spaccare, frantumare la grossa pietra trasformandola in piccole brecce che, successivamente, venivano sparse sul manto stradale; tale lavoro, prendeva il termine “imbrecciatura”.
Oggi molte di queste ex strade bianche sono asfaltate e la vecchia massicciata è divenuta la base dell'attuale manto stradale catramato, dove le nuove generazioni, con le loro brillanti auto, passano senza sapere che sotto c'è ancora il lavoro ed il sudore di coloro che spesso, troppo spesso, vengono dimenticati.
Avrò avuto circa dieci anni, la sera di un sabato di marzo, il babbo mi disse se, all'indomani, avessi piacere di trascorrere la mattinata con lui andando a caccia nella zona della proprietà del signor Carlo Goletti, detto "Mecotorso", che si trovava lungo la strada Castiglione, meglio conosciuta come, il "Vicoletto". La risposta fu affermativa.
Al mattino la mamma si svegliò presto per preparare la colazione mentre io, che ero felice di poter stare con il babbo, mi preparai indossando un paio di pantaloni alla zuava; un maglione e gli scarponi, confezionati da mio padre con pelle anfibia.
Io avevo l'onere di portare il tascapane e i laccetti per mettere la selvaggina; di ciò ero orgoglioso, perché mi sentivo cacciatore.
Mentre andavamo, con la bicicletta Legnano, lungo il Vicoletto, un'autovettura ci sorpassò a velocità sostenuta che, oltre sollevare molta polvere, fece diventare bianchi i miei pantaloni ed il maglione e ci fece correre il rischio di cadere.
Ricordo che il babbo disse: "Verrà un giorno che anche noi, con la nostra macchina, solleveremo la polvere, ma rallenteremo, nel momento in cui incontreremo o sorpasseremo una persona a piedi o in bicicletta".
Lì per lì forse, data la mia giovane età, non seppi dare un significato immediato a
quanto disse mio padre, se non: "sarà un augurarsi di un futuro migliore?". Poi con gli anni si matura e si pesano parole e azioni, prendendole come lezioni di vita.
Il babbo, invece, poi mi disse che ritenne quell'azione una violenza e non un disturbo, perché camminare su una strada "bianca" vuol dire automaticamente impolverarsi, ma non correre il rischio di perdere la vita per uno sconsiderato sorpasso, commesso da un'incosciente.
Dai miei genitori, tanto ho imparato e racchiuso nel mio cuore; quello che da loro ho avuto spero di averne fatto buon uso.
La cosa più importante, secondo il mio modo di vedere la vita, è trasmettere ai miei figli l'amore verso Dio, il rispetto verso il prossimo, l'amore per la famiglia; con la certezza che si continuerà a vivere, solo se il ricordo resterà nei cuori di chi vivrà.
Forte di questo mio modo di vivere, sono sempre più convinto che: "Chi fu sta vicino a me tanto quanto io oggi, che sono, penso a loro, che furono!".
Questo modo di vivere mi aiuta, sebbene tutto, a tirare avanti, certo e convinto che, se si cammina con la mano tesa in avanti e nessuno ti viene incontro per stringerla, stai perdendo tempo.
Allora capirai che su questa terra la felicità la puoi trovare solo nel tuo cuore e nei ricordi di quello che è stato, in compagnia di chi ti ha amato.
I miei genitori sono stati cattolici convinti e praticanti, infatti, nel periodo in cui siamo cresciuti sotto il loro sguardo, siamo sempre stati, Bruna ed io, sollecitati a pregare, in particolare la sera.
Ricordo che i nostri genitori ci dicevano: "La sera, prima di addormentarvi, pregate, pregate per i nostri morti e ringraziate Iddio, Santa Rosa ed Sant'Ubaldo per quanto abbiamo e, alla mattina, dato che per farvi svegliare ci vuole tempo e dovete poi andare a scuola, quello che ci raccomandiamo è che vi facciate il segno della Croce, rivolgendo poi al Signore un pensiero".
Il parroco, a cui facevamo riferimento, in quella zona, era don Otello Ferrazzani della Parrocchia dell'Ellera, che mi è stato amico, fino al suo ritorno alla Casa del Padre.
Ricordo un episodio che dette tanta preoccupazione ai miei genitori.
C'è da premettere che all'epoca era difficile trovare un appartamento con impianto di acqua potabile.
La quasi totalità delle famiglie si dovevano recare alla fonte pubblica per attingere, con vari contenitori, acqua potabile. Per lavare biancheria e quant'altro necessario, le massaie si dovevano recare al lavatoio pubblico che in città si poteva trovare in varie zone.
Lavatoi esistono ancora nella zona di Pianoscarano; in via dei Vecchi, in prossimità di Porta Fiorita; sotto il ponte di via San Lorenzo, in via della Torre e in via Pietro Vanni; come pure è esistito, fino a qualche mese fa, anche se fatiscente, quello degli Occhi Bianchi.
Un giorno nel vicino lavatoio non c'era ulteriore posto per una massaia, poiché lo stesso aveva una capacità per sei persone; mamma, che aveva bisogno di fare il bucato, decise di farlo usando la tavola inclinata, incastrata dentro la tinozza; cosa che rientrava nella generalità delle attività domestiche, in sostituzione del lavatoio pubblico..
La mamma era assorta nel suo lavoro, usava acqua, sapone ed estratto di varechina, contenuto in un apposito fiasco di vetro, ricoperto dalla "scarcia"; fiasco simile a quello che si usava per contenere l'acqua da bere.
Io, avevo circa anni quattro, ero un bambino più che vivace, e mi avvicinai nel punto in cui la mamma stava lavorando, senza chiedere nulla, presi il fiasco e, assetato come ero, feci una lunga bevuta.
Fu un attimo; al grido della mamma, seguì un soffocato mio grido e fui subito soccorso.
In quel preciso momento, provenendo da Viterbo, il babbo stava rientrando a casa con la sua fedele bicicletta, oltrepassato il cancello del cortile su cui era, al piano terra, l'ingresso della casa, sentì mamma che gridava: "Bruno ha bevuto la varechina!".
Fu tutto un attimo di infinita preoccupazione; il babbo gettò in terra la borsa, contenente la spesa e, senza esitare un attimo, con la sua bicicletta corse a Viterbo con lo scopo di chiamare un taxi, ritornare agli Occhi Bianchi, caricare su figlio e moglie e correre all'Ospedale Grande degli Infermi, per le cure del caso.
Il babbo, che all'epoca aveva circa trentaquattro anni, era nel pieno delle sue forze e lo dimostrò, ancora una volta, con la tempestività con cui giunse a Porta Fiorentina per sollecitare la presenza di un taxi.
Mi raccontava: "In quel momento non vedevo nemmeno i selci paracarro a margine della strada, vedevo solo te, figlio mio, tra le braccia di tua madre. Giunsi a Porta Fiorentina, feci un salto dalla bicicletta, spingendola verso lo chalet Garbini; gridai, all'indirizzo del titolare del taxi numero 4: presto, di corsa mio figlio si è avvelenato!".
Ricordo che il babbo mi disse di essersi inquietato con il conducente del taxi, il quale mise in moto l'auto, imboccò la discesa di via della Palazzina, spense il motore, dimostrando che aveva intenzione di procedere a folle.
Con un grido di mio padre, inteso a far riaccendere il motore del taxi, l'autovettura prese a correre e nelle orecchie dell'autista, come egli stesso disse: per un paio di giorni, riecheggiò quel grido disperato.
Il taxi giunse, agli Occhi Bianchi, così presto, che mamma non aveva fatto in tempo a cambiarmi la maglietta che indossavo.
Caricato che fui sulla macchina, accompagnato dalla mamma e dal babbo, mentre Bruna fu lasciata ad una famiglia dove era la sua amica Silvana Feliziani; giungemmo al pronto soccorso dell'Ospedale di Viterbo.
La diagnosi, sulla base di quanto riferirono i miei genitori ai medici, fu immediata.
Il dottore disse: "Necessita di una buona lavanda gastrica, il problema sarà di tenergli la bocca aperta, comunque, useremo uno strumento di metallo che, a pressione, gli bloccherà la mandibola, tenendogli la bocca aperta".
A queste parole il babbo, che si preoccupava dei miei denti, perché sarebbero stati messi a dura prova, disse al medico: "No, non usi questo strumento, vedrà che se al figlio gli parlo io; lui, che è tanto ubbidiente, aprirà la bocca e la terrà aperta consentendovi di immettere il tubo nello stomaco".
Detto e fatto; in un attimo mi fecero la lavanda gastrica, tra le lacrime dei miei genitori e lo stupore del dottore e degli infermieri.
Il ritorno a casa fu festeggiato, con un forte abbraccio, da mia sorella, e dalle manifestazioni affettuose dei vicini di casa.
Abitare in quel grosso caseggiato significò per me avere vari amici, come per esempio, quelli che ho ancora nel cuore e che purtroppo sono passati a migliore vita: Renato e Marcello Feliziani, Arduino Aquilani, Agostino e Liliana Zappi che ho veduto recentemente, con piacere e Ezio Feliziani che, purtroppo, ha dei problemi di deambulazione, ma è sempre sorridente, come lo è sua sorella Silvana con la quale, spesso, ricordiamo la sua carissima amica Bruna, nonché mia sorella.
Altro amico che ricordo con piacere, sebbene più grande di me, è il geometra Renato Leoni, già economo della RAI e il giovane Alberto Bruschetti, uomo dalle mani d'oro; lui con il ferro ci "ricamava".
Ricordo un episodio che si è svolto tutto sulla mia pelle, per non aver ascoltato mia madre.
I miei amici stavano facendo dei salti sopra un mucchio di rena, che avevano scaricato nel cortile; erano tutti scalzi; alcuni si tolsero le scarpe in quell'occasione, altri stavano senza scarpe tutto il giorno.
Io ero costretto ad indossare sempre le scarpe che il babbo mi faceva con le proprie mani; erano scarpe veramente belle e solide. Quel giorno, di nascosto della mamma, me le tolsi e mi misi a fare i salti, come gli altri ragazzi. Il destino volle che, con un salto, andassi a cadere sopra un fondo di bicchiere rotto, riportando una grossa ferita all'alluce destro. Quel giorno fu più forte il mio dolore, per aver disubbidito alla mamma, che quello fisico, derivante dalla ferita.
Del periodo, in cui ho abitato agli Occhi Bianchi, mi veniva ricordato dai miei genitori che io, all'età di tre anni circa, a chi mi domandava quale erano le proprietà che avevo, rispondevo: "il campo di Pippo, Biancaneve e i sette nani, il cavallo, la mucca Stellina, un asinello e, tante, tante pecorelle tutte bianche".
La fantasia non mi è mai mancata!
Il 12 Maggio 1940, con i genitori e Bruna andammo a Prato Giardino per fare qualche fotografia; eravamo elegantemente vestiti.
Mamma indossava un abito nero con due allacciature al collo, con una "mostrina" trasparente; aveva una elegante borsa e belle scarpe. Mamma era longilinea, aveva ventisette anni, era una bella mamma; il babbo non era da meno, aveva trentaquattro anni, indossava un abito nero, con camicia bianca, cravatta intonata e fazzoletto nel taschino.
Bruna aveva un vestito bellissimo di organza rosa, con elegante borsetta, calzini bianchi, eleganti scarpe e un bel fiocco in testa.
Io ero vestito di velluto, con camicetta bianca e fiocco, bianco e nero, al collo con calzini bianchi e scarpe nere. Dalla foto che facemmo a Prato Giardino si vede un pezzetto di mutandina che si affaccia sotto il pantalone della mia gamba sinistra.
Il babbo ci teneva ad avere, ogni tanto, qualche fotografia, del gruppo famigliare, che si faceva al giardino pubblico dove era il "Toscano", fotografo ambulante.
Ricordo che, dopo lo scatto, il fotografo lo sviluppo lo faceva in nostra presenza mettendo le foto, ancora nere, in una catinella piena d'acqua con strane sostanze che facevano diventare, quel rettangolo di carta, una fotografia.
Momenti belli si alternavano, come normale, nella vita, a momenti brutti.
Un giorno, mentre mamma stava stirando i vestiti, con il ferro da stiro scaldato dal carbone, e il babbo, che collaborava, manteneva acceso il carbone contenuto nel ferro da stiro, agitandolo con un ampio gesto del braccio, colpì Bruna sulla testa.
Fu un attimo tremendo, Bruna cadde a terra; la mamma la prese tra le braccia, mentre il babbo corse a prendere l'alcool e il cotone idrofilo, necessario per tamponare la ferita; mentre Bruna diceva: "Non è niente, non è niente1", grazie a Dio fu solo un grande spavento.
Quando andavamo in città, si usava la bicicletta del babbo, lui alla guida, la mamma seduta sulla canna, io a cavallo sulle spalle, abbracciato al collo del babbo e Bruna, che reggeva me, seduta sul portabagagli posteriore.
Una volta giunti a Viterbo si lasciava la bicicletta a Porta Fiorentina, dove era un'apposita rastrelliera per il parcheggio, poi si andava al cinema.
Al ritorno, prima di uscire da Porta Fiorentina, sulla sinistra, erano i vespasiani a muro, che molti uomini utilizzavano; mio padre, per farmi sentire adulto, mi faceva avvicinare consentendomi di fare pipi. Il babbo mi diceva: "Cocco, sei grande, vedi, fai la pipi dove la fanno gli uomini".
Ricordo che al babbo giunse la cartolina di richiamo per la guerra, non sono in grado di dire la data, però ho la certezza che il babbo dovette partire per Firenze, in procinto di essere inviato, mi sembra, in Albania.
In quell'occasione un'attenta visita, della commissione medica, accertò che il babbo aveva il braccio destro storto, a causa di una frattura, non curata, avuta nella gioventù per una caduta da cavallo, come ho già ricordato.
Il "richiamato" Giuseppe Matteacci, fu dispensato dal partire e fu trattenuto come addetto ai Servizi sedentari. Quella caduta dalla cavalla, in quella famosa gara, fu la salvezza del babbo. Molti partirono e pochi ritornarono.
In quel periodo, in cui il babbo era a Firenze; un giorno, mamma dovette recarsi, con noi figli, a Viterbo per l'acquisto dei mezzi di sostentamento, nel negozio del signor Fernando Franceschi.
Al rientro verso casa, a Porta Fiorentina, dove il babbo era solito accompagnarmi a fare pipi, mi misi a piangere perché volevo ripetere il gesto che normalmente facevo con il babbo.
La mamma, poverina, si trovò in un certo imbarazzo, in quel momento sopraggiunse la signora Costanza, con il marito Flavio, che si prese l'onere di accompagnarmi a fare pipi, anche se non ne avevo necessità.
Gli anni passarono ed anche per me giunse il momento di andare a scuola.
Eravamo nel 1942, fui iscritto alla prima classe della Scuola elementare "Edmondo De Amicis", meglio conosciuta come le "Monachelle".
La mia maestra era la signora Giuseppina Forti, alla quale ho voluto tanto bene!
Del periodo scolastico ricordo che, prima di iniziare la lezione, ci facevano recitare la preghiera per Benito Mussolini, capo del Governo, come pure ci facevano pregare, per lo statista, prima di iniziare il pranzo che ci veniva dato nel refettorio.
A volte mi sembra si sentire ancora sia l'odore dell'olio di fegato che ci davano al mattino, che l'odore dello sgombro che ci veniva dato per pranzo, dopo una minestra o una buona pastasciutta preparate dalla cuoca signora Argia Crochi.
C'è da dire che i miei genitori, a noi figli, non ci hanno fatto mai mancare la colazione che poteva consistere in uno sfilatino con la marmellata o con la mortadella, comunque lo sfilatino nella cartella c'era sempre, sia per me che per Bruna, che frequentava la terza elementare.
Un giorno, la supplente della signora Forti mi prese lo sfilatino, lo spezzò e ne dette una parte ad un ragazzino della mia classe. Nel momento che andai al bagno vidi mia sorella che, con atteggiamento protettivo, come ha sempre avuto, mi domandò perché avevo pianto, visto che avevo gli occhi lucidi. Le narrai l'accaduto e lei, senza esitazione, affrontò la supplente dicendole: "Non si permetta mai più di togliere la colazione a mio fratello; i nostri genitori fanno sacrifici, li facessero pure gli altri!".
Fu una lezione che, come mi diceva la bidella Gloria, fece un certo effetto nell'ambiente scolastico.
Un altro episodio che ricordo dell'epoca, in cui facevo la prima elementare, è questo:
avevo la necessità di parlare con mia sorella perché, per errore, lasciai un mio quaderno nella sua cartella e dovevo rientrarne in possesso nella mattinata. Chiesi alla mia maestra, dopo averle detto il motivo, se potevo uscire per andare da Bruna; avuto il consenso mi precipitai nella classe di mia sorella.
All'epoca era norma comportarsi così: si doveva bussare, attendere il consenso per entrare, aprire la porta facendo un passo in avanti; fare il saluto romano, ritornare un passo indietro e rimanere sull'attenti.
Io sbrigativo: bussai; senza la dovuta autorizzazione, aprii la porta ed entrai e di scatto mi avvicinai verso mia sorella dicendo: "devo parlare con la Matteacci".
Fu una risata collettiva, la maestra Facchinetti mi accarezzò i capelli e mi lasciò parlare con mia sorella.
Tutte le mattine ci si svegliava molto presto perché si doveva andare a scuola; noi abitavamo, circa quattro chilometri, lontano dall'edificio scolastico.
Verso le ore sette, tutte le mattine, proveniente da Tuscania transitava, davanti alla nostra casa, un camion tipo "Bielle", a gomme piene, alimentato a vapore derivante dall'acqua fatta bollire con carbone, legna o gas metano.
Ricordo che il "Bielle" aveva, nella parte posteriore, un grosso recipiente, a forma di cilindro, che conteneva acqua, con sotto vivo fuoco.
Quando sentivamo il rumore di tale mezzo di trasporto, voleva dire che erano le ore sette; quindi ci dovevamo mettere in cammino verso Viterbo; a volte i più audaci salivano, di nascosto, sul predellino posteriore di quel camion.
Tutte le mattine, proveniente da Tuscania, transitava anche un carro trainato da un cavallo, con alla guida un uomo che normalmente dormiva. Il cavallo avanzava tranquillamente e agli Occhi Bianchi, dove era ed è, ancora, una fontana tipo abbeveratoio, si fermava, beveva e ripartiva verso Viterbo, mentre alcuni di noi, senza fare rumore, posavamo la cartella sul carro e a volte salivamo, facendoci trasportare, a turno, per un pezzo di strada.
L'appuntamento, degli scolari della zona, era davanti all'immagine della Madonna che si trova tuttora a fianco della fontana.
Eravamo un gruppetto di quattordici bambini: Arduino e Giuliana Aquilani, Liliana e Agostino Zappi, Silvana, Renato e Marcello Feliziani, Bruna ed io, ai quali si univano, Gino e il fratello insieme all'Adriana (della Dinde) e altri due bambini, tutti abitanti in strada Castiglione.
Il percorso, che facevamo, era tutto al centro della campagna ad eccezione del punto chiamato: "la Centrale", che era proprio all'inizio di strada Tuscanese; pochi metri più a nord era la casa padronale del professore Nestore Narduzzi e del suo colono, detto "Fedino".
Altra abitazione, "la Palazzina", si trovava davanti all'ingresso del campo sportivo; dalla quale prese il nome via della Palazzina, fino a Porta Fiorentina.
Appresso era una seconda costruzione dove, al piano terra, era la famosa "Fiaschetteria toscana" che vendeva, a detta di tutti, dell'ottimo vino di marca.
Tra una costruzione e l'altra, salendo, sempre sulla sinistra; perché a destra era ed è il muraglione del Prato Giardino; erano alcune grotte, scavate nel tufo che spesso ci servivano per ripararci dalle intemperie e, in epoca bellica, per proteggerci da eventuali mitragliamenti aerei o bombardamenti.
Di quel periodo ricordo un episodio che è rimasto vivo nel mio cuore: una improvvisa malattia del babbo.
Stavamo in casa, da pochi minuti avevamo pranzato con un bel piatto di pasta e patate; mamma stava lavando i piatti, Bruna, operosa come sempre, aiutava asciugando piatti e cucchiai, mentre io stavo vicino al babbo che, all'improvviso, cadde in terra, tra atroci dolori e forti lamenti.
Fu un attimo di smarrimento; necessitava portare, urgentemente, il babbo in ospedale. Con l'aiuto del signor Flavio, che abitava in un appartamento in fondo alle scale di casa nostra, il babbo fu preso in braccio con la preziosa collaborazione di mamma e l'aiuto morale di noi due figli che gli tenevamo, ciascuno, una mano.
In quell'attimo pensai di perdere il babbo, lo ricordo pallido, con gli occhi assenti che si lamentava.
Dio è grande, quando lo chiami, Lui risponde e si manifesta in tanti modi!
Quel giorno il miracolo si manifestò con la tanto gradita, quanto utile e necessaria, presenza di un mezzo di trasporto, che in quell'epoca era difficile trovare.
Scendemmo le scale, fatti pochi metri verso la strada Tuscanese, vedemmo che, in direzione Viterbo, veniva un carro, di colore verdognolo, trainato da un bellissimo cavallo di colore bianco e marrone che aveva, vicino agli zoccoli, dei folti e lunghi peli dello stesso colore del mantello.
Il carro, che era dell'Esercito italiano, era condotto da un giovane militare il quale, veduta la precaria situazione dello stato di salute del babbo, si accostò al ciglio della strada, si fermò e dopo aver aiutato a caricare il malato sul pianale del carro, con un perentorio invito, ordinò al cavallo di mettersi al trotto, mentre il signor Flavio e sua moglie ci augurarono ogni bene!
Giunti nel punto in cui è "la Centrale", dove è il bivio per andare a Montefiascone, ricordo che il babbo alzò la testa dal pianale, guardò in direzione del cimitero ed emise un grosso sospiro.
Solo dopo, quando grazie a Dio, Santa Rosa e Sant'Ubaldo, dei quali tutta la famiglia era molto devota, il babbo tornò a casa, con una diagnosi incerta, seppi che, quando eravamo sul carro e lui alzò la testa emettendo un sospiro, pensò: "al ritorno dove mi porteranno, a casa o al cimitero?". Dio volle che il babbo ritornasse a casa.
Intanto, visto che la città di Viterbo era accogliente e che c'era la possibilità di mangiare, serenamente, un pezzo di pane, tutta la famiglia dei nonni, Cesare e Assunta si traferì a Viterbo, andando ad abitare, come ho già scritto, in via San Girolamo, in un appartamento di proprietà del signor Renato Latilla.
Altra gradita immigrazione a Viterbo fu quella di zio Salvatore, fratello maggiore del babbo.
Zio Salvatore, reduce della guerra del 1915-18, fu arruolato con "i ragazzi del '99"; in battaglia rimase ferito ad una gamba con ritenzione, fino alla morte, di un proiettile di moschetto.
Lo zio, era celibe, lavorava come bracciante agricolo, alle dipendenze del signor Massimo Aonzo, nella tenuta Macchia del Conte, sulla strada Tuscanese, dove dormiva in una stanza, che aveva l'ingresso proprio in fondo al letto.
Lo zio, che era molto affezionato a Bruna e a me; veniva a casa, ogni quindici giorni, per trascorrere con noi il sabato e la domenica. Portava la biancheria da lavare in cambio di quella pulita, utile per i successivi quindici giorni.
Nell'agosto del 1942, allo zio Salvatore, fu fatale un attimo di disattenzione.
Lo zio dormiva nella sua camera; durante la notte ebbe necessità del bagno; si alzò, convinto di stare nell'abitazione della Macchia del Conte, che aveva la porta d'ingresso in fondo al letto e si diresse fuori. Purtroppo in fondo al letto, nella nostra casa, c'era la finestra, con un parapetto basso. Lo zio precipitò nel cortile riportando serie ferite.
Fu immediatamente trasportato in ospedale dove, con piena lucidità mentale, dichiarò ai carabinieri cosa gli accadde, come e perché.
Furono giorni tremendi per tutti noi, lo zio Salvatore morì il 25 agosto, lasciando un grandissimo vuoto nella famiglia; fu sepolto a Viterbo dove, in sua memoria, è una lampada sempre accesa.
Dopo questo grave lutto, la vita riprese; Bruna ed io, pur sentendo la mancanza di zio Salvatore, che tutte le domeniche andavamo a trovare al Cimitero, con l'immancabile fiore, eravamo molto felici perché avevamo, con noi, nonni e zii materni, che ci stavano molto vicini.
Voglio, a questo punto, ricordare un episodio che spesso ha fatto sorridere tutti noi.
Bruna, aveva circa nove anni, cominciava a guardarsi, con interesse, allo specchio; un giorno mamma decise di portarla dal parrucchiere Giacinto, che aveva il negozio in via del Pavone, allo scopo di farle fare i riccioli a quei bellissimi "fili d'oro" che aveva.
Appena fatti i riccioli, che le davano un tono da signorina, Bruna manifestò il desiderio di farsi vedere dalla nonna Assunta e dalla zia Giuseppa, solo di tre anni più grande di lei.
Percorremmo un tratto di via Matteotti, poi piazza del Teatro e su per viale Raniero Capocci.
Man mano che ci avvicinavamo a via San Girolamo, che si trova all'interno di Porta della Verità, entrando sulla sinistra, Bruna aumentava il passo, desiderosa di farsi vedere. Giunti all'altezza della Croce con Gesù, quei bei riccioli cominciarono a scomparire, sino a che, quando giungemmo dalla nonna, Bruna, mio grande amore, non aveva più un ricciolo.
La mamma, con fare convinto, le disse: "Sei bellissima con i tuoi capelli naturali, con quei ricci mi sembravi una vecchietta".
Il sorriso tornò sul bel viso di Bruna che, soddisfatta, si guardò allo specchio e, con un gesto plateale si accarezzò, col pettine, quei bei capelli.
Tornerò, successivamente, sull'argomento: "salute del babbo".
Era quello il tempo in cui si cominciava a sentire, ogni tanto, il lacerante suono delle sirene che preannunciava l'inizio delle incursione aeree nemiche.
Il babbo diceva: "Noi corriamo maggior pericolo degli altri, per il fatto che abitiamo vicino all'aeroporto ed alle caserme, quindi è il caso di trasferire la famiglia, più lontano possibile, dall'aeroporto militare".
In quell'epoca zia Anna contrasse matrimonio con Vittorio Burla, l'elenco degli zii aumentò; era una persona tanto cara; ricordo che era un carpentiere; per regalo un giorno mi portò un banchetto di legno, fatto da lui.
Il babbo con la mamma, concordò la proposta e si mise alla ricerca di un luogo, dove c'era la possibilità di stare più sicuri e tranquilli. Le grotte, di proprietà dell'avvocato Felice Mignone, che si trovavano lungo la strada Sammartinese, entrando in un grosso cancello, sulla destra salendo, erano talmente solide, che si pensava potessero resistere ad un bombardamento aereo.
Il trasferimento era stato deciso e organizzato per l'indomani, infatti, i miei genitori prepararono tutto il necessario per iniziare una nuova vita.
Purtroppo la sera suonò l'allarme, noi, con le coperte sulle spalle, corremmo per mettersi al sicuro in un grande spiazzo, lontano dalle abitazioni, perché pensavamo che stare in una spianata deserta, poteva essere la salvezza, e così fu.
Le giornate, passate nelle grotte site sulla strada Sammartinese, le ricordo come se fossi stato in villeggiatura. Oltre la mia famiglia era con noi la famiglia dei nonni Cesare e Assunta, fra i quali zio Vittorio e zia Anna, che ivi dette alla luce Rossana.
Oltre a questi due nuclei familiari era anche il nucleo familiare del signori Franceschini, dei quali ricordo il nome dei figli: Andreina, Josè e Costantino
Le giornate trascorrevano con la paura nel cuore e negli occhi, con l'ansia di poter trovare un luogo più sicuro; visto che avevano bombardato l'aeroporto, e qualche bomba era caduta anche nelle vicinanze.
Il babbo non ci pensò due volte, appena capì che per noi tutti a Viterbo non c'era più sicurezza, decise di trasferirsi a Gubbio; come "sfollati di guerra".
Al mattino successivo ci recammo alla stazione ferroviaria di Porta Romana a Viterbo e, su un treno, che aveva tutti i sedili in legno, prendemmo posto e via verso l'Umbria.
Dopo un travagliato viaggio con forzate soste, causa il continuo sopraggiungere di mezzi militari, arrivammo alla stazione di Pietralunga, ai piedi del monte di "Pisciano" nella frazione di Camporeggiano dove era l'abitazione di zio Eugenio, zia Elisa ed il piccolo Luigi Matteacci, mio cugino, che aveva il padre, Tommaso, in guerra, di cui, da tempo, non si avevano notizie.
Ad attenderci erano gli zii e qualche componente la famiglia Terradura, mi pare che ci fosse Gelardo stesso e la figlia Teresa, amica di mamma.
Dopo i convenevoli saluti, iniziammo la salita verso la nostra nuova abitazione.
Appena percorsi pochi centinaia di metri, ci trovammo vicino alla prima abitazione, che era ed è, in prossimità della curva. Fummo invitati ad entrare in casa per poterci, temporaneamente, ristorare. Quello fu il primo, gradito, cenno di ospitalità umbra.
Salimmo le scale, entrammo e ricordo che vidi, sul focolare, una grossa padella piena di pezzi di ventresca, che stavano per "rosolare", in attesa di un buon numero di uova, il tutto pronto per diventare una succulenta frittata.
Mangiammo qualcosa, ringraziammo e riprendemmo, subito, il nostro andare.
Giunti a Pisciano, su un cucuzzolo era la casa degli zii, ci fu poco da vedere perché l'unica fonte di luce presente era il riverbero del fuoco del camino ed una "acetilena", accesa all'istante, che colpì la mia attenzione a causa della bianchissima luce che emetteva, accompagnata da un leggero fruscio.
La nostra nuova, temporanea, abitazione consisteva in una camera, cucina con sottostante la stalla dei buoi ed il pollaio. Nella immediata vicinanza, al di là della strada, era un'altra costruzione dove era una camera da letto, per zio Eugenio, un ampio locale adibito a granaio e, nei sottostanti locali, a piano terra, era l'ovile.
Oggi in quella casa è l'agriturismo "Le Cianciallegre", luogo che ancora vado spesso a rivedere e che, con tanta commozione, richiama alla mia mente bei momenti trascorsi con Bruna, Luigi, da ora in poi, scrivendo di lui, lo chiamerò "Gigino", perché, affettuosamente, così lo chiamavamo, e altre persone che ho amato e che resteranno sempre nel mio cuore.
Il periodo, di circa due anni, che ho trascorso a Pisciano, che ricordo come se fosse ieri, sarà oggetto di una narrazione particolare, collegata alle escursioni fatte con i miei cari, quando la loro presenza era per me come un viatico.
Altre visite, le ho successivamente fatte; con lo zio Adamo, zia Ida e zio Emilio ed anche con l'amico Domenico Biagioli e don Gianluca Scrimieri.
Da un poco di tempo in qua, la zona è stata resa vivibile dalla presenza delle suore della "Madonna del Deserto e di San Bruno"; fra loro la reverendissima suor Enosia.
Il convento delle suore, con chiesetta, e il Cimitero, dove è sepolta la piccola Nella, sono la forza traente per altre visite, che mi auguro poter fare ogni tanto, anche per onorare i miei genitori che, in quella chiesa, contrassero matrimonio l'8 febbraio 1930.
Ricordo la bella impressione che mi fece il molino ad acqua di proprietà di Gelardo. Trattasi di una costruzione, in pietra, fatta a castello, con una bella torre merlata dove, alla base, era ed è ancora, una macina di pietra, che ruotava su altra ruota, fissata alla base che, grazie alla forza dell'acqua in caduta, proveniente dal vicino laghetto artificiale, consentiva la molitura del grano. Era il molino presso il quale tutti i coloni della zona facevano riferimento.
Per arrivare a casa si doveva attraversare a guado il fiume, percorrere un lungo tratto di strada tutta in salita, usando la "treggia" dello zio, trainata da una coppia di buoi, di cui uno si chiamava Boccone.
La zona era collinosa e le strade esistenti erano solo quelle battute dal passaggio di persone e animali.
Quando pioveva, il terreno argilloso, diventava viscido e scivoloso quindi come mezzo di trasporto, usavano la treggia, che poi non è altro che una slitta, costruita con grossi tronchi, smussati davanti a mo' di sci, sui quali venivano fissati dei perni verticali ed orizzontali che erano la base sulle quali veniva poi adagiata la "ciovea", cioè un grosso paniere di vimini, intrecciati con bastoncini di legno.
L'uso della treggia era prettamente agricolo ed indispensabile, nel periodo invernale, specialmente quando faceva oltre un metro di neve; con tale mezzo agricolo si poteva andare anche attraverso i campi, dove non era presente nemmeno la minima traccia di strada.
Ricordo che la prima notte trascorsa a Pisciano, dormimmo molto poco, c'era tanto da raccontare, sia dall'una parte che dall'altra. Gli argomenti erano la guerra e lo zio Tommaso, che era sotto le armi e non si avevano sue notizie.
La nostra materiale sistemazione fu trovata facilmente; nella spaziosa cucina fu messo un grande letto. I miei genitori presero atto della funzionalità, o meno, della scuola, che si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa, a circa un chilometro di distanza dalla casa; ci misero a letto, invitandoci a dire, come di consueto, le preghiere.
Il risveglio fu al canto del gallo che, come detto, stava sotto le nostre camere.
Appena fu possibile spaziare in giro, con lo sguardo, mi affacciai dalla finestra, insieme a Bruna e Gigino e potemmo vedere, per la prima volta, le altre case della zona; a valle era la ferrovia, che costeggiava una bianca strada che conduceva a Gubbio. Sulla sinistra, era la casa di Cesare Ceccarelli, detto "Cecio", omonimo e cugino del mio nonno materno; più a destra si vedeva solo il tetto della casa di Nina Bregolisse.
Guardando dall'ingresso della casa, verso Levante, vidi la chiesa con il suo campanile, la scuola e l'abitazione dei cugini di mamma, i Minelli detti i "Gialvecchio".
E' una immagine sempre presente nei miei occhi, nel cuore e nella mente che, spesso, rinverdisco con visite in loco, anche se molto, moltissimo è cambiato.
Il fatto più grave e doloroso, purtroppo, è che sono rimasto solo a gioire e a piangere su questi ricordi.
Parlare, oggi di quei momenti, con chi non li ha vissuti, è come raccontare una favola; perché chi ascolta, vivendo in un mondo dove tutto é possibile avere e poco dare, mai potrà capire lo stato d'animo di quelle persone, che non sono più tra noi, o che oggi hanno i capelli bianchi.
Poco dopo il risveglio; facemmo colazione con il latte di pecora, munto dalla zia Elisa, mentre zio Eugenio accendeva il fuoco nel camino e babbo e mamma disfacevano le valigie, mettendo i nostri vestiti appesi nell'armadio.
Intanto bussarono alla porta, anche se prima sentii una voce che diceva: "Peppe di Moraola, finalmente sei arrivato!". Era un cuginello di mamma, Adriano Ceccarelli, che poi è stato, per tutto il tempo dello sfollamento, l'ombra di mio padre; erano sempre insieme. Ricordo l'affetto che ci dimostrò la gente della zona.
Per un motivo o per una certa parentela, che la si andava a cercare, magari nella "costola di Adamo", come diceva la mamma, tutti ci tenevano in particolare considerazione; quindi tutto era bello e festoso, perché così ci trattavano gli abitanti di Pisciano.
Un fatto che ha colpito la mia attenzione fu la grande nevicata che avvenne quell'anno; io pensavo che era una nevicata eccezionale, occasionale, invece anche altre volte di neve ne cadde in grande quantità.
Ricordo il silenzio del momento e il rumore che faceva la neve sotto i nostri passi; era musica era, per me e per Bruna, come vivere in un mondo di favola.
Dalla porta d'ingresso si vedevano i comignoli, fumanti, dei "Gialvecchio", della casa del parroco don Basilio, della scuola che stava immediatamente appresso alla chiesa e il comignolo della famiglia di "Cecio".
Affacciandosi, invece, dalla finestra della cucina, si vedevano il comignolo dei Bregolisse e solo il fumo degli Stacca, perché stavano al di là di una collinetta e altre case, tra le piantagioni, dalla parte opposta alla strada.
A fianco della casa era una "troscia"; così veniva chiamata una grossa pozza artificiale, fatta dall'uomo, che serviva per raccogliere l'acqua piovana che, a causa della impermeabilità del fondo argilloso, la tratteneva per molto tempo. Acqua che serviva per abbeverare gli animali e, a noi bambini, per giocare con la creta e la cenere del focolare.
C'è da ricordare, anche se non cronologicamente trascritto, che dopo esserci trasferiti a Viterbo, il babbo, ogni anno, ci portava a Gubbio in occasione delle feste pasquali o di Natale. Ricordo che alcuni viaggi li facemmo, in treno, con i signori Soderi, genitori del ginecologo Giuseppe, che abita a Viterbo, in via Monte Bianco; ottimo medico, degna persona, che all'epoca abitava a Perugia.
La vita, nella zona chiamata Pisciano, per Bruna e per me, incominciò ad essere vissuta con il far visita ai parenti che abitavano nelle vicinanze.
Trovammo persone, veramente magnifiche, bastava dire che erano i figli di Peppe di Moraola e di Maria d'Orcone che tutti gli abbracci erano per noi.
Era veramente un momento felice perché gli effetti della guerra erano lontani perché il fronte stava a sud di Montecassino.
I nostri genitori ci iscrissero alla scuola, che aveva soltanto un'aula funzionante comprendente, maschi e femmine che frequentavano le prime tre classi delle elementari, cioè la I, la II e la III perché, considerata l'età e il numero dei bambini presenti, la situazione era questa.
Per quanto riguardava mia sorella, si creò una situazione strana perché Bruna la III classe la stava facendo a Viterbo e a Pisciano la IV classe non c'era, quindi Bruna, nei nostri confronti era molto più avanti negli studi.
La maestra era la signorina Miranda Chigi, che veniva tutte le mattine da Gubbio, quando ritardava, eravamo intrattenuti e controllati da Bruna.
Ricordo che feci amicizia, insieme a Gigino, che aveva 18 mesi meno di me, con due bambine dei "Gialvecchio"; la più grande, Ines Minelli di otto anni e Nella Minelli di quasi sei anni, bambine che Gigino già conosceva.
Il punto in cui ci incontravamo era, sotto delle piante di salice piangente, in una valletta, tra la casa dei Gialvecchio e la casa degli zii.
Sentendo quello che dicevano i più grandi, tentammo di emularli: cogliemmo l'erba, chiamata "dell'amore", la masticammo un poco e la mettemmo su una coscia. C'era stato detto che, se dopo questa operazione, tolta la foglia e sulla coscia figurava una specie di fiore, la persona, per la quale si era fatta l'operazione, era innamorata. Se invece, dopo tolta la foglia, sulla parte appariva una "scottatura", voleva dire che la persona non era innamorata. E' facile pensare con quanta ansia noi quattro togliemmo, dalle nostre “coscette", la foglia semi-masticata.
Ci fu chi riportò un leggero rossore, che fu subito definito fiore, quindi amore; mentre altri ebbero una "scottatura" ed allora giù lacrime!
Con il crescere, venimmo a conoscenza che l'erba in questione era tossica e, il tenerla un poco di più a contatto della pelle, causava una scottatura.
Dopo oltre cinquant'anni ho avuto modo di rivedere la signora Ines, in presenza dei figli, con i quali sorridemmo nel ricordare il fatto.
Alla mattina si andava a scuola, mi sembra di ricordare che si entrava un poco più tardi di come si entrava a Viterbo, ciò per consentire a tutti i bambini di arrivare senza doversi alzare troppo presto, perché c'erano bambini che dovevano fare molta strada per giungere a scuola.
Ricordo che, quando nevicava, e di neve in detta zona ne cadeva qualche metro, il babbo faceva un camminamento spostando la neve ai lati della strada. Ognuno faceva il proprio pezzo fino alla strada centrale, poi, uniti nel lavoro, tutti insieme i famigliari degli alunni, proseguivano a spalare la neve fino alla scuola.
L'aula era grande, aveva tre file, ognuna composta di cinque banchi, per un totale di quindici banchi a due posti.
Ogni classe occupava una fila e l'insegnante era unica, per le tre classi.
La bontà della signorina Miranda era infinita. Tanto fu il mio dolore quando seppi che, a causa di un rastrellamento, fatto a Gubbio dai Tedeschi il 22 Giugno 1944, fu fucilata tra i "Quaranta martiri".
Del fattaccio, che umiliò Gubbio, ne farò oggetto di un particolare, dettagliato, racconto.
Tutto ciò che viene guardato con occhi di bambino è bello, tutto sembra una favola e, quando con gli occhi ormai stanchi, riguardi il passato, tutto è diverso!
Considerato che in quei luoghi ho trascorso bei momenti, con persone che non sono più tra noi, se non nel mio cuore, mi auguro che nulla sia dimenticato di quello che è stato!
Parlo di Bruna, mamma, babbo, zio Eugenio, Gigino, zia Elisa nonni materni, amici e conoscenti, che mi hanno voluto bene, che ho amato e che li ricorderò per sempre.
La guerra, anche a Pisciano, incominciava a farsi sentire, da lontano, durante una nottata illuminata solo dai bengala lanciati dagli aerei, vedemmo bombardare verso Perugia. Fu una visione allarmante.
Pochi giorni dopo bombardarono la ferrovia che si trovava nella valle sottostante; ricordo che colpirono anche una Littorina e distrussero, oltre che la ferrovia, anche la vicina strada, con i relativi ponti.
Il babbo, con una tagliente forbice per lamiera, si recò nel luogo dove erano i resti della Littorina e, con maestria, tagliò delle grosse strisce dalla fiancata della stessa che era di alluminio. In quell'occasione prese pure del piombo che era stato, a suo tempo utilizzato, per fissare i paletti di metallo, ai margini del ponte.
I miei genitori, quando ci trasferimmo a Pisciano avevano un rotolo di monete di carta che sentii valutare in lire centomila.
Erano momenti che non c'era lavoro per mio padre, se non la possibile riparazione di alcune paia di scarpe, di qualche vicino che, per pagamento, soleva dare generi alimentari, come conigli, polli e spesso anche formaggio pecorino, che le donne facevano in loco.
Il babbo, il tempo lo trascorreva andando a caccia o, come detto, facendo qualche lavoretto, oppure giocando a bocce con l'inseparabile amico, Adriano Ceccarelli.
I due, davanti alla casa, costruirono un campo da bocce. Usando il legno di una pianta di crognolo, a mano, a colpi di raspa, fecero otto bocce, con il relativo boccino.
Adriano, con il fratello Vittorio, le sorelle Italia e Ada e la madre lavoravano, con il padre Cesare, detto Cecio, un bel podere, che confinava con quello degli zii. L'altro figlio, Giulivo, era militare.
Considerato che il babbo aveva molto tempo a disposizione, e senza far nulla non ci sapeva stare, decise di utilizzare quei pezzi della Littorina che aveva portato a casa.
A colpi di martello ricavò, da una semplice lamina di alluminio, padelle, testi da forno, pettini e forchette.
Caro babbo eravate veramente ingegnoso; nell'arco della vostra vita ne avete date di dimostrazioni!
Come si può notare ai nostri genitori, Bruna ed io, nel rivolgersi a loro davamo del "voi". Una forma di rispetto, mai perduta.
In quell'epoca era proibito detenere armi da fuoco, il babbo, che era tanto affezionato alla sua doppietta, a cani esterni, calibro 16, la nascose sotto le tegole del tetto di casa, dove rimase per tutto il periodo della guerra. Oggi, quel fucile, regolarmente denuciato, è in mio possesso.
Il babbo, nel periodo invernale, quando la neve era alta oltre il metro, allo scopo di poter mangiare la carne, pensò di catturare la selvaggina, in particolare i tordi, visto che ce n'erano tanti. Il sistema per catturare quel volatile era quello del laccio.
Davanti a casa c'era una piccola spianata di terreno, il babbo vi tolse molta neve, fece dei piccoli corridoi con dei ramoscelli di ginepro mettendo, tra un ramo e l'altro, un bastoncino in verticale, con attaccato ad esso un laccio che doveva prendere prigioniero l'animale.
Il laccio era fatto con le setole della coda dei cavalli; in quella zona di cavalli ce n'erano pochi e quei pochi, con il consenso dei proprietari, furono quasi tutti, totalmente privati dalle setole della coda.
A Gubbio e in tutta la zona, non si usava mangiare il pane perché, giornalmente, le donne facevano la crescia o torta, come qualcuno la chiama ancora.
Sebbene la guerra, la fame non c'era perché i risultati, della cattura dei tordi, furono strabilianti.
Ogni giorno si catturavano un centinaio di tordi, dei quali i più grossi servivano per nostro cibo, mentre i più piccoli venivano barattati con i commercianti che ci davano olio, sale, carburo e petrolio per illuminazione e quanto non era possibile trovare nelle campagne.
C'era da considerare che, sebbene i miei genitori avessero una congrua somma di danaro che, a Viterbo, stava per essere utilizzata per acquistare due appartamenti, uno in via Santa Maria Elisabetta e l'altro in zona Pianoscarano, a Gubbio il danaro non aveva più valore a causa della guerra in atto.
Al ritorno a Viterbo a guerra finita, le due case, che dovevano essere acquistate dai miei genitori, erano solo due cumuli di macerie. Non tutti i mali, delle volte, vengono per nuocere, anche se per la ricostruzione di una casa venivano erogati contributi dallo Stato.
Cos'era ed è la crescia o torta? Proverò a spiegarlo.
Gli ingredienti necessari per fare la crescia sono: farina, acqua, un pizzico di bicarbonato, sale quanto basta, e delle buone mani per fare l'impasto. Il panaro, può essere di metallo, d'argilla o terracotta; è un oggetto simile ad un grosso coperchio, ha un manico nella parte opposta a dove si adagia l'impasto.
La crescia, ovviamente, deve essere grande come il panaro che, dopo essere stato ben scaldato sopra il fuoco, al bisogno, verrà collocato vicino alla fiamma. Sul panaro si adagerà la crescia per farla, leggermente, abbrustolire nel lato che è a contatto con il panaro stesso.
Una volta che il lato è leggermente cotto, la crescia si gira in modo che il lato semi-cotto sia nella parte superiore.
A questo punto la crescia; dopo avervi fatto, con la forchetta, dei buchi, si copre con cenere e carboni. Poco dopo è cotta, basta una bella spazzolata per togliere la cenere, che è rimasta attaccata e... buon appetito!
L'attesa sarà breve, tanto quanto serve ad accumulare altro appetito e, mi si creda, il mangiare crescia con tordi e starne è stato, per tanto tempo, una cosa magnifica!
Ricordo che i miei genitori erano riusciti ad acquistare, a borsa nera, un paio di prosciutti, ventresca, e del lardo; alimento, in quell'epoca, molto ricercato, stante il fatto che l'olio di oliva se ne trovava poco.
Il babbo tutta questa grazia di Dio la teneva nascosa in una grossa buca, fatta sull'aia e ricoperta con delle tavole, collegate tra loro, occultate con zolle di terra ed erba, allo scopo di sottrarla all'occhio indiscreto. La sera il tutto veniva portato dentro casa.
Ricordo che una sera, mentre stavamo sull'aia a parlare del più e del meno, giunse voce che stavano arrivando i Tedeschi. Fu un attimo di spavento. Gli uomini scapparono per nascondersi tra il grano, mentre le donne, con i propri figli, rincasarono e si misero a letto facendo, finta di dormire.
Mio padre non ci ha mai lasciato soli, eravamo sempre uniti, ci diceva: "nel bene o nel male stiamo tutti e quattro insieme". Il babbo praticò l'espediente del paralizzato. Costruì due stampelle, invecchiò il taglio del legno con del fuoco e, con le stampelle sotto le ascelle, faceva finta di essere paralizzato alle gambe.
Ad un certo momento, sentimmo parlare una lingua a noi sconosciuta, erano i Tedeschi accompagnati dalla signora Teresa di "Terradura" che, allo scopo di aiutare i paesani faceva da interprete.
Sentimmo bussare, con il calcio del moschetto, contro la porta; delle voci, a tono alto, dicevano non so cosa. La signora Teresa disse: "Aprite, non abbiate paura"!
La mamma aprì la porta. Per terra, sotto il tavolo della cucina, erano i prosciutti e quanto altro veniva nascosto di giorno nella buca, che faceva da ghiacciaia.
Il tedesco chiese un po' di luce, la mamma sfregava i fulminanti di legno, ma tutto rimase al buio, l'unica luce era quella che poteva irradiare la luna attraverso le finestre.
Ricordo che il letto cigolava perché, chi stava adagiato sopra, tremava come una foglia al vento.
Bruna, nonna Assunta, zia Elisa, Gigino ed io eravamo sul letto; mentre il babbo, nonno Cesare e zio Emilio, nella stanza adiacente, facevamo finta di dormire.
Zio Eugenio volle rimanere nella sua stanza, che si trovava nelle vicinanze, sopra all'ovile. Tutto andò liscio, ma la paura fu tanta.
Dopo pochi giorni, verso le ore dodici vedemmo, a valle, un lenzuolo steso sull'aia; voleva dire "pericolo, ci sono i Tedeschi". Fu subito steso un altro lenzuolo, verso il punto stabilito, il "passaparola" funzionò.
Pochi giorni dopo venne un gruppo di sei Tedeschi; quattro, con armi in pugno si piazzarono fuori la casa, uno si fermò sull'uscio; il sesto, che parlava un poco l'italiano, entrò in casa e disse di essere polacco.
Il babbo era a letto, perché finto malato, mentre Bruna ed io, seduti intorno al focolare, tentavamo di leggere un libro di scuola, Gigino stava in braccio alla madre mangiando un pezzo di crescia.
Chi stava in prima linea, era sempre la mamma, perché era spigliata e sapeva destreggiarsi, anche in momenti difficili come questi.
Il militare entrò e chiese i documenti del babbo il quale, prontamente, tentò di prendere il portafogli che aveva nella tasca posteriore dei pantaloni.
Visto che il babbo faceva fatica a muoversi, sebbene aiutato dalla mamma, il polacco estrasse dalla tasca dei pantaloni del babbo, il portafogli e gentilmente, lo dette in mano al babbo il quale lo aprì consegnando, al suo interlocutore, i richiesti documenti.
Dopo un fugace controllo, il polacco fece una carezza a me ed a Bruna, mentre Gigino si mise a piangere, poi uscì salutando. Appena fuori sparò, in aria, un razzo allo scopo di segnalare, agli altri plotoni, che l'abitazione era stata controllata e che tutto andava bene.
Ricordo che mamma disse: "Anche lui è un figlio di madre, che Dio lo aiuti; la guerra non l'ha voluta lui". Lo stesso giorno, sentimmo delle scariche di mitragliatrice che provenivano dal podere degli "Stacca", sito nella zona detta "dei calanchi", dove era molto brecciolino e la pietra si sfaldava facilmente sotto il peso di chi ci passava.
Gli spari erano diretti ad un gruppetto di tre o quattro giovani che non si erano fermati ad un controllo, noi vedemmo fuggire questi ragazzi, proprio nel momento che scollinavano.
Non è che una volta avuta la visita dei Tedeschi, si poteva stare tranquilli, il pericolo era all'ordine del giorno, anche se eravamo, come diceva il babbo, in una posizione tranquilla.
Giungevano notizie che in certi casolari i Tedeschi facevano incetta di vino e viveri vari e, in certe occasioni, uccidevano anche gli animali, in particolare i suini.
Zio Eugenio, che aveva nel magazzino una discreta quantità di vino, per uso della famiglia e per le sue sbicchierate, aveva paura che, con l'eventuale venuta di qualche plotone di Tedeschi, gli venisse sottratto il vino, come era capitato ai Guardabasso.
Lo zio decise di travasare il vino nelle bottiglie da un litro e nasconderle.
Stante la quantità del vino e la esigua disponibilità di bottiglie e di certi vasi di coccio, non sapeva dove travasare il resto del vino.
La soluzione, per lo zio, fu semplice; lo bevve e in quella eccessiva bevuta, coinvolse pure il piccolo Bruno, cioè io, che, dopo un paio di sorsate, si ubriacò.
L'onere più increscioso lo ebbe, non solo Bruno, ma pure la mamma che dovette assistere il figlio portandolo al fresco, lontano dalla casa dove potevano arrivare da un momento all'altro i Tedeschi e quindi capire e scoprire l'accaduto.
Tanti episodi affiorano alla mia mente, tutti sarebbero meritevoli di essere ricordati, ma, come in tutte le cose, c'è quella che primeggia sull'altra, quindi farò una cernita e racconterò quello che potrà far sorridere il lettore di questo povero, modesto, ma "vero" scritto.
Spesso si andava, con Bruna, a far visita ai parenti della zona, in particolare agli "Orcone" dei quali ricordo qualche nome: Asterio e Giuseppe. Quest'ultimo, quasi coetaneo di Bruna, un giorno mi portò in giro per una macchia, a basso fusto, allo scopo di farmi vedere i nidi degli uccelli.
Fu una scoperta che colpì la mia attenzione; vedemmo una decina di nidi di vari uccelli, fra i quali uno su cui il "cucco" aveva gettato via un uovo e lo aveva sostituito con il proprio; ricordo che l'uovo del cucco è bianco con delle macchie nere.
Io avevo trovato un nido, in prossimità del "Poggetto", vicino alla casa dove abitavamo.
Un pomeriggio, mentre la mamma e Bruna erano andate a prendere l'acqua, che scaturiva da una parete di creta, nella valle del "Buzzacchero", io ne combinai una delle mie.
Feci un giro nella zona dove Giuseppe degli "Orcone" mi aveva fatto vedere i nidi; di soppiatto tolsi da ogni nido due o tre uova e, dopo averne presi una dozzina, li andai a depositare nel mio nido del "Poggetto".
S'immagini la temporanea allegria di Bruno che, al sol pensare di avere un nido, nel quale sarebbero nati una quindicina di uccelli, di varia razza, lo faceva impazzire di gioia.
Dopo qualche giorno la realtà fu atroce; mentre nelle vicinanze, si sentiva cantare gli uccellini, da poco nati, corsi al "Poggetto" per prendere i miei, ma ahimé, trovai solo un ammasso di cocce d'uovo che puzzava e basta.
Mi misi a piangere e raccontai tutto al babbo che, sempre tanto caro, nella giornata riuscì prendere un uccello detto "cucco", perché quando canta fa: "cu, cu cu".
I miei genitori furono molto contenti perché dissero: "Che era sparito il sorriso dal mio volto". Mettemmo il cucco in una spaziosa gabbia di legno, fatta dal babbo; io mi sentii un signore!
Di birbonate ne ho combinate! Ricordo che un giorno, il babbo doveva portare al molino del signor Gelardo, una certa quantità di grano da molire, per ricavarne dell'ottima farina per uso famigliare.
Prese una coppia di buoi, fra i quali Boccone, li attaccò alla treggia dove, sopra la "ciovea", oltre il grano era anche Bruno.
Giunti che fummo al mulino, il signor Gelardo predispose il tutto per una normale molitura, poi si mise a parlare con il babbo, passeggiando lungo il fiume, al di sotto del mulino.
Io, che ero rimasto vicino al mulino a guardare le variopinte anatre, che scorrazzavano con le oche, fui attratto dal rumore della macina; mi avvicinai e imprudentemente, toccai una leva di legno che combinò il guaio.
Il signor Gelardo, che stava a valle con il babbo, vide che il letto del fiume si era ingrossato perché arrivava una grande quantità di acqua.
Con l'aver mosso quella leva avevo aperto la chiusa e quindi avevo fatto alzare la macina dalla base, causando la sola spaccatura del seme di grano e non la normale molitura. Gelardo con una corsa, da podista, riuscì a minimizzare il danno: serrò la chiusa, raccolse il grano spaccato rimettendolo in molitura, come se nulla fosse accaduto.
Il babbo non disse nulla, anche se avrei gradito un ceffone piuttosto che vedere il suo volto, molto rattristato.
In epoca del Carnevale, se non vado errato, il martedì grasso, era usanza andare a "Cicattolo". Noi maschietti, ci vestivamo con abiti da donna, e le bambine da uomo, si teneva in mano uno spiedo di legno e si faceva il giro dei casolari gridando: "cicolo, cicolo"
Le famiglie, che avevano la visita, regalavano ai "cicattolari" pezzi di carne di maiale, ottima per fare la padellata, stante il fatto che erano varie qualità e vari pezzi di maiale.
In quella giornata ci si incontrava con altri ragazzi; Bruna ed io eravamo orgogliosi perché avevamo lo spiedo più pieno degli altri.
Alla sera si rincasava e le donne cucinavano; chi passava, davanti a casa in gruppo, mascherati o in solitario, se gradiva, poteva entrare e mangiare.
Era una gran festa; come pure era una festa quando si mieteva e si trebbiava il grano.
A Gubbio, quando mietevano, il grano lo tagliavano a mano, con la falcetta a raso terra perché c'era l'esigenza di avere molta paglia; mentre nel Viterbese, il grano veniva mietuto a taglio alto.
Il giorno della trebbiatura, o battitura, come veniva detta a Gubbio, era una gran festa,. Nel 1943 l'usanza era come quella della battitura del 1930, quando mamma entrò nella famiglia dei "Moraola".
Il babbo soleva dire: "Dalle nostre parti, quando c'è la battitura si mangiano tutto il ricavato del raccolto". Quell'anno, pochi giorni prima della battitura, la mamma si ammalò e il babbo fu costretto a ricoverarla all'Ospedale di Monte luce, a Perugia.
Noi figli rimanemmo a casa con gli zii.
Il giorno della battitura portarono la trebbia, il motore a vapore e la pressa per la paglia, tutti i mezzi erano trainati dai buoi.
Fu istallata la trebbiatrice, ad una consistente distanza fu piazzato il motore che, tramite lunghe cinghie, metteva in movimento la trebbiatrice stessa.
Il motore si metteva molto lontano dal posto dove si lavorava il grano, allo scopo di evitare eventuali incendi perché, lo stesso, era alimentato dal vapore prodotto da una caldaia, piena d'acqua, alimentata a fuoco.
La mano d'opera era a scambio, chi veniva a lavorare aveva poi il diritto di essere aiutato da chi aveva già ricevuto la prestazione.
Io avevo tanta voglia di essere parte attiva nella trebbiatura; chiesi a zio Eugenio cosa potevo fare e questi, senza pensarci due volte, mi mise a spalare la “pula".
Si trattava di stare nella parte dove esce la pula, che, poi, non è altro che il guscio del chicco del grano.
Di polvere ce n'era tanta, infatti, quello era il peggior punto esistente nel lavoro della battitura.
Durante la fase del pranzo, ricordo che io avevo il cucco, legato in una zampetta, che volteggiava sopra la mia testa ed ogni tanto si posava sulla mia spalla.
Ad un certo momento, tra la confusione, la cordicella mi sfuggì dalla mano e il cucco volò via andando a fermarsi a pochi metri dall'aia, sopra una piccola pianta di quercia.
Io mi misi a piangere e gridando, verso lo zio Eugenio, gli chiesi di andare a riprendermi il cucco, perché una estremità della corda si era, a mio parere, impigliata nel ramo della pianta.
Lo zio non fu sollecito a fare quanto sperato; con la flemma che lo distingueva, si avvicinò alla piccola pianta e, in quell'attimo, il cucco volò via. E' immaginabile il mio stato di frustrazione.
Terminato il pranzo, al suono della sirena, tutti ci mettemmo al nostro posto di lavoro, io, stordito dal dispiacere per aver perduto il mio uccellino, mi rimisi alla pula.
Non trascorse tanto tempo che, da Perugia, sopraggiunse mio padre, il quale si inquietò moltissimo, con suo fratello Eugenio, per avere consentito che io lavorassi e poi in quel punto così disagiato.
Ricordo che il babbo, mi prese in braccio, ero tutto impolverato, si avvicinò ad una bacinella e mi lavò il viso che era però già bagnato dal pianto, per non avere più il mio cucco.
Il babbo quel giorno fu doppiamente addolorato, aveva la moglie all'ospedale e i figli abbandonati; perché non gradì, minimamente, quello che accadde.
La mattina successiva il babbo si alzò, come di consueto, molto presto perché doveva andare a Perugia dalla mamma.
Uscito da casa sentì cantare il cucco, fece pochi passi verso il luogo da cui proveniva il verso cu cu e vide, sopra una pianta di cerro, l'uccellino; gli tirò una sassata con la speranza di vederlo bloccato dalla cordicella che avrebbe dovuto avere nella zampetta, ma fu invano, il cucco volò su una pianta vicina.
Il babbo non si diede per vinto, continuò a tirare sassi e a corrergli dietro, in tutti i suoi spostamenti, fino a quando con una sassata, più mirata delle altre, riuscì a colpire il cucco che cadde, poverino, tramortito.
Si può immaginare la gioia del babbo; corse a casa, mi svegliò e mi dette il cucco.
Dopo qualche giorno mamma, guarita, ritornò a casa; fu una grande festa che, purtroppo, durò poco.
Da Viterbo giunse la notizia che avevano bombardato la Località Occhi Bianchi, dove avevamo lasciato i nostri mobili con quanto non fu possibile portare a Pisciano. Fu detto, ai miei genitori, che c'era la quasi certezza che gli "sciacalli" avrebbero rubato quanto poteva essere recuperabile da sotto le macerie.
Il babbo e la mamma non se lo fecero ripetere due volte; ci affidarono alla nonna Assunta e, in bicicletta, partirono per Viterbo.
La drammaticità del viaggio era dipinta nei volti dei miei genitori; sapevano di dover fare, in piena estate, con la sola forza della volontà, un viaggio di 220 chilometri, tanta era la distanza Gubbio Viterbo.
Dopo un grande sforzo, mamma e babbo, percorrendo la Strada Teverina, giunsero a Viterbo; le prime immagini furono terrificanti; a Porta Fiorentina, si resero conto di quello che era accaduto a Viterbo e quale grosso pericolo erano riusciti ad evitare, sfollando a Gubbio.
Arrivare agli Occhi Bianchi fu un attimo, appena giunti videro che la nostra casa era senza tetto, una parete era stata abbattuta e per salire c'erano difficoltà, per il fatto che la scalinata era pericolante.
I miei genitori fecero un'accanita ricerca per trovare un mezzo adatto a trasportare quello che fu possibile recuperare sotto le macerie. Ricordo che i miei dissero di aver trovato, sotto le macerie, ancora funzionante, la sveglia; quel diabolico strumento che tutte le mattine rompeva le scatole alle ore 6,45 e che continuò, ancora per molti anni, a farci sentire quel drin drin che divenne, poi, molto, molto famigliare.
I miei genitori trasportarono quanto recuperato in via San Girolamo, nell'appartamento che i nonni tenevano a disposizione, in attesa di prendere definitive e concrete decisioni.
Adempiuto quanto si erano prefissi, mamma e babbo si misero nuovamente in viaggio verso Gubbio, ripercorrendo la Strada Teverina, in direzione di Orvieto e su, poi, verso Gubbio.
Era una giornata maledettamente calda; mamma era stata, da poco tempo, dimessa dall'ospedale. La fatica, per giungere a Viterbo, fu massacrante; quando furono all'altezza del bivio per Fastello, la mamma crollò. Aveva oltre 40 di febbre.
Altro, sovrumano, sforzo e giunsero a Fastello, dove la mamma fu ospitata da una famiglia, della quale non ricordo il nome, ma che ringrazio, pregando Dio che possa avere salute e bene.
Il babbo ritornò a Viterbo con lo scopo di trovare le medicine e un'automobile per portare mamma in ospedale.
Ogni ricerca fu vana, il babbo mi disse, che andò pure dal vescovo per chiedere l'uso dell'auto.
Il vescovo accompagnando il babbo verso la scalinata della sua residenza, gli disse: "La macchina e là, il problema è farla camminare, come potrà esservi utile se tutto intorno è un cumulo di macerie?". Lo scoraggiamento stava per prendere mio padre, causa il pensiero per la moglie, che era gravemente malata, perché colpita da insolazione.
A Porta Fiorentina erano le truppe americane, o alleati degli Americani, presso i quali il babbo fu avviato, con lo scopo di farsi dare la penicillina. Avuta questa strana e nuova medicina il babbo, sempre in bicicletta, raggiunse la mamma a Fastello, facendole subito l'iniezione.
Soltanto alla terza iniezione videro che la temperatura scendeva; ne doveva fare altre tre e, secondo quello che prevedeva colui che consigliò tale prodotto, tutto si sarebbe normalizzato.
La forte fibra di mamma, le cure del babbo, la bontà dei zabaioni e il desiderio di ritornare a Pisciano, dai figli, contribuirono a far sì che dopo pochi giorni, i miei genitori poterono riabbracciare i loro Bruna e Bruno. Ricordo che, la sera, quando ritornarono, lasciarono, come di consueto, le biciclette da Gelardo e giunsero a casa: il babbo a piedi e la mamma, seduta sopra una cavalla. La nottata fu trascorsa, prima al lume di acetilene, poi al bagliore del cammino acceso e alla luce di un lume a petrolio.
Sembrava festa, tutto era illuminato, ma la luce più grande, più importante, più calorosa era quella che irradiavano i miei genitori che, per circa dieci giorni, furono sottratti all'affetto dei figli, correndo immani pericoli.
Mamma diceva che, durante il periodo, che sono stati lontano da noi, solo la preghiera era la forza che spingeva le gambe a far girare le ruote della bicicletta, senza poi pensare alla preoccupazione, che regnava nei loro cuori, dal momento che erano impossibilitati a muoversi, perché lei era allettata.
Gli zii avevano un esiguo numero di pecore che, qualche volta, Gigino ed io accompagnavamo in un praticello nelle vicinanze di casa;. Dovevamo fare attenzione che non pascolassero in un determinato campo, seminato ad erba medica.
Gigino ed io pensavamo solo a giocare e di nascosto degli zii andavamo a cavallo sulle povere pecore, divertendoci un mondo. Il nostro divertimento, però, ci fece disattendere l'ordine datoci, tanto che qualche pecora, sconfinò andando a brucare l'erba medica. Il risultato fu immediato; la pancia delle pecore, che avevano mangiato quell'erba, si gonfiò così tanto che rimasero in terra a zampe all'aria.
Gigino ed io non ci rendemmo conto della gravità della situazione e, a colpi di frustino e con ordini perentori, spingemmo le pecore verso l'abitazione, lasciandone due a zampe all'aria.
Giunti a casa, ci vennero incontro zia Elisa e la mamma alle quali dicemmo: "Due pecore si sono messe a dormire, a zampe all'aria, perché hanno mangiato tanto e hanno la trippa piena".
Fu sufficiente, per zia Elisa, sentir dire: "zampe all'aria e trippa piena" che intuì la verità.
La cosa che ci stupì fu l'accettazione, silenziosa, del fatto.
Intervenne subito, mio padre che, dopo aver abbattuto le due pecore, le scuoiò, e avvisato Adriano e la famiglia dei romani, fra i quali Bruno, provvide a consegnare alle donne tutta la carne mangiabile che, dopo averla leggermente bollita in acqua e vino, venne cucinata sulla brace.
Con tanto appetito, all'aperto, sull'aia davanti casa, mangiammo il tutto.
Il fatto delle pecore, non fu la sola birbonata che combinammo, altre ce ne furono, come quella del cane e le galline.
Avevamo veduto che zia Elisa, tutte i giorni, andava nel pollaio e ritornava, in casa, con le uova.
Gigino ed io pensammo di anticipare la zia nella visita alle galline; di soppiatto entrammo nel pollaio, prelevammo due uova, ne bevemmo uno ciascuno, lasciando per terra il guscio schiacciato, in modo da far credere che il furto lo aveva compiuto Lilla, la cagna dei Cecio.
Al ritorno dai campi, la zia provvide a prelevare le uova, visto che in terra c'erano le cocce “d'ovo”, come diceva lei, ci domandò se avevamo veduto, la Lilla gironzolare intorno al pollaio. Gigino ed io rispondemmo affermativamente.
Da quel giorno la povera, innocente cagna, venne tenuta lontana da casa e, se necessario, prendeva pure qualche calcio, mentre io e Gigino, continuavamo a bere un uovo, se non due, al giorno.
Intanto il fronte della guerra avanzava; i Tedeschi avevano occupato Gubbio, la loro prepotenza la manifestavano ovunque con abusi, razzie e nel caso specifico di Gubbio, con la fucilazione dei Quaranta Martiri, avvenuta il 22 Luglio 1944.
Narrare il fatto è pietoso; ma per onorare, ancora una volta, quei morti, mi soffermerò, con cuore addolorato, perché ricordare quei momenti vissuti, più volte sentiti raccontare dagli anziani, fa veramente male e spinge l'animo a odiare un popolo, per colpa di un "esaltato".
Una sera, in un locale pubblico di Gubbio, erano dei militari tedeschi, al comando dei quali era un ufficiale. Un tizio esplose dei colpi di pistola contro il gruppetto, uccidendo due Tedeschi e ferendo l'ufficiale.
La reazione dei Tedeschi, fu immediata e violenta, fu fatto un rastrellamento in tutto il territorio eugubino con il conseguente eccidio, che gettò nel lutto e nel pianto il caro operoso popolo eugubino.
Il babbo, quel giorno stava andando in bicicletta a Gubbio per gli acquisti e per il baratto di starne con altri prodotti necessari alla famiglia.
Giunto alla Mocaiana, venne a conoscenza di quanto stava accadendo a Gubbio; senza esitare un attimo ritornò, subito, a casa. Cosa stava accadendo a Gubbio?
I Tedeschi, in massa, prendevano come prigionieri le persone che incontravano per strada; in altri casi andavano nelle abitazioni a prelevare cittadini che, probabilmente, erano stati segnalati come persone contro il regime. Presero, come ostaggi, tra donne e uomini di ogni età, ottanta persone fra le quali la mia maestra, signorina Miranda Chigi e la sua mamma.
Mi raccontarono che la maestra stava in casa con la madre ed il fratello, quando bussarono alla porta; dall'interno, dalla "parlata", capirono che fuori erano i Tedeschi. Il signor Chigi stava pulendo la rivoltella; appena comprese che correva pericolo, attraverso un abbaino, fuggì sui tetti vicini, sottraendosi all'arresto da parte dei Tedeschi che abbatterono la porta proprio nell'attimo in cui la maestra occultava, nel proprio petto, la rivoltella che era rimasta sul tavolo, ma fu vista e, insieme alla madre, fu presa come ostaggio.
Mentre il gruppo di Eugubini, inquadrato, veniva condotto verso la stazione, uno di quei sfortunati paesani, convinto che andava a lavorare, passando davanti alla propria abitazione, chiamò la moglie chiedendole la giubba.
Fatto un breve percorso di qualche centinaia di metri, gli ottanta sfortunati Eugubini vennero divisi in due gruppi; quaranta furono accantonati in un lato, mentre gli altri quaranta ricevettero l'ordine di scavare una lunga buca, non tanto profonda.
Terminato l'ingrato compito i quaranta furono fatti allontanare di pochi metri, poi i Tedeschi piazzarono la micidiale mitragliatrice e, con ripetute scariche, spararono contro gli altri quaranta, fra i quali era la maestra Chigi.
Le grida dei poveri martiri, che per primi, vennero colpiti alle gambe, furono sentite nella zona, poi altri colpi li raggiunsero in altre parti del corpo, fino a quando quelle povere creature, prive di vita, caddero in terra.
Altri, ancora vivi, ma gravemente feriti furono, parzialmente, coperti con la terra. Si vedeva, in qualche punto, qualche mano che fuoriusciva dalla terra e che muoveva le dita.
Con un secco comando fu ordinato ai superstiti di coprire, con la terra, quei corpi mutilati e sfregiati. Gubbio, "Città martire", intese onorare i suoi caduti costruendo un mausoleo nello stesso punto dove avvenne l'eccidio; dove furono sepolti, sulla nuda terra e dove, successivamente, a riesumazione avvenuta, furono sepolti in appositi loculi.
In memoria di questo tremendo giorno Gubbio ha intitolato la piazza più grande, quella delle "Logge", ai "Quaranta martiri". Il popolo di Gubbio risentì, tremendamente quello che accadde!
Mentre gli Americani avanzavano, i Tedeschi indietreggiarono oltre il Monte Ingino.
La vita, a Gubbio, giorno per giorno, cambiava in meglio.
Ricordo che gli Americani mangiavano un pane bianchissimo, contrariamente ai Tedeschi che mangiavano un pane nerissimo.
A proposito di pane e di crescia alimento, quest'ultimo, essenziale a Gubbio, è il “brustengo", piatto semplice, saporito e facile a prepararsi che, in certe circostanze, può sostituire il pane, come ieri, 9 settembre 2005, che ne ero sprovvisto e una cara persona, mi ha ricordato l'esistenza dello stesso.
Gli ingredienti sono: farina, acqua, olio e sale q.b, un pochino di ventresca e cipolla. Si fa una pastella mentre in una adeguata padella si cuoce, con poco olio, cipolla e ventresca. Quando il tutto è ben rosolato, si deve versare la pastella, lasciarla cuocere da un lato, poi rivoltarla e... buon appetito, bollente è... speciale.
Lasciata la casa degli zii a Pisciano, il babbo trovò un appartamento proprio al centro di Gubbio, più precisamente andammo ad abitare in prossimità del Palazzo dei Consoli; avevamo la finestra che si affacciava proprio verso Piazza Grande.
Veramente mi sarei dovuto soffermare ancora per parlare di quando stavo a Pisciano, ma a chi leggerà, forse, poco può interessare il fatto che io abbia frequentato parte della terza elementare a Pisciano e i rimanenti mesi a Gubbio, in una scuola che, sinceramente, non ha lasciato alcun segno nella mia giovane mente. Certo è che abitavamo a Gubbio in via dei Consoli, dove ricordo era una fontana che, mi sembra si chiamasse del “Conte Budello". Le giornate a Gubbio erano d'attesa perché ci si augurava di essere rimpatriati, quanto prima, e tornare a Viterbo.
Intanto, giunse notizia che, a Viterbo avevano bombardato anche in via San Girolamo, dove era la casa dei nonni, e dove i miei genitori avevano trasportato quanto recuperato sotto le macerie agli Occhi Bianchi.
Babbo e mamma, sebbene molto stanchi, partirono nuovamente in bicicletta, con il cuore in mano, destinazione Viterbo, in via San Girolamo, dove ripresero quanto avevano, a suo tempo, depositato per riportare tutto nella nostra abitazione, appunto, agli Occhi Bianchi, dove avevano rifatto il tetto e ridata una sistemata allo stabile.
I giorni di attesa del loro ritorno furono brevi, la loro mancanza la sentimmo tremendamente, sebbene l'affetto dei nonni e degli zii fosse immenso.
Del periodo di permanenza a Gubbio ricordo qualche serata trascorsa al Luna park, dove erano molti Americani.
La mia attenzione fu colpita dalla presenza di un bambino di Gubbio, che parlava in inglese ed era utilizzato come interprete nel Luna park in cambio della facoltà di andare sulle automobiline senza pagare.
Ricordo che quel bambino, più o meno della mia stessa età, mi chiese di salire con lui sulle automobiline per trascorrere qualche minuto insieme, ricordo che mi chiamava: Bruno il romano, perché Viterbo lo conosceva come città vicino a Roma.
Mi viene in mente e lo racconto, quanto un giorno mamma ha materialmente vissuto in compagnia di nonna Assunta.
Era una di quelle mattine insignificanti, ma per nonna Assunta, nonno Cesare e zii, erano momenti tristi per il fatto che, quanto prima, saremmo ritornati a Viterbo; mentre loro sarebbero rimasti a Gubbio, per la precisione in Piazza San Giovanni n. 6.
Quella mattina, mamma e nonna, mentre camminavano, vicino all'Ospedale di Gubbio, sentirono una forte esplosione, così forte, che lo spostamento d'aria gettò mamma da un lato e la nonna fu gettata contro il muro della Chiesa di San Francesco.
Fu un momento tremendo; tra le grida della gente, la polvere e i pezzi di carne umana sbattuti in vari punti del giardino pubblico e sui fili della luce; videro una bicicletta nera che credettero essere di zio Dante, mentre lo zio non si vedeva.
E' tristemente immaginabile cosa pensarono mamma e nonna che gridò: "Dio mio Dante"; per fortuna a zio Dante non capitò nulla. Non era lui quello della bicicletta nera.
In questa circostanza morirono solo un paio di prigionieri, mi sembra fossero della provincia di Roma. Che cosa era successo? I Tedeschi stavano partendo da Gubbio, perché pressati dai cannoneggiamenti e dall'avanzata degli Americani.
Sul ciglio del giardino pubblico era una bomba, inesplosa, sparata dagli Americani, che presero il nome di liberatori. Avuto sentore della presenza della bomba inesplosa, promisero la libertà, a tre Italiani che avevano trattenuto per motivi a me sconosciuti, chiedendo, come prezzo della libertà, che disinnescassero la bomba.
Due, dei tre romani, accettarono la proposta, mentre il terzo disse: "meglio vivo e prigioniero, che libero e morto". I due si misero al lavoro; con il picchio colpirono, accidentalmente il detonatore della bomba che esplose, travolgendoli, uccidendoli.
Dopo pochi giorni, ci vedemmo apparire a casa lo zio Tommaso, che da tempo era dato per morto o disperso in guerra, sulla base di quanto riferì un commilitone che, a suo tempo, passò da casa degli zii a Pisciano.
E' indescrivibile la gioia provata in quell'attimo, stavamo attendendo che ci chiamassero per prendere, in giornata, il posto su un camion per partire verso il Lazio.
Il babbo mi, mandò a comperare un boccione di vino di quello buono, mi dette i soldi ed io mi precipitai lungo via dei Consoli per andare a Piazza San Martino, per adempiere a quanto richiesto dal babbo, che era nella impossibilità di offrire qualcosa allo zio, perché era tutto impacchettato per la partenza.
Lungo il mio andare, camminavo sul lato sinistro della via, direzione San Martino, tenendo, nella mano destra il boccione, quando un'autovettura nera con i parafanghi verniciati di bianco, proveniente da dietro, colpì la mia mano facendomi cadere il boccione. Fu tutto in un attimo, la macchina continuò il suo percorso mentre io, mi misi a correre, come un ossesso, fino a che riuscii a mettere un piede sul predellino della macchina e, attaccatomi al finestrino, gridai di fermarsi.
L'autovettura si fermò mentre io, energicamente, rivendicai il pagamento del boccione, che fu subito soddisfatto dal conducente dell'auto, senza alcuna esitazione; anzi mi disse: "Bravo, ti chiedo scusa e tieni il resto".
C'è da evidenziare, che in quell'epoca, un boccione di vetro aveva il suo valore perché, in commercio, non se ne trovavano, come pure non si trovavano le stoviglie.
Ricordo che c'era gente che andava nelle discariche degli Americani a prendere i secchi già usati, che avevano contenuto farina lattea o altro.
Andai alla fiaschetteria, comprai il vino, di quello buono, come voleva il babbo e ritornai, con tanta soddisfazione, a casa dove attendevano il mio ritorno per brindare con lo zio Tommaso.
Consegnai al babbo il boccione di vino, con tanto di targhetta, detti anche le monete, che avevo avuto da quel signore, spiegando al babbo, tutto l'accaduto.
Ricordo che il babbo e la mamma furono contenti della conclusione del fatto, pur provando, come dicevano, un brivido nel pensare alla dinamica dell'incidente e a quello che sarebbe potuto accadere, sia nel momento della collisione che quando pazzamente, dicevano, corsi e salii sul predellino dell'automobile.
Tutto è bello quando la cosa finisce bene!
Quel giorno finì lo sfollamento, poco dopo, tra le lacrime dei nonni, degli zii e di noi tutti, partimmo dalla Piazza delle Logge, davanti al monumento ai Caduti.
Lo stesso giorno fummo tutti felici anche per l'inaspettato ritorno dello zio Tommaso e lo scampato pericolo, corso da me.
Il viaggio di ritorno, in compagnia di altri sfollati, fu fatto dentro il cassone di un camion, con le gomme piene, parzialmente coperto da un tendone.
Di polvere ne mangiammo tanta, perché le strade erano bianche, prive d'asfalto e, spesso, si doveva passare per strade di campagna, perché i ponti erano stati distrutti.
Giunti a Civita Castellana, noi dovemmo scendere, perché il camion era diretto a Roma, per trasportare sfollati romani.
Da Civita Castellana, non ricordo come giungemmo a Viterbo, certo è che ritornammo ad abitare agli Occhi Bianchi, nello stesso appartamento che occupavamo prima della guerra, con i vecchi mobili che, ancora facevano il loro dovere, come la sveglia, che continuò a segnare il tempo, ancora per molti anni, fino a quando, io abile nello smontare un oggetto, ma incerto nel rimontarlo, la ruppi per sempre, sveglia che sopportò un bombardamento, ma non il "bombardamento" di Bruno.
Giorni senza dubbio migliori di quelli trascorsi che comunque, grazie ai miei genitori, sono stati meno duri di quanto potevano essere e di come sono stati per tanti bambini meno fortunati di noi.
Il cammino della vita, dai miei genitori, fu affrontato con grandi vedute e tanta volontà, allo scopo di poter assicurare a tutti un futuro migliore.
Presero atto che a Viterbo non si trovava, a sufficienza, il vitto, perché c'era ancora l'ombra della guerra e se ne sentiva la conseguenza in tutti i settori.
Babbo e mamma acquistarono a Tre Croci, frazione di Vetralla, un maiale vivo e passo, passo, lo portarono fino a Viterbo dove lo fecero abbattere dal norcino Grazini, detto "Cencino della Dinde", che abitava in un casolare, di colore rosso, sito sulla destra del Vicoletto, che inizia agli Occhi Bianchi.
Grazie ai sacrifici ed al lavoro dei miei genitori, non abbiamo mai sentito il morso della fame e con serenità, era necessario dimenticare e riprendere il ritmo della vita.
Come prima cosa si doveva pensare alla iscrizione scolastica di Bruna e mia nelle rispettive classi.
Poiché si abitava sulla Strada Tuscanese n.7, la zona di competenza, per la frequenza, era la Scuola elementare "Edmondo De Amicis", meglio conosciuta come "Le Monachelle", perché in detto stabile, a suo tempo, erano le monache dell'Assunta.
Bruna fu iscritta alla classe V elementare della quale era insegnante la signora Lucia Tota Cherubini, che è stata, veramente una madre, pur non avendo figli.
Io fui iscritto alla IV elementare nella stessa scuola di Bruna. Il mio insegnante era, il maestro Peleo Caporossi, originario di Ischia di Castro in cui, a suo tempo, fu pure sindaco. Il maestro Caporossi è il nonno dell'amico Massimo Caporossi, già titolare della concessionaria FIAT ed amministratore della Società Igino Garbini.
Ricordo, con sommo piacere, i miei compagni di scuola per i quali dopo cinquant'anni, dalla data della licenza elementare, il 15 maggio 1997 ho organizzato un incontro conviviale, nel ristorante Biscetti di Bagnaia, incontro che ha avuto vasta eco e del quale parlerò quando sarò giunto, con il mio scritto, al 1997.
Gli alunni della IV e la V classe erano: Mario Barbini, Giuseppe Bernabei, Domenico Bernardini, Domenico Biagioli, Cesare Bruno, Marcello Calevi, Gabriele Capparelli, Sante Carrer, Giovanni Durante, Franco Faggian, Francesco Fiorentini, Giulio Fratini, Mario Gasbarro, Franco Giammarioli, Luigi Gobattoni, Vitaliano Ippolitoni, Orlando Lucaccioni, Giuseppe Marini, Pietro Marini, io Bruno Matteacci, Franco Mecarini (Carlino), Domenico Menghini, Franco Pinzi, Igino Rampolli, Eraldo Stramaccioni, Felice Vestri, Raffaele Zuccarini. Con tutti ho mantenuto ottimi rapporti e, per Bruno, Gasbarro, Fratini, Giammarioli, Zuccarini, che sono in cielo, ho pregato e pregherò.
Lo spostamento da casa per recarsi a scuola non ebbe mutamenti se non il fatto che la strada era più asfaltata e le auto in transito erano aumentate.
A scuola, sia io che Bruna, trovammo un poco di difficoltà perché l'insegnamento, a Viterbo, era più intenso, perché ogni insegnante doveva far lezione ad una sola classe e si poteva quindi dedicare, alla stessa, tutta la mattinata, mentre a Pisciano l'insegnante, anche se impagabile, doveva, nell'arco della mattinata seguire tre classi.
Ricordo che la zona di Porta Fiorentina, Piazza della Rocca e zone limitrofe erano totalmente distrutte dai bombardamenti, era una scena veramente impressionante. La miseria del vegetare, più che vivere, delle persone era un pianto. C'erano molte persone che si recavano, con un secchiello in mano, in un locale del Buon Pastore, dietro il Teatro Genio, in cui veniva dato loro il vitto, che alcuni chiamavano "la bobba".
Lungo il Corso Italia, all' altezza del Largo Cesare Battisti, era una interruzione dovuta alle macerie che ostacolavano pure la circolazione pedonale.
Stati di disagio si provavano in vari punti della città, sia sotto l'aspetto del traffico, che per procurarsi il vitto; il denaro non aveva più il suo valore nominale, era in voga la famosa "am lira" in poche parole l'Italia era in ginocchio; si sentiva ancora l'eco del referendum per la Repubblica, molto era cambiato al governo, ma poco o nulla era cambiato nella politica locale.
A Viterbo era forte l'immobilismo voluto da chi aveva interessi contro l'urbanizzazione perché, per alcuni, era una grossa perdita economica vedere le forze lavorative, in agricoltura, che abbandonavano i campi e che, magari, rivendicavano la terra con la famosa frase: "la terra a chi la lavora!”.
Il babbo ha sempre preteso che noi si studiasse tutti i giorni e non accettava che si dicesse: "Abbiamo fatto i compiti". Giustamente il babbo ci spronava verso il meglio e diceva che "sapere qualcosa di più, non fa mai male". Bruna ed io, tutti i giorni, per attestare che studiavamo, sui nostri quaderni mettevamo la data del giorno.
Il babbo e la mamma si misero alla ricerca di un locale dove poter aprire a Viterbo un laboratorio artigianale di calzolaio. Dopo poco tempo trovarono un locale, in via della Pace n.73 che, poi, per esigenze comunali della toponomastica, è stato cambiato con il numero civico 81.
Il locale, che fu preso in locazione, era di proprietà di un vero gentiluomo che, con il tempo, divenne amico del babbo. Intanto il sogno del babbo, stava per avverarsi!
Il signor Consalvo Delle Monache, detto "Farinella", era il proprietario dello stabile, che aveva l'accesso da Piazza Luigi Concetti, e di tutti i locali, a piano terra con il fronte su via della Pace, dove aveva la stalla che ospitava il suo cavallo bianco e nero, che utilizzava per trainare una biga a due posti.
Nell'immediata vicinanza era pure la stalla del signor Cenciarini, padre del geometra Giuseppe con il quale, nel tempo, divenni amico.
Qualche ferro e qualche altro attrezzo, necessario per svolgere l'attività, il babbo l'aveva, ma tanto materiale rimase sotto i bombardamenti come le forme per fare scarpe su misura, la macchina per cucire, la macchinetta per allargare le scarpe e tante altre che, seppur modeste attrezzature, erano necessarie per lavorare.
Iniziò a cercare qualcosa, come le forme di varie misure, che trovò a Ronciglione, dove si recò con la mamma per acquistare molti attrezzi, nuovi e usati.
In quell'occasione acquistarono anche circa due quintali di suola in "gropponi".
Per lavorare il babbo aveva necessità di una mola per rifinire i lavori, ma non fu possibile trovarla.
Con il suo ingegno, che lo ha sempre contraddistinto, prese una vecchia bicicletta l'attaccò, con le staffe, alla parete della bottega e, con un certo gioco di pulegge e cinghie, riuscì ad avere la mola a pedale; molto più utile di una elettrica che girava sempre allo stesso ritmo, mentre lui, quella che aveva costruito da solo, la poteva comandare come voleva: più lenta o più veloce, secondo le necessità.
Dopo anni però, con il progresso, si adeguò acquistando una bellissima macchina da cucire a cannone e a piano; un motore, a varie velocità, con tutti i tipi di spazzole, necessarie per ripulire e rifinire le scarpe riparate.
L'ingegno dell'artigiano Giuseppe Matteacci, nonché mio padre, fu tanto che si costruì certi attrezzi idonei e necessari per effettuare determinati lavori.
Appena finita la guerra, per la carenza di animali e quindi di suola, misero in commercio le scarpe con il fondo di "para", nient'altro che un derivato di una qualità di caucciù naturale o gomma elastica che conteneva meno del 2% di resine e sostanze minerali.
Una volta rotta la para, la scarpa veniva buttata perché, nessuno era in grado di ripararla.
Mio padre, non ci dormiva la notte per pensare come si poteva fare per rimediare a tale rottura finché, prova e riprova, riuscì a trovare il modo per far saldare le parti rotte.
Conosciuta la combinazione della para, il babbo aveva intuito che riscaldando con la mola le due parti rotte e riaccostandole quando erano ancora bollenti e tenendole, per un attimo, sotto pressione, le stesse si saldavano e non si sarebbero più separate.
Per molto tempo fece questa prestazione per i propri clienti, che aumentavano numerosi, mentre gli altri colleghi tentavano di carpirgli il segreto.
Addirittura ci furono anche dei vulcanizzatori che provarono a riparare le scarpe, senza ottenere la perfezione che raggiunse mio padre. Solo dopo tanto tempo a qualcuno, che andava a trovarlo per imparare il mestiere, svelò il segreto, che per molto tempo lo inorgoglì.
A volte c'erano persone che si lamentavano del fatto che i figli giocando consumavano le scarpe; il babbo diceva loro: "Ringraziate Iddio che i vostri figli rompono le scarpe, vuol dire che stanno in salute, stanno peggio quelli che non le consumano".
Era un discorso saggio come quando non voleva che io litigassi, mi diceva: "Se hai qualche problema con qualche coetaneo, non devi litigare, vieni da me e mi dici cosa è successo, io ne parlerò con i genitori, i quali prenderanno poi i dovuti provvedimenti nei confronti dei propri figli".
La teoria era bella, ma io non condividevo ciò che chiedeva mio padre, perché mi sentivo come se fossi impedito a tutelare la mia persona quindi, quando ritenevo di essere nel giusto e c'era da menare le mani, menavo, perché non mi sarei mai accontentato di prendere una sberla e vedere colui, che me l'aveva data, passarsela con un semplice rimbrotto.
Dopo qualche anno i miei genitori acquistarono, dal signor Consalvo Delle Monache, il locale dove il babbo svolgeva la propria attività artigianale. Quello fu il primo traguardo che il babbo e la mamma volevano raggiungere.
In quel locale mio padre ha lavorato fino al mese di agosto 1976, data che ha segnato la mia vita per la improvvisa ed inaspettata sua dipartita.
Mio padre non ha mai acquistato la suola tanto quanta poteva servire per qualche paio di scarpe, lui aveva preso l'abitudine di comprare all'ingrosso il materiale che gli serviva; in poche parole di suola ne comprava tre o quattro quintali alla volta, come pure i tacchi e quant'altro gli serviva per lavorare. Era un lavoratore instancabile, mi raccontava che spesso, a seguito degli energici colpi che dava sulle piante delle scarpe, gli si rompeva il manico del martello, che era di legno.
Un giorno decise di fare il manico con un tubo di ferro, quindi era bello resistente; soddisfatto del risultato lanciò una sfida, come dire: "Vediamo se adesso ti rompi, penso che, questa volta, durerai più di me".
Purtroppo è stato così, il manico del martello, anche se qualche volta lo uso io, durerà, durerà nell'eternità, quasi come voler testimoniare di essere stato il mezzo con il quale il babbo ha lavorato per tanti, tantissimi anni.
Ricordo che un noto personaggio viterbese aveva un figlio di pochi anni, con un difetto ad un piede e si trovava in difficoltà nel fargli indossare un paio di scarpe.
Il più noto commerciante di calzature di Viterbo, il signor Mario Rossini, titolare del negozio in via Matteotti, venuto a conoscenza di tale problema, ne parlò a mio padre che si dichiarò disponibile a servire la persona segnalata.
Quel signore contattò mio padre e gli chiese di recarsi a vedere, in via riservata, i piedi del figlio, il babbo accettò. Visto il caso il babbo, nel rassicurare quel signore, prese le misure e in pochi giorni, gli confezionò un paio di scarpe ortopediche.
Per anni quel signore, prima, e il figlio poi, sono stati clienti di mio padre, il quale sempre, con la stessa riservatezza, di quando era bambino, lo ha servito mettendolo in condizioni di non essere claudicante, tanto perfetto era il supporto che il babbo applicava alla scarpa del piede informe.
Un giorno il babbo mi chiese di scrivergli una targa con la seguente dicitura: "Calzolaio Giuseppe Matteacci - Tel. 341587 - Si riparano borse e scarpe di para".
Misi tutto il mio impegno e la mia bravura, se bravura avevo, allo scopo di fare un bel lavoro.
Presi un pannello di faesite, lo annerii con la vernice e scrissi quanto desiderato con pennarello bianco e bordino rosso.
La targa ancora la custodisco gelosamente nel mio garage dove ho ancora la poltroncina di lavoro di mio padre e gli attrezzi che usava, oltre a molti tacchi di gomma.
Dopo che il babbo ci ha lasciato ebbi necessità di fare i tacchi alle mie scarpe e a quelle di mamma; andare da un calzolaio, per far fare il lavoro, mi sembrava non giusto; allora, con tanto dolore e con le mani tremanti, mi chiusi nel laboratorio artigianale del babbo e, tra sospiri e lacrime, riuscii a fare un bel lavoro, sulla base di quanto, per quarant'anni, avevo veduto fare dalle esperte mani di mio padre.
Una sera andai nella bottega, con mamma e Bruna, con lo scopo di fare qualche lavoretto per casa e per far prendere un poco d'aria al locale dove erano accatastate oltre venti gropponi di suola e oltre tremila paia di tacchi di gomma, e tanto altro materiale che, successivamente, vendemmo al signor Michelangelo Cannatà, amico e fornitore del babbo.
Tanto altro materiale lo vendemmo ad un ex agente di custodia che, essendo andato in pensione, si orientò su questo lavoro.
Una coincidenza che mi ha commosso è stata quella di aver venduto la macchina da cucire "a piano e a cannone", ad un calzolaio umbro, mi sembra che sia del paese chiamato Calzolaio, che si trova nelle vicinanze di Trestina, paese dove è il Santuario della Madonna di Canoscio, della quale babbo e mamma erano molti devoti. Devozione che mi hanno tramandato, come un loro personale dono.
Onoro questo dono andando spesso a pregare in questo magnifico santuario che si trova in una posizione favolosa, sopra una collina, dove tutto è "amore, pace, silenzio e invito alla preghiera".
A proposito di Canoscio voglio raccontare quanto mi disse mia madre riguardo ad una sua amica.
Erano entrambe giovanissime, fecero un discorso macabro di questo tenore: "Facciamo alla conta per vedere chi di noi due muore prima?". Fecero la conta e, dal conteggio, risultò che sarebbe deceduta, per prima, l'amica di mamma.
La cosa rimase nel silenzio perché era un discorso tra due bambine che all'indomani sarebbe stato dimenticato. Ma non fu così, passarono gli anni e l'amica di mamma si ammalò gravemente.
Soffriva tanto, sino al punto che questa "creatura" si recava, spesso, al Santuario della Madonna del Transito, a Canoscio, mettendosi a pregare seduta sul primo banco, della fila sinistra, davanti all'ambone, sull'estremità di destra.
Tra le sue ferventi preghiere c'era una richiesta accorata ed era quella di voler morire, perché non sopportava più il lancinante dolore che l'assillava giorno e notte.
Mi è stato detto che quell'amica di mamma fu trovata morta in quell'angolo del banco della prima fila.
Di questo fatto ne parlai al carissimo monsignore Cesare Pazzagli, rettore della Basilica dell'Immacolata Assunta in Cielo di Canoscio.
In questo Santuario lo zio Eugenio, in occasione della festa dell'Assunta del 15 agosto, ci andava tutti gli anni; anche quando abitava a Viterbo.
Anche il babbo e la mamma non mancavano di fare il loro pellegrinaggio in quel sacro luogo, cosa che io continuo a fare e sarebbe per me cosa molto gradita se i miei figli, nel tempo, continuassero anche saltuariamente, ad inginocchiarsi davanti alla sacra immagine della Madonna, presso la quale, a suo tempo, in un momento di dolore, Le chiesi "aiuto".
Aiuto che mi fu dato e di ciò non finirò mai di dire: "Grazie Madre Santa, Grazie!".
L'attività artigianale, di calzolaio, di mio padre Giuseppe, successivamente chiamato "maestro", ebbe inizio, con tanta gioia di tutti!
Il babbo aveva già qualche cliente nella zona dove abitavamo, ma la mira era di avere come clienti, non solo coloro che abitavano nelle vicinanze. C'era da tenere conto che nelle vicinanze erano altri calzolai: in via Mazzini erano tre, in piazza Crispi era uno, in piazza Fontana Grande ce ne era un altro.
Per fare la clientela, l'unica pubblicità valida era, come diceva il babbo: "lavorare bene, usare materiale buono, essere puntale e praticare prezzi buoni".
Il babbo praticò questi criteri, ma ne pretese uno che in un primo momento lasciò la clientela sbalordita, poi questa si adeguò ed apprezzò quanto il babbo pretendeva.
Mio padre non accettava scarpe se non ben pulite e, in certi casi, con una spolverata di borotalco all'interno delle stesse, perché lui le restituiva lucide che brillavano ed il lavoro era fatto talmente bene che non era possibile vedere, nel caso di una solatura, il punto di congiunzione tra il nuovo ed il vecchio.
Il primo paio di scarpe nuove le volle fare per me; ricordo che erano di vacchetta, erano un paio di scarpe che mi consentivano di fare l'esibizionista, infatti, le tenevo sempre lucide e, quando stavo a scuola, spesso tenevo il piede in modo che si vedesse la scarpa. Ero orgoglioso di avere un babbo come il mio.
Non da meno il babbo trattò mia sorella Bruna, alla quale confezionò un paio di sandali, con un tacco leggermente più alto del normale, cosa che fece tanto piacere a Bruna, che già aveva l'atteggiamento di una signorinella!
Del periodo che abitammo agli Occhi Bianchi voglio ricordare un episodio che ebbe come attori, Renato e Marcello Feliziani e me.
Si era nel mese in cui l'uva mostra il suo bel colore giallo e nero ed è in attesa di essere colta per fare il buon vino.
Lungo la strada Tuscanese era un continuo passare di militari che, dalla caserma si recavano in città, passando proprio a pochi centimetri dalla rete che divideva la vigna del signor Flavio dalla strada.
Da qualcuno ci venne richiesto un grappolo di uva; noi, con piacere, assecondammo la richiesta.
Visto, poi, che la stessa richiesta ci veniva fatta molto spesso, pensammo che fosse giusto farci pagare, anche con poche lire, la prestazione che ci chiedevano.
Decidemmo di vendere l'uva. Veramente facemmo un buon affare, perché a tarda ora dividemmo in tre l'incasso. Non tenemmo però in considerazione che il conto finale lo dovevamo fare con il signor Flavio che, ritornando a casa da Viterbo, incontrò molti militari con il grappolo di uva in mano che, chicco dopo chicco, lo mangiavano.
Flavio giunse all'altezza del luogo dove stavamo vendendo l'uva e, senza dire nulla, incominciò a picchiare i propri figli, non disdegnandomi di qualche minaccia, che demandava per l'esecuzione a mio padre, nel momento in cui lo avrebbe veduto.
Io, non è che me la passai molto bene, ma il tempo aveva sopito il tutto e con una bella ramanzina fui liquidato. Avrei, però, preferito uno o due scappellotti, alla lungaggine dei rimproveri!
La mamma intese dare un aiuto economico alla famiglia. Si ripartiva da zero, le esigenze della casa erano tante; sia ben chiaro non che si facesse il lusso, ma un vestito con le pezze non lo abbiamo mai indossato, come pure un pezzo di carne lo abbiamo sempre mangiato.
I miei genitori chiesero al Comune di Viterbo la licenza ambulante per la vendita, al minuto, di frutta e verdura, licenza che fu loro concessa.
Il punto in cui decisero di svolgere l'attività commerciale fu quello di piazza Verdi, meglio conosciuta come piazza del Teatro, più precisamente davanti al palazzo Santoro, sul marciapiedi, sotto a dei pini. Oggi, il luogo dove stava la mamma è l'edicola dei giornali.
Il punto di appoggio delle cassette e dei plateau, contenenti le varie specie di frutta, era un robusto carrettino, con due stanghe molto lunghe e due ruote che poggiavano su un forte assale.
Alla sera, terminata l'attività commerciale della mamma, si accatastava tutto sul carrettino e, spingendolo, ci si trasferiva in via della Pace n. 73, nella bottega dove lavorava il babbo.
Si scaricava tutta la merce invenduta e, per evitare che rubassero il carrettino, lo si metteva dentro alla bottega, dopo avergli tolto le ruote, sollevandolo di fianco, con tanto sforzo dei nostri genitori e di noi figli.
La mamma era una commerciante nata, sia per come conduceva le trattative per gli acquisti, che per come teneva i rapporti con i clienti e grazie a lei aumentavano sempre di più, con buoni incassi giornalieri.
Non da meno era il babbo con la sua attività, anche se c'era il solito male di stomaco che, da tempo gli logorava il fisico. La mamma non era al massimo della salute; soffriva di claustrofobia che contrasse durante i bombardamenti, mentre il reumatismo si era impossessato del suo fisico, a causa del tanto lavoro sostenuto nel passato.
I miei genitori affrontarono una spesa non indifferente per acquistare un chiosco con tre ruote, delle quali due davanti ed una, snodabile, dietro.
Il chiosco consentiva, durante la vendita, di stare all'interno dello stesso; quindi si era protetti dagli agenti atmosferici, non dico totalmente, ma molto ci si riparava.
In parole povere il chiosco era come una casetta di circa sei metri quadrati; aveva un lato che si apriva con un grande sportello che diventava il tetto e che copriva la merce esposta.
In un lato era la porta d'accesso dello stesso, dove potevano sostare, comodamente, anche tre o quattro persone; nella parte davanti alla porta, era una grande finestra. Alla sera, dentro al chiosco, dopo chiuso lo sportello, si collocavano tutte le cassette che servivano per conservare ed esporre la frutta.
La situazione era migliorata sebbene il chiosco lo si doveva togliere dalla piazza; a tale proposito i miei genitori presero, in affitto, un magazzino in via del Pavone, a fianco delle "Monachelle". Tutte le sere, noi quattro sapevamo che dovevamo fare quella faticaccia spingendo, con tutte le nostre forze, il chiosco fino al magazzino.
La parte che aveva una sola ruota snodabile la tenevamo dietro e il tutto si guidava agendo sullo snodo della stessa.
Lasciato il chiosco, soddisfatti, si rientrava a casa in attesa di un meritato riposo, per ripartire l'indomani mattina per fare il percorso al contrario.
Prima si portava in loco il chiosco, poi si doveva andare ai magazzini generali: in piazza Santa Maria Nuova da Uvio Goletti; in via Fattungheri da Fonti; in piazza San Pellegrino da Leo Piacentini, prima, e Gino Risi poi.
Noi figli, nel nostro piccolo, abbiamo sempre aiutato i genitori i quali, spesso, mettevano in risalto il nostro aiuto.
Intanto Bruna ed io frequentavamo le rispettive classi con discreti risultati, anche se il nostro pensiero non era sempre dedicato allo studio, forse per il fatto che la giornata la trascorrevamo quasi sempre soli.
Bruna, essendo la maggiore di età, ebbe l'ordine di potermi comandare per fare quanto lei avrebbe richiesto, nell'interesse mio e della casa.
Qualche volta litigavamo ed io, "carogna" prendevo il sopravvento su di lei che, sottostava alla mia affettuosa prepotenza. Ricordo che qualche volta mi faceva i compiti, mentre io, magari, stavo a giocare. Bruna mia eri veramente cara!.
Un giorno, che non dimenticherò mai, accadde che stavo nel cortile a giocare con gli amici, Bruna stava a casa perché, oltre che fare la scolara, faceva anche le faccende domestiche, sì perché Bruna è nata donna di casa.
Quel giorno il babbo, per un normale controllo, o per qualche motivo che non ricordo, venne a casa, trovò Bruna che stava studiando, le domandò dove io fossi.
Bruna, dolce come sempre disse: "Bruno è sceso proprio adesso", anche se non era vero, lei ha sempre avuto, nei miei, confronti lo spirito di protezione!
Il babbo le disse: "chiamalo". Bruna si affacciò alla finestra e con voce sommessa chiamò due volte: "Brunooo... Brunoooo.".
Io dal cortile feci un gesto con la mano, come per dire: "aspetta... aspetta".
Il richiamo, da parte di Bruna, fu ripetuto per due o tre volte, come, per due o tre volte, risposi con il gesto della mano. A quel punto sentii sibilare nell'aria il fischio del babbo, molto noto a noi di famiglia. Nelle mie vene ci fu una gelata di sangue, corsi verso casa, immaginando cosa mi stava per capitare, avendo disubbidito a mia sorella.
Giunto che fui, con la lingua fuori per la corsa fatta, il babbo mi disse: "riprendi fiato"; io pensai: "me la sono passata liscia". Non fu così a fiato ripreso e dopo aver bevuto un goccio d'acqua, mi giunse una sberla, che mi fece fischiare l'orecchio, con di seguito la frase: "E' così che ubbidisci a tua sorella?".
Voglio ricordare, forse, l'ultimo episodio che accadde agli Occhi Bianchi, prima della Santa Pasqua.
Era tradizione, che quando passava il prete per benedire le famiglie, si facesse benedire anche un congruo numero di uova, di gallina, che dovevano servire per la colazione pasquale.
Mamma, come sua abitudine, acquistò una ventina di uova, fresche, che mise in un bacile, in attesa che venisse, don Otello Ferrazzani, il nostro parroco.
Giunto il giorno della venuta di don Otello, che benedì l'appartamento, la mamma sollevò, con tanta, troppa facilità, il bacile contenente le venti uova, ma si accorse che c'era qualcosa che non andava bene. Le uova erano tutte vuote e alcune, tra loro, erano attaccate a causa della fuoriuscita del tuorlo. Cosa era successo?
Io, uno o due al giorno, dopo aver fatto con l'ago un forellino all'uovo, bevvi tutte le uova. Il vizio non lo avevo perduto: l'uovo era uno dei miei cibi preferiti!
Non sto qui a raccontare la disperazione di mia madre, la quale si trovava in difficoltà a reperire altre uova, stante la grande richiesta che c'era e la poca produzione; comunque, anche quell'anno, grazie alla mamma, facemmo colazione con le uova benedette, colorate a mano da noi figli.
Lungo il Corso Italia era la macelleria del carissimo signor Alicandro Vergati, nella quale lavorava Momo, un signore alto, di poche parole, ma molto cortese, che quando passava in piazza del Teatro, oggi piazza Verdi, la mamma gli ordinava, sempre, la carne; in particolare costarelle di maiale e corata; salvo per la domenica, ricordo che chiedeva, quattro belle bistecche e a volte anche di carne da brodo.
Mamma, al signor Momo, dava spesso, in omaggio, una busta piena di frutta perché ci sentivamo privilegiati in un momento di carestia, anche perché per gli acquisti, si doveva fare una lunga fila.
Anche nel negozio della Cooperativa del Popolo, in piazza del Teatro, dove oggi è la latteria, la situazione non cambiava. Ricordo che tale attività era gestita, sotto l'ottimo controllo amministrativo, del signor Alberto Jacchia, con la materiale collaborazione lavorativa di Osvaldo, Reno e di un terzo dipendente, del quale non ricordo il nome.
Tutto procedeva per il meglio, ma era sempre presente il problema della salute del babbo, mi sembra ancora di vederlo ritornare, verso il chiosco, proveniente dal Corso Italia, appena sbucava da via Mazzini, in un atteggiamento sofferente, curvo in avanti che lamentandosi si adagiava sul pavimento del chiosco.
Il babbo era in cura dal dottor Vespasiano Bottoni, con studio medico sopra il locale della Cooperativa del Popolo, davanti al chiosco di mamma.
La diagnosi, sullo stato di salute del babbo, per anni fu dubbia, fino a quando il carissimo, ottimo, dottor Renato Quadrani, con studio radiologico, in via fratelli Rosselli, prese a cuore il caso, sostenendo che, per lui, non era un "K", come si dubitava, ma un grosso problema allo stomaco, per la precisione disse che si trattava di ulcera duodenale e che solo un'operazione chirurgica avrebbe potuto risolvere il problema.
Bruna preparava il pranzo; prima mangiavamo noi, poi lo portavo alla mamma e al babbo, facendo poi ritorno a piazza del Teatro, dove mi incontravo con gli amici: Marcello Biagi, purtroppo da poco deceduto; ottimo amico, atleta e persona molto umana, Vinicio Colonna, carissimo amico, il quale lo chiamavo; "Oiciniv Ottorocub", mentre lui mi chiamava: "Onurb Ottorocub"; Luigi Gobattoni, sempre amico e grande cicloamatore, Franco e Luciano Zaffamenti, non da meno degli altri; tutti abitanti in via San Marco.
Ricordo quanti “Giri d'Italia” e quanti “Tours de France” abbiamo fatto, sulla scalinata della Chiesa di San Marco, quando parroco era il caro don Fiorino Cesarini, dottore in Teologia. Ricordo che, con a capo Vinicio Colonna, formammo anche una "banda" che chiamammo "Le léopard fantome" (il leopardo fantasma).
La domenica si andava al Cinema Corso, i miei genitori mi davano la "pagaccetta" di lire 200, che era più che sufficiente per pagare il biglietto per il cinema, dal costo di 60 lire e lire 50 per la pizza napoletana; ricordo che un supplì costava 10 lire, alimenti che mangiavamo nella pizzeria sita all'inizio di via Mazzini, angolo Corso Italia.
Bruna aveva le sue amiche, con le quali tutte le sere faceva una passeggiatina per il Corso, nei punti che era ancora transitabile, dopo i bombardamenti.
Intanto il ricordo della guerra, per noi bambini, si affievoliva; avevamo un futuro che ci aspettava, un presente da vivere ed un passato da dimenticare!
Terminata la scuola elementare, mi trovai davanti ad un bivio. Il babbo non stava bene in salute, non mi potevo permettere di prendere una strada scolastica lunga.
Era necessario fare presto e bene, cioè prendere un indirizzo scolastico allo scopo di avere un "pezzo di carta", come diceva il babbo, e la possibilità di guadagnare un boccone di pane.
Questo era il pensiero dei miei genitori che, dopo aver fatto le dovute valutazioni, ritenemmo giusto concretizzare con la mia iscrizione alla prima classe della Scuola di Avviamento Professionale Commerciale "Francesco Orioli", con sede in via Emilio Bianchi.
Era una scuola, nella quale si studiavano tante materie, utili nella vita; erano tre anni di Avviamento poi, dopo un esame, si accedeva alla frequenza della Scuola Tecnica Commerciale, che aveva due classi; al termine delle quali veniva rilasciato il diploma di "Computista commerciale".
Era poco, ma chi aveva questo diploma sapeva, più o meno, quanto un ragioniere.
In questa scuola le materie di studio erano: italiano, storia, geografia, matematica, scienze, chimica, merceologia, computisteria, ragioneria, tecnica bancaria, francese, inglese, musica, istituzione di diritto, disegno, calligrafia, stenografia, dattilografia, religione, educazione fisica.
Delle predette materie, prima della frequenza della prima Tecnica, alcune si lasciavano, come: dattilografia, calligrafia, musica e disegno, mentre altre si approfondivano, come ragioneria, inglese, matematica ed italiano.
Nel primo anno di Avviamento ero veramente bravo, ricordo che mi fu assegnata la borsa di studio in danaro, come primo della classe; l'anno successivo ebbi nuovamente detto riconoscimento, solo che fui il secondo; mentre alla fine del terzo Avviamento, ebbi sì la borsa di studio, ma arrivai terzo.
Nell'aria c'era qualcosa che mi distraeva; la mia attenzione era molto, molto attratta dalle grazie di qualche compagna di scuola; comunque i miei genitori, per premio della promozione, mi mandarono in villeggiatura a Gubbio, dalla nonna Assunta dove, tra l'affetto di tutti, trascorsi giornate stupende, da non dimenticare.
Intanto le condizioni di salute del babbo precipitarono, si dovette far operare allo stomaco. Questo triste avvenimento sarà, in seguito, oggetto di particolare narrazione.
Tre anni passarono veloci, sostenni felicemente gli esami e fui ammesso alla frequenza della prima Tecnica Commerciale.
Quell'anno fui il miglior atleta della scuola, ebbi un riconoscimento con una medaglia; la mia specialità era il lancio del giavellotto e i millecinquecento metri di corsa campestre. Tra l'attività ginnica e le distrazioni sentimentali non è che andassi molto bene nel profitto scolastico.
La mamma venne a parlare con i professori, i quali consigliarono un sostegno con qualche ripetizione. Fui mandato a lezione dalla professoressa Palmira Cuccioli che abitava in via del Teatro Nuovo n.1, ultimo piano; era veramente un genio; era in grado di insegnare qualsiasi materia, da quelle letterarie, straniere, alla matematica ed alla ragioneria; in poche parole non c'era argomento che lei non conoscesse.
In quel periodo venivano a scuola, dalla signorina Cuccioli, molti ragazzi, fra i quali ricordo: Laura Bertarelli, Antonietta Giovannelli, Fracassini, Mamerto Sambuco, Nando Gibellini, Torquati e persone, già adulte che, per mantenere il proprio impiego, avevano necessità di un titolo di studio che, a causa della guerra, non avevano conseguito.
Quando terminò l'anno scolastico, fui rimandato a settembre in sette materie, sebbene avessi fatto qualche ripetizione; si calcoli che, in quella scuola si dovevano studiare diciassette materie.
Andai a casa e dissi ai miei genitori che ero stato rimandato in due materie; così facendo il dolore dei miei cari lo avevo, un poco, alleviato.
Babbo e mamma decisero, comunque, di mandarmi, più spesso a ripetizione rimproverandomi per il fatto che precedentemente sostenevo di non averne bisogno. Studiavo come un matto, il perché lo sapevo io. Però il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, questo era un detto che mi è stato fatale.
La mattina del mese di settembre, giornata in cui iniziavano gli esami di riparazione la mamma, che lavorava in piazza del Teatro, incontrò la professoressa Aurelia Scoppola, di San Martino al Cimino che scendeva dall'autobus, per recarsi a scuola.
La tanto cara signorina Scoppola, che insegnava italiano, salutò la mamma dicendole: "Quel birbone di Bruno si è preparato bene?". La mamma la rassicurò dicendole: "Per le due materie che ha, secondo me, ha studiato pure troppo". La signorina, soggiunse: "Due materie? Ma ne ha sette!”.
Fra le due sorse un dubbio, si recarono a scuola ed accertarono che quello che diceva la professoressa era vangelo. L'avevo commessa grossa, ma a fin di bene, perché comprendevo i sacrifici dei miei e non meritavano tale risultato scolastico, quindi falsai il tutto, dicendo due materie.
La mamma non mi disse nulla, previdente del fatto che dovevo sostenere gli esami. Tutto andò per il meglio, fui promosso e fui, pure; capito dalla mamma e dal babbo.
Mi sembra, più che doveroso, ricordare i miei professori, sperando di non dimenticarne nessuno. Inizio, alla rinfusa dal primo Avviamento: preside Oliviero Casanova; Gaetano Mazzeri, Silvana e Giuseppe Mazzeri, calligrafia; Antonio Javarone, disegno; Vera Pastori, musica; Manetti, dattilografia; Anna Rita Meschini, Antonino La Novara, Emilia Del Gaudio, Antonella Bonavia, francese; Michele Lo Monaco, computisteria e tecnica bancaria; Eraldo Arciola, Emilio Innocenzi, matematica; Orazio Puletti, Rosetta Guastini, Trento Grani, Rossana Fiorucci, Ferdinando Montemari ragioneria; Pietro Geronzi, inglese; Aurelia Scoppola, Marcella Bruno, Francesco Galamini, Agata Sorbello, Luigia Donati italiano-storia; Cesare Stramaccioni, Paolo Capoccetti, Carlo Di Carlo, educazione fisica; don Serafino Pierotti, monsignor Salvatore Del Ciuco, monsignor Carbone, religione. Di tutti questi insegnanti serbo un vivo ricordo e gratitudine per avermi sopportato.
Loro hanno sempre apprezzato la mia amicizia, che ancora, quando ci si vede la rinfreschiamo, con reciproco affetto.
Per esigenze comunali, con il chiosco per la vendita della frutta, fummo costretti a trasferirci, in altro luogo; noi andammo in piazza della Vittoria, angolo via Matteotti, a ridosso della ex sede della Banca d'Italia, dove il chiosco fu fissato a terra. Maria Bernini Gobattoni, che aveva anch'essa un chiosco, si trasferì nei pressi del passaggio a livello, mentre Ernesta Catoni Burlazza, per il momento, cessò l'attività.
Giunse il momento d'iscriversi alla seconda classe della scuola Tecnica Commerciale.
Era l'epoca che si scioperava per rivendicare, la città di Trieste all'Italia, noi, non fummo da meno; una mattina, spalleggiati pure dal preside e da qualche professore facemmo un corteo che partì da via Emilio Bianchi, si spostò verso Piazza del Plebiscito, sotto la Prefettura; poi su per via Cavour, via Garibaldi, dove fummo presi a sassate dai muratori, che stavano riparando il tetto della Chiesa di San Sisto, seccati per il fatto che qualche esaltato del corteo gridava: "guerra, guerra!".
Viterbo, in particolare nel punto dove ci trovavamo, era stata seriamente distrutta e... c'era ancora chi invocava la guerra.
Io, seccato di tale avvenimento, mi dissociai dalla massa e andai, a lavorare, con mia madre.
Il giorno dopo, sapendo che si ripeteva lo sciopero, non andai a scuola; rimasi nel chiosco ad aiutare mamma, poi con regolare giustificazione, scritta e firmata da mia madre, mi presentai a scuola sottoponendo la stessa al preside, per il visto, il quale non l'accettò dicendomi: “Vattene a casa, vieni accompagnato dai tuoi genitori, non sei giustificato. Tu, che ti sei distinto nello sport, dovevi essere avanti a tutti con il gagliardetto fascista”.
Indignato gli risposi: “Ci mandi suo figlio, al corteo, con il gagliardetto fascista!”.
Io, che già guardavo con simpatia la Democrazia Cristiana, grazie al professore Michele Lo Monaco, che mi corteggiava politicamente, dissentendo dall'invito dell'altrettanto professore Orazio Puletti di Città di Castello, paesano del babbo, che mi aveva invitato a frequentare la sede del M.S.I. che stava lungo il Corso Italia.
L'indomani i miei genitori andarono a parlare con il preside che non voleva riceverli. Visto però che con i miei genitori, non poteva essere prepotente li ricevette e anticipò loro che sarei stato sospeso dalle lezioni, per sette giorni, per aver risposto male al capo dell'Istituto.
Un certo tipo di arroganza faceva ancora effetto anche se lutti, sofferenze e macerie rattristavano l'Italia e gli Italiani.
Capimmo che mi ero giocato l'anno scolastico. Infatti, esposti i quadri scolastici, leggemmo: "Matteacci Bruno - Respinto"; mi avevano dato sette in condotta.
Non ci scoraggiammo ripetei, con profitto, la seconda classe, prendendo il tanto sospirato diploma di "Computista commerciale".
Durante quell'anno scolastico mi impegnai più del solito, anche perché avevo a che fare con chi abusava della propria posizione; comunque ricordo tutti con simpatia, anche se, quell'anno, fui esonerato dal partecipare ad una gita scolastica a Perugia ed Assisi.
A tale proposito, ricordo che il babbo, che aveva un bella Fiat Topolino 500, sapendo che ero dalla parte della ragione; mi voleva portare, con la sua auto, al seguito della gita, ma io non volli.
Nel pensare di scrivere: "Quello che è stato, perché non venga dimenticato" ho ritenuto opportuno dare un ordine cronologico ai fatti; penso di esserci riuscito in parte, anche perché certi tristi avvenimenti si accavallavano nel tempo e quindi nel racconto. Per non rendere lugubre lo scritto, ho deciso di scrivere, a parte, qualche avvenimento, perché penso che non interessi la cronologia di fatti, ma interessi sapere.
La malattia allo stomaco del babbo ci ha rattristato per molti anni.
Da quando il dottor Renato Quadrani, ottimo radiologo viterbese, diagnosticò l'ulcera duodenale, in casa si vedeva qualche sorriso perché era dato per scontato che non era ciò che non voglio più nominare.
Si presero contatti con un luminare della chirurgia, il professore Anacleto Cirenei, primario all'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, che veniva da Roma, il quale disse che "l'operazione chirurgica era urgente farla perché si correva il rischio della perforazione dello stomaco, con le logiche conseguenze".
Per effettuare l'intervento necessitava il pagamento di oltre 350.000 lire, solo per la degenza e l'uso della sala operatoria, perché il professore Cirenei disse, chiaramente, che non intendeva essere pagato per tale prestazione.
Il babbo aveva paura di affrontare l'intervento. Una sera, mentre stava lavorando, si vide presentare, sull'uscio della bottega, il professore Cirenei che era andato a trovarlo, con lo scopo di convincerlo a farsi operare.
Il babbo, rimase colpito dall'affettuosa dimostrazione che gli dette il professore.
Chiedemmo, al Comune di Viterbo, l'iscrizione nell'elenco dei "meno abbienti" allo scopo di poter usufruire del ricovero gratuito.
Da poco tempo la mamma aveva iniziato a lavorare, mentre il babbo, pur avendo la sua bottega, non poteva dedicarsi completamente al lavoro, perché aveva quel grosso problema.
Il Comune non concesse quanto richiesto con la motivazione: "Il figlio Bruno è studente universitario". Furono fatte le informazioni da un incompetente, che non nomino. Si calcoli che eravamo verso la fine del 1949, io avevo tredici anni.
Intanto la bellezza e la grazia di mia sorella Bruna fece colpo su Vinicio Galeotti che chiese, ai miei genitori, di fidanzarsi con lei.
La risposta del babbo fu affermativa, ma gli disse: "Sii il benvenuto in questa casa però, io le cose a lungo non le voglio; stante le mie precarie condizioni di salute, vorrei morire sapendo di lasciare mia figlia sposata".
Il fidanzamento durò appena otto mesi; il 24 aprile del 1949, nella Chiesa di Santa Rosa, Bruna, dove ricevette la Santa Cresima, all'età di sedici anni, contrasse matrimonio con Vinicio; testimoni furono Vittorio Burla e Angelo Zeppa.
Dopo qualche mese Il babbo, ebbe una emorragia; fu ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico.
Ricordo che la mattina che doveva essere operato, andammo ad attendere il pullman della Roma Nord, a Piazza del Teatro, per accertarsi dell'arrivo del professor Cirenei, che, quando ci vide, impallidì, fece una carezza a Bruna e a me, dando una stretta di mano a mamma.
L'operazione ebbe inizio nella prima mattinata e si protrasse per circa sei ore e trenta minuti con l'asportazione di tre quarti di stomaco e la resezione della valvola del pancreas e di una parte di duodeno. Così fu detto, così ricordo e cosi racconto.
Il babbo chiese di non essere addormentato, aveva paura di non risvegliarsi più, fu accontentato, l'operazione iniziò senza anestesia, all'epoca addormentavano con il cloroformio. Dopo pochi attimi che iniziò l'intervento, il babbo, tra il gran dolore, gridò: "addormentatemi, addormentatemi". Così fu fatto.
Era abitudine, prima di sottoporre ad intervento un paziente, praticare allo stesso, una iniezione che, volgarmente, veniva chiamata "d'incoraggiamento", cosa che fu fatta. Terminato l'intervento, consentirono alla mamma di assistere il babbo, con la raccomandazione che, allo stesso, non venisse somministrato nulla ad eccezione di una eventuale, leggera bagnatura delle labbra; cosa che mamma fece con tanta parsimonia. Ad un certo momento il babbo girò gli occhi, iniziò a sudare, e la bocca gli si deformò.
Un grido di aiuto di mamma fece giungere subito dei medici, di cui uno disse: "Che cosa gli hai dato?". La mamma rispose dicendo che la reazione avuta dal marito, era conseguente ad una iniezione che gli aveva praticato un infermiere.
Nella sala riservata agli infermieri era uno scaffale fatto a nido d'ape, cioè con tanti spazi numerati, con lo stesso numero del letto del paziente, dove venivano lasciate le medicine per la terapia dello stesso.
Dopo un breve controllo videro che la terapia che doveva essere fatta al babbo, non era stata effettuata perché, la iniezione di sostentamento era ancora nello scompartimento mentre, nello spazio vicino, mancava l'iniezione che doveva essere praticata ad altro paziente, come “incoraggiamento”.
Compreso l'errore, fu subito praticato un antidoto alla iniezione, erroneamente fatta.
Il mio babbo, grazie a Dio, al professor Cirenei e a mamma, si salvò vivendo, tra il nostro affetto, per altri ventisei anni. Il futuro si presentava, migliore di quello vissuto.
Bruna si sposò, come già scritto, con un bravissimo ragazzo; Vinicio, un vero lavoratore, che entrò, come si suol dire, in famiglia non come il genero, ma come un figlio; era rispettoso, educato, silenzioso ed affettuoso.
Un giorno, appena Vinicio si fidanzò con Bruna, mi fece per regalo la carrozzetta; era a tre ruote con i cuscinetti, quindi silenziosa e veloce; impazzii dalla gioia.
I miei genitori erano entrati nell'ottica di motorizzarsi, pensarono, in un primo momento, di acquistare una moto Guzzi 500 c.c. con il sidecar.
Nel contempo videro un'automobile che colpì la loro attenzione, della quale si innamorarono e, senza pensarci troppo, l' acquistarono.
Il proprietario della bellissima autovettura era signor Orsalini, impiegato all'Ufficio Registro e marito della signora Botarelli, si trattava di una FIAT Topolino tipo A, di cilindrata 500 cc., di colore verde bottiglia, mezza balestra, con capotte, bianca, alla "fiorentina".
Ricordo che, una volta abbassata la capotte gli occupanti erano scoperti, dalle spalle in su. Era veramente un sciccheria, come diceva zia Ida, che anch'essa, con zio Adamo si erano trasferiti a Viterbo, andando ad abitare, da zio Vittorio e zia Anna, in via Cacciamele.
La macchina, serviva anche per accompagnare, qualche volta, la mamma ai magazzini generali, dove acquistava la frutta, ma principalmente restava tutta la settimana nell'autofficina del signor Alessi, in via della Verità dove, molti anni dopo, al piano superiore, era l'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, dove io ero impiegato.
La domenica era attesa con gioia, non solo sotto l'aspetto del riposo, dell'andare a Santa Rosa, dello stare tutti uniti in famiglia, ma era bello perché si andava, sempre, a fare qualche escursione con l'automobile.
Intanto, da un poco di tempo, si era trasferito, da Gubbio a Viterbo il fratello del babbo, lo zio Eugenio, per andare a lavorare alla Macchia del Conte, dove a suo tempo lavorò zio Salvatore. Lo zio veniva a casa nostra ogni quindici giorni.
Dopo un poco di tempo si trasferì, a Zepponami (Montefiascone), pure la famiglia di zio Tommaso, con la moglie Elisa e il figlio Luigi, detto Gigino, con il quale trascorsi il periodo dello sfollamento a Pisciano.
All'inizio gli zii lavorarono alla Macchia del Conte, poi stimolato dal babbo, zio Tommaso, imparò a fare qualche lavoretto da calzolaio, sotto lo sguardo del fratello; trovò un piccolo locale in via Chiusa dove, per un certo periodo, ha svolto o tentato di svolgere tale attività. Poco tempo dopo cessò di lavorare perché, credo, non riteneva remunerativo il lavoro.
Gigino andava a scuola a Zepponani, perché abitava con i suoi genitori e zio Eugenio, in via Madonna del Giglio, poi si trasferirono in via Montisola, 71 dove contrasse matrimonio con Luciana Pannacci, originaria di Montanaldo - Gubbio.
I miei amici, con i quali trascorrevo parte della giornata e, sicuramente i giorni festivi, erano, e sono tuttora, in ordine alfabetico: Claudio Di Gregorio; Elio Fontana, Mario Laurenti, Gabriele Mancinelli, detto Lello, Mario Mancinelli, detto Ciccio, Dino Massi, Giulio Municchi, Emanuele Filiberto Pace, Angelo Petroselli, Giorgio Proietti, Giacomo Scarsella.
Un giorno, decidemmo di andare sulla cima della Palanzana per trascorrere una giornata diversa dalle altre, era il 1° Maggio.
Eravamo il solito gruppo, quel giorno senza donne; ognuno di noi doveva portare qualcosa per il pranzo che avremmo cucinato, una volta arrivati, sulla cima del monte. Percorrendo la strada Cimina, che era bianca, giungemmo in un punto di ristoro con vino e cucina, detto "La bronca" perché chi lo gestiva aveva una infermità ad un braccio. Prendemmo l'acqua, che doveva servire per cucinare la pasta, il vino e, tutti insieme, ci avviammo verso la mèta prefissa, la cima della Palanzana.
Dopo una bella camminata, giungemmo sulla cima, ci riposammo un poco, poi
iniziammo a fare le escursioni in zona.
Verso l'ora del pranzo, accendemmo un bel fuoco, dopo aver preso le dovute precauzioni contro l'eventuale propagarsi delle fiamme, facendo una bella pulizia intorno al focolare, che avevamo predisposto, con delle pietre, sulle quali appoggiammo il recipiente che conteneva l'acqua per cuocere la pasta. Il ragù lo avevamo fatto a casa; c'erano da cuocere la pasta e le braciole.
Quando l'acqua iniziò a bollire, scoperchiammo la pentola per predisporre il tutto. Nel momento che si stava per gettare la pasta nella pentola, ci accorgemmo che essa era invasa da animaletti morti.
Cosa era successo? Scoperchiando la pentola, il vapore acqueo esalò e, poiché al di sopra di noi erano alcune piante, sicuramente invase da animaletti, questi storditi o uccisi dal vapore, caddero e ci bloccarono il buon esito della cucina.
Due o tre amici fra i quali, ricordo Angelo Petroselli, partirono dalla cima della montagna e ritornarono a valle per riprendere l'acqua; in quell'occasione, Petroselli vide una grossa serpe in amore che ostacolava il loro cammino anzi, la serpe si scagliò contro Angelo; ebbero paura e si misero a correre per un lungo tratto, seguiti dalla serpe; in quell'occasione Angelo Petroselli perse la camicia.
Comunque quando si è giovani la fatica non si conosce, come del resto si ignora, troppo spesso, il pericolo.
Ricordo che stavamo a valle, in prossimità a delle pozze d'acqua, si scherzava tra noi tirando i sassi dentro le pozze, allo scopo di schizzare chi stava vicino. Io avevo un bel sasso in mano, facevo finta di tirarlo verso Giorgio Proietti che, al mio gesto, ritraeva la gamba da vicino alla pozza. Una, due, tre volte, ripetei il gesto e Giorgio, sempre pronto, ritraeva la gamba, ma alla mia quarta mossa lui non si tirò indietro.
Lo colpii proprio sull'alluce destro causandogli un forte dolore. Fui preso dal senso di colpa, mi misi Giorgio sulle spalle e via di corsa verso Viterbo.
Mentre correvo sentivo Giorgio che si lamentava e il suo lamento era per me come il carburante necessario per correre; la strada da percorrere era tanta, ma la forza non mancava e il rimorso si faceva sentire, anche se stavamo giocando tra noi.
Giorgio continuava a lamentarsi ed al lamento di dolore aggiungeva, ogni tanto, questa esclamazione: "Anna mia"; Anna era una bellissima ragazza per la quale Giorgio ci "pendeva".
Arrivammo in prossimità di Monte Pizzo, già si sentiva l'inno del P.C.I. che, in detta località, aveva radunato gli iscritti in occasione della "Festa del lavoro".
Cominciavo ad essere stanco, poi la visuale di tutto quel rosso delle bandiere del Partito Comunista, mi annebbiarono la vista; ad un certo momento Giorgio disse: "Sono contento di aver trovato chi mi ha portato a Viterbo, senza faticare", al suo dire fece seguito una risata; ebbi una reazione immediata, scaricai dalle spalle Giorgio facendolo cadere in terra, tra una risata generale.
Tutto ci divertiva, nulla ci divideva, eravamo veramente un gruppo di veri amici; amicizia che dopo oltre cinquant'anni è sempre viva, forte, sincera ed affettuosa.
Altre gite si fecero nell'arco degli anni, una che merita di essere ricordata è quella che facemmo, sempre verso la Cimina, il giorno del Ferragosto.
Partimmo da Viterbo al mattino, era un bel gruppo di amici, ma quella volta tutto era ingentilito per la presenza delle donne.
Giungemmo alle falde della montagna nella tarda mattina, avevamo con noi i viveri, l'unico impedimento che trovammo furono grossi cespugli che ogni tanto fermavano il cammino delle coppie perché ci “infrattavamo".
Comunque trascorremmo una giornata particolare anche se Elio si addormentò sopra una pianta, creandoci serie preoccupazioni; perché avevamo paura che cadesse, anche se, data la sua lunga statura, aveva incrociato le gambe tra i rami della pianta.
Tutto finì secondo i programmi, a tarda sera rientrammo a Viterbo dove trovammo la madre di una nostra amica, che le fece una scenata. Io tentai di prendere le difese della mia amica, ma corsi il rischio di prenderle pure io, tanto la madre era infuriata.
Altre volte decidemmo di fare merende, una delle quali fu fatta nel giardino antistante la casa di Angelo Petroselli, che abitava all'inizio della strada Cimina, al bivio con la strada per San Martino al Cimino, solo che quel giorno le formiche fecero prima di noi, mangiarono tutta la porchetta e quanto noi portammo, perché lasciammo il tutto fuori dalla casa.
Comunque tutto era allegria, anche una piccola sciagura, a volte, poteva essere motivo di una risata.
Sebbene avessi la stessa età dei miei amici, alcuni di questi mi tenevano in particolare considerazione e, quando avevano qualche problema ne parlavano con me.
Ricordo che, un giorno, il mio carissimo amico, Giorgio Proietti, a scuola, ebbe un problema con il professore Gaetano Mazzeri, un "simpatico vecchio signore" siciliano che si faceva rispettare anche se, a volte, eccedeva con i suoi modi di fare.
Ricordo che a Giorgio tolse dal tavolo certi libri e li gettò dalla finestra in via Marconi; giustamente, Giorgio reagì nervosamente al gesto del professore di calligrafia, che voleva pure sospenderlo dalle lezioni.
Del caso fui informato, con la sollecitazione del caro amico, affinché io intercedessi benevolmente verso il professore Mazzeri. Andai a parlare con il professore, al quale chiesi di chiudere un occhio su quanto era accaduto tra lui e Giorgio.
Il professore Mazzeri, abbozzando un sorriso, disse: "sì ora chiudo pure quest'altro occhio", alludendo al fatto che lui aveva un solo occhio funzionante; era monocolo.
Il professore apprezzò il mio intervento abolendo la sospensione.
Dopo qualche settimana accadde a me la stessa cosa. Avevamo il compito in classe, il professore Mazzeri passò vicino al mio banco e vide che sul margine dello stesso era il mio vocabolario; senza esitare lo prese e lo gettò dalla finestra, che si affacciava sul richiastro interno; il salto fu minimo perché da quel lato era un terrapieno.
Io ebbi una reazione incontrollata, gli dissi: "il vocabolario, lei lo ha gettato nel cortile, ma io a lei la butto dalla finestra, dal lato che si affaccia su via Emilio Bianchi, quello più alto; provveda subito a ridarmi il vocabolario!".
Il professore non si aspettava una reazione del genere, rimase molto, molto turbato; chiamò il bidello Mancinelli e lo mandò a raccogliere il vocabolario che mi restituì, con le sue scuse, nella sala dei professori nel momento dell'intervallo.
Un'altra volta, sempre dal professore Mazzeri, ebbi una battuta, che ancora mi fa sorridere.
Era l'ora della ricreazione e stavo mangiando uno sfilatino imbottito, nel mentre che avevo dato il morso al pane ed avevo la bocca piena, entrò in classe il professore, il quale mi guardò, si avvicinò e mi disse: "Tu sii, nu cristiano o nu puorco?"; io inghiottii il cibo e gli risposi dicendo: "A professo' appartengo alla razza sua" e lui disse: "Allora sii nu cristiano!".
A scuola si facevano le consuete gite scolastiche, ricordo quella del 23 maggio 1954. di tre giorni, che facemmo a Napoli, visitammo Terracina, Napoli, Pompei, i campi Flegrei, Pozzuoli, Nisida, Baia d'Ischia e Caserta.
Ci accompagnarono: il preside Oliviero Casanova, il professor Orazio Puletti, la professoressa Claudia Peri, la professoressa Silvana Mazzeri, il professore Carlo De Carlo. Trascorremmo una vacanza veramente da sogno.
Da una fotografia scattata nella Casa del Fauno a Pompei, riconosco: Giuseppe Sugliani, Renato Cappetti, Rita Cario, Mario Costantini, Pasquale Busso, Urbani, Bucciarelli, Sabatti, Giacomo Merlani, Silveri, Pianura, Lombardi, Franco Pinzi, Fausto Bozzi, Eugenio Verardi, Elio Ribeca, Elisa Egidi, Fetoni, Augusto Marchini, Carla Carmassi, Orlandi, Rossana Zei, Tecla Zarletti, Rosalba Franceschi, Celestini, Luciano Barozzi, Cepparotti, Ughetta Zei, Emiliani, Botarelli, Elio Fontana, Luigi Stentella, Carla Salvatori, Antonietta Agostini, Dina Farnesi, Rina Gernone, Clorinda D'Alessandro, Angelo Petroselli, Mancinelli, Gianfranco Chiusaroli; logicamente c'ero anch' io, con tanto di baschetto in testa.
Non mancavano le occasioni per fare le passeggiate, come quella che facemmo al Campo Sportivo di Viterbo, dove le due classi, 1^ e 2^ Tecnica, fecero una fotografia sulla gradinata della tribuna; foto nella quale si vedono: il preside Oliviero Casanova, la professoressa d'italiano, Luigia Donati, il professore di ragioneria Orazio Puletti, il professore d'inglese Pietro Geronzi, il professore di matematica Emilio Innocenzi, la professoressa di calligrafia Silvana Mazzeri e la segretaria, signorina Stavagna.
Tra le studentesse ricordo: Elvira Zei, Materni, Carla Carmassi, Elisabetta Pecchia, Rosetta Sirena, Antonietta Agostini, Rita Gallinella; mentre dei maschi ricordo: Marcello Nuvoli, Poleggi, Di Giuseppe, Fernando Silvi, Franco Pinzi, Giancarlo Selvaggini, Franco Lucernoni, Onesimo Milioni, Francesco Bruni, Lombardi, Bruno Stefanoni, Augusto Marchini, Bernini, Paolo Marianello, Eraldo Delle Monache, Umberto Fabbri, Giovanni Cecchettini, Luigi Naldi, Castoldi, Renato Cappetti, Fausto Bozzi, Bruno Fatiganti, Franco Rocchi, Vincenzo Bruzziches. Amici di allora, amici di sempre!
Con la scuola di gite ne facemmo altre, ne ricordo solo alcune: Perugia - Assisi, nella quale non vi partecipai per volontà di chi il potere lo usava a modo suo, il preside. Altre gite furono fatte a Piombino - Isola d'Elba; Arezzo - Averna; Terni - Marmore e Fonti del Clitunno.
A suo tempo il babbo si era attivato per trovare un'abitazione a Viterbo o nelle immediate vicinanze delle mura castellane. Poche erano le case rimaste in piedi a seguito dei bombardamenti, quindi la difficoltà di trovare un alloggio era sempre maggiore; anche in considerazione al fatto che molte persone rientravano dallo sfollamento, dalla campagna o da altre località.
Eravamo verso la fine dell'anno 1947; avevo circa undici anni, la guerra mi aveva, in anticipo, maturato nel dolore, nel senso del dovere, nell'apprezzare il poco, nell'amore verso Dio e il prossimo; quindi vivevo e sentivo i problemi della famiglia e qualche volta, con Bruna, queste problematiche erano oggetto dei nostri discorsi.
Il babbo, dopo aver girato invano per oltre una settimana, venne a sapere che gli sfollati potevano ottenere un alloggio dal Genio Civile: ufficio di Stato preposto ai Lavori Pubblici ed alla assistenza degli sfollati e sinistrati di guerra.
Questa povera Italia, afflitta dalla guerra, dalla politica, che aveva reso invivibile la situazione; dal clientelismo e dal latrocinio, vedeva i propri figli giunti alla disperazione!
Mio padre, venuto a conoscenza che, in zona Paradiso, era un ex convento di frati, già utilizzato come caserma e da poco tempo destinato ad alloggio per gli sfollati che rientravano a Viterbo, si recò sul luogo e trasse le conclusioni che lasciavano intravedere la presenza di un ampio locale, che si sarebbe potuto utilizzare, come abitazione.
Il babbo vide, guardò, misurò i muri perimetrali esterni e fece un raffronto con i locali interni; risultò, al suo occhio clinico, che il perimetro esterno era maggiore dei locali interni; anche perché quello che lui guardava, era misurabile in tre lati.
Da una finestra, che stava proprio sull'angolo, vicina ad una altra finestra, semichiusa, riuscì ad entrare, correndo anche un grosso rischio perché l'altezza da terra era tanta.
Entrato che fu rimase a bocca aperta. C'era un salone con quattro finestre, due delle quali si affacciavano verso il chiostro dei frati, mentre le altre due volgevano verso via della Caserma e via del Paradiso; aveva il pavimento con mattonelle rosse esagonali, mentre il soffitto era perfetto, con un controsoffitto leggermente allentato in un angolo
Il predetto locale era libero, gli unici occupanti erano due conigli dentro ad una gabbia, da poco alimentati perché vicino c'era erba fresca.
L'entusiasmo del babbo non si poteva contenere, con discrezione, uscì e si recò immediatamente nei locali del Genio Civile per rivendicare l'assegnazione del predetto locale.
Giunto davanti al funzionario preposto alla assegnazione degli alloggi, riferì quanto veduto, chiedendo l'assegnazione dello stesso.
Quel funzionario mise in dubbio quanto asseriva il babbo poiché dalle piantine topografiche, in suo possesso, diceva che: "non erano presenti alloggi, nei locali dell'ex Caserma Paradiso".
Il babbo gli disse: "va bene, però, se un locale esiste, quello è mio e non più di chi ha interesse, ad occultarlo, per tenerci due conigli".
Quel solerte funzionario, gli disse: "aspettate, andiamo insieme sul posto, se quanto voi dite è vero, sono contento e il locale sarà assegnato a voi e famiglia perché, dai documenti, che mi avete dato, ne avete più che diritto".
Il tragitto fu più breve del dovuto perché, a passo sollecito, i due si diressero in loco. Giunti che furono sul posto, non si trovava la porta di accesso, perché occultata con una muratura e tinteggiatura, volutamente invecchiata.
Il babbo gli suggerì di passare da dove era entrato lui, ma quel signore si rifiutò di correre degli inutili pericoli e disse: "in loco abbiamo dei nostri muratori che stanno sistemando gli alloggi, li chiamiamo ed abbattiamo il muro che ostacola l'ingresso".
Ci volle poco, due colpi di piccone e, la porta fu aperta.
Agli occhi del funzionario si presentò quello che il babbo gli aveva descritto, per un attimo quel signore rimase sbigottito, ma compiaciuto. Mio padre fu invitato ad andare, in ufficio per concretizzare, la tanta desiderata, assegnazione dell'alloggio.
Stipulato l'atto di assegnazione dell'appartamento; dati i dovuti incarichi ad un geometra, per una adeguata tramezzatura e messa in opera della porta di accesso e di quant'altro necessario, per rendere abitabile l'alloggio, quell'ottimo funzionario salutò il babbo, che lo ringraziò, con una stretta di mano, mentre lo stesso gli augurava un futuro migliore.
Ci volle un poco più del previsto per sistemare la nuova abitazione.
Ricordo che ricavarono un ingresso di circa 16 metri, senza finestra, dove dormivo io; una camera per mia sorella di 18 metri circa, con finestra; una camera da letto, di circa 25 metri, con finestra, per i miei genitori; una cucina di circa 13 metri, con finestra e in un angolo della casa che poteva essere pericolante, ci ricavarono un magazzino con finestra sul chiostro.
Messe le dovute finestre, riparato il controsoffitto a camera a camme, il tutto divenne un bellissimo appartamento, invidiato da molti; in particolare da chi aveva interesse nel tenere nascosta la sua esistenza, pur di utilizzarlo per i conigli.
L'unico inconveniente erano i servizi igienici fuori dell'appartamento, erano otto, a disposizione delle otto famiglie del piano.
Purtroppo questa casa non esiste più perché è stata successivamente demolita; comunque era sulla sinistra dell'ingresso dell'attuale sede universitaria di via del Paradiso.
Le cose cominciavano ad andare per il meglio: il babbo aveva nuovi clienti, fra i quali personalità della città, come il Prefetto di Viterbo, il dottor Samaritani, il professore Tommaso Farisei, la elegantissima calzoleria dei fratelli Rossini, di via Giacomo Matteotti; il dottor Bernardini, il signor Minelli, il professor Oliviero Casanova, il signor Consalvo Delle Monache, detto Farinella, la famiglia Battaglia, il signor Cenciarini; il signor Silvio di Franceschi, tanto per citarne alcuni.
Noi figli collaboravamo di vero cuore con i nostri genitori, Bruna pensava, con ottimi risultati, alla gestione della casa, io davo una mano.
Ricordo che al mattino mi recavo ad acquistare il latte in via Roma, nella latteria dei fratelli Chiodi; solo dopo molti anni fu cambiato, per volontà degli stessi, il cognome in Chiodo. In detta latteria c'era un sistema per fare la fila veramente pratico; si metteva la bottiglia in fila su un lungo tavolo e il proprietario della stessa rimaneva fuori fila perché due o tre persone pensavano a far scorrere le bottiglie, che avevano tutte un particolare segno di riconoscimento, verso l'operaio che le riempiva.
Il lavoro della mamma andava bene, i clienti non mancavano sebbene nella stessa piazza erano altri commercianti tra i quali ricordo Maria Bernini in Gobattoni, madre di Laura e Luigi, miei amici; Ernesta Catoni in Burlazza, mamma di Lisetta, Giuseppe e Irma; Giuseppe Capulli con la moglie Giacinta; Fiorentini e due sorelle, delle quali non ricordo il nome.
Intanto i miei genitori, da un signore, abitante in via Porta Murata, che svolgeva il servizio pubblico di trasporto persone, con una carrozza trainata da un cavallo, ebbero il permesso di parcheggiare, di notte, il chiosco in un tratto di strada senza uscita, sita sul lato destro, dove era la stalla per il cavallo.
Da quel giorno le fatiche diminuirono perché il tragitto, che normalmente si doveva effettuare, era di gran lunga inferiore a quello che facevamo per giungere nel vecchio magazzino, ove si pagava pure l'affitto, che si trovava in via del Pavone , adiacente allo stabile delle scuole "Monachelle", con ingresso proprio davanti ai locali dove oggi è la sede dell'Associazione don Armando Marini.
Gli affari andavano bene, il tutto andò ancora meglio quando i miei genitori riuscirono ad ottenere dal Comune di Viterbo, l'autorizzazione per fissare a terra il chiosco.
Da quel momento tutto era più facile; non c'era più la necessità di giungere sul posto di lavoro tutti e quattro insieme.
Il babbo poteva andare direttamente alla sua bottega; la mamma, da sola poteva gestire il chiosco; mentre io potevo andare a scuola e Bruna provvedere alla casa e, se necessario, andare ad aiutare la mamma.
Giunse il momento di trasferirsi, nel nuovo appartamento; sembrava una cosa irreale. Babbo e mamma provvidero a fare i dovuti contratti per l'energia elettrica e per la fornitura di acqua potabile, dopo aver provveduto ad acquistare qualche mobile che mancava.
Immediatamente ci trasferimmo nel nuovo alloggio, che era ubicato al secondo piano, in un'ala del complesso religioso, a sinistra del portone di accesso del convento.
Prendemmo possesso dell'appartamento; ognuno di noi ebbe una chiave; mi sentii "grande"!
Il mattino successivo affacciatomi dalla finestra della cucina, che era orientata verso il chiostro dei frati, vidi una grande quantità di erbe, adagiate su appositi contenitori di legno, con una base di stoffa, da lì proveniva un buonissimo profumo.
Scesi subito, trovai il cancello aperto ed entrai. Fra quei contenitori si aggirava un simpatico signore che indossava una lunghissima parannanzi bianca.
Questo signore, nel vedermi, disse: “Vuoi vedere che ho trovato chi mi aiuta..., come ti chiami?”.
La risposta non ci fu subito, anzi gli domandai: "che ci fate con tutte queste erbe? .... Siete voi il padrone? ...Io mi chiamo Bruno e voi?". Quel signore non esitò, un attimo per dimostrarmi la sua bontà, con un sorriso a tutti denti, mi disse di chiamarsi Enrico Natili, che lavorava nell'Officina galenica dei Frati Minori del Paradiso, sotto la direzione del reverendissimo padre Antonio Daddario, noto erborista, già appartenente all'Ordine religioso degli Scalzetti, ordine soppresso dal Papa.
Mi feci spiegare cosa era una Officina galenica; lui mi portò dentro ad un grande locale, al piano terra, dove erano un macchina che impastava le erbe tritate, una macchinetta che faceva le pasticche e tante, tante scatolette da riempire di verdure, che lui chiamava tisane.
Poco dopo sopraggiunse padre Antonio, era una persona di poche parole, ma io, non so perché, entrai subito nelle sue grazie, disse, infatti: "Penso che abbiamo trovato il chierichetto; ti piacerebbe servire la Santa Messa?". Non avrei voluto di più, accettai subito, anche se gli dissi che avrei dovuto sentire, prima, la mamma e il babbo.
Lui mi domandò se ero quello che era venuto ad abitare da poco e se andavo, con i miei genitori, alla Santa Messa domenicale.
Avuta la risposta affermativa, disse: "Sono sicuro che i tuoi genitori ti diranno di sì". Così fu. Divenni il chierichetto, che tutte le mattine serviva la Santa Messa celebrata da padre Antonio o dai confratelli Saturnino e Gaetano.
Avevano nel convento un cuoco cicciotto, del quale non ricordo il nome, che tutte le mattine, dopo la Santa Messa, mi dava la colazione a base di pane e prosciutto.
Intanto i giorni passavano sereni e si avvicinava la Santa Pasqua.
Padre Antonio disse che dovevamo andare a benedire le case. Stabilito il giorno, mi spiegò quali erano le mie incombenze e partimmo.
Sul braccio destro tenevo un canestro, che serviva per depositare le uova che la gente ci avrebbe dato; con la mano sinistra tenevo un secchiello pieno di acqua santa, dove padre Antonio immergeva l'aspersorio, che serviva per benedire le famiglie e le case.
Iniziammo dalle case dell'ex Caserma Paradiso, dove Bruna ci aspettava nel nostro appartamento.
Usciti, andammo dalle famiglie: Moncelsi, Grani, Vergati, Zanobbi, il molino Medori e poi cominciammo a salire lungo viale Trieste, benedicendo solo le abitazioni esistenti sulla destra perché quelle che si trovavano sulla sinistra, venivano benedette dal parroco di Santa Maria dell'Ellera, don Otello Ferrazzani, che poi era il mio parroco da quando siamo venuti a Viterbo e lo era anche in questa occasione, perché la Chiesa di Santa Maria del Paradiso non era ancora parrocchia.
Era abitudine che in ogni casa regalassero delle uova o del danaro, ma non solo: il solito bicchierino di liquore o di vin santo, non mancavano mai.
Le famiglie erano molte e tante furono le bevute che, giunti a metà di viale Trieste, nel secchiello non c'era più un goccio d'acqua benedetta, perché il mio andare era incerto e traballante, con le relative conseguenze.
Verso i Magazzini generali, incontrammo don Otello che, veduto lo stato di padre Antonio e il mio, ci invitò di ritornare in convento; cosa che facemmo, subito, con passo incerto.
Trovammo la porta della chiesa aperta, entrammo e ci mettemmo seduti sulla fresca pietra del pavimento, a destra dell'ingresso; dopo aver chiuso la porta fui invitato a contare i soldi delle offerte, che ammontavano a lire settecento. Padre Antonio mi volle dare settanta lire e quasi subito fummo storditi dai vapori dell'alcool, dopo aver chiuso la porta, ci addormentammo.
Il tramonto si avvicinava, noi dormivamo; seppi, poi, che ci cercarono per tutto il convento, poi sul far del buio, fra la gioia di tutti, ci trovarono.
Con la mia attività di chierichetto continuai ancora, per un poco di tempo, a servire il Signore, poi dovetti sospendere, perché la mattina mi dovevo svegliare molto presto per andare a prendere il latte in via Roma e poi andare a scuola con la stanchezza che si vedeva sul mio volto.
Attendevo però, con desiderio, la domenica perché potevo servire la Santa Messa, senza fare la levataccia mattutina.
Tanto come anticipo dico, ora, che in quella chiesa, sono ritornato a fare il chierico dal 14 Novembre 1999, quando vice parroco, ma di fatto parroco, era il carissimo don Gianluca Scrimieri che ho seguito affettuosamente, che seguo e mi auguro di continuarlo a seguire, come feci coi fratelli don Armando e don Bruno Marini, che saranno oggetto di un particolare racconto.
Una sera, mentre rientravo a casa, percorrendo via della Caserma, nella quale era, sul lato destro salendo, una profonda cunetta, sentii dei guaiti; ebbi un attimo di smarrimento, non riuscivo a vedere da quale parte venissero per il buio.
Dopo un attento controllo vidi, dentro la cunetta, due cagnolini. Erano talmente piccoli che a prima vista mi sembravano due gatti, allungai un braccio verso il fondo e riuscii a tirarli fuori; erano bagnati, avevano il pelo tutto attaccato al corpo, erano infreddoliti, tremavano come foglie al vento.
Non sto a raccontare la tenerezza che provai verso quelle due creature, io
ho sempre avuto un debole per gli animali, in particolare cani, gatti ed uccellini.
La gioia fu tanta e tale che presi i due cagnolini, li portai a casa, li asciugai con l'asciugacapelli, li cosparsi di talco e li misi a dormire dentro un cesto, in cucina, vicino al camino.
Ero felice avevo, finalmente, due cagnolini, anche se erano piccoli, molto piccoli.
Ma la felicità delle volte dura proprio un attimo e quella sera per me la felicità fu solo quella che mio padre riuscì a farmi capire cioè: "dovevo esser felice perché avevo salvato la vita a due animaletti" e mi dovevo dimenticare di pensare che quei cani potessero diventare miei, perché avevano tanto di padrone. Infatti, il babbo, per farmi capire il valore dei cani, mi disse: "sai Bruno? questi cagnolini sono stati portati in Italia con l'aeroplano, sono di proprietà del cavaliere Gargana e gli stessi vengono portati a spasso dal fratello; infatti, oggi l'unico onere che ha questo signore, è portare a spasso quei due cagnolini che dovrebbero appartenere alla razza dei... mi disse un nome strano che assomigliava a chihuahua.
Alle prime ore del giorno il babbo prese i due cagnolini e li portò al signor Gargana che, mi sembra, abitasse in via della Sapienza.
Nella mia gioventù sono stato impegnato, anche se sporadicamente, in attività sportive in varie specialità.
A Viterbo faceva il servizio militare un certo Greco, già noto pugile ed amico di Gianni Pagano, che aveva un negozio di abbigliamento in via Saffi; ora ha una attività commerciale in via Monte Zebio.
Io fui attratto dalla disciplina sportiva del pugilato e, a tale proposito, mi recavo, tutte le sere, nel richiastro della Chiesa di San Marco, con ingresso in via Santa Rosa, dove facevamo l'allenamento, poiché nella palestra in via Dobici potevano entrare e praticare il pugilato solo coloro iscritti alla Federazione pugilistica, dopo aver ottenuto il nulla-osta sanitario.
Gianni mi prestò i guantoni che, poi, dovetti pagare perché ne ruppi uno.
Una sera avevo i guantoni calzati, quello della mano destra era già legato al polso, mentre stavano per legare quello sinistro, arrivò di sorpresa mia madre, contraria a quel tipo di sport; non ci furono parole, mi tolsi il guantone sinistro che non era ancora fissato; tentai di togliermi il guantone dalla mano destra, ma per il fatto che era fissato al polso, si ruppe nella parte superiore.
Al dispiacere, arrecato alla mamma, fecero seguito due begli schiaffi, uniti alla frase: "io t'ho fatto un bel viso ed io te lo gonfio!". Fu l'ultimo combattimento che feci! Vinse mia madre, per K.O. tecnico!.
Successivamente mi dedicai, per circa un anno, al calcio, giocando nel ruolo di portiere, con la squadra "Ellera". Altra attività sportiva, non agonistica, fu quella del pattinaggio a rotelle. Adiacente allo stabile dove abitavo in via del Paradiso o in via della Caserma, considerati i due accessi, era un grande spazio, con fondo in cemento, dove spesso facevano opere teatrali.
In momenti in cui la pista era libera veniva utilizzata per il pattinaggio a rotelle. Io ero un frequentatore assiduo anche se non ero tanto abile; di culate ne ho date tante prima di poter gareggiare con gli amici che erano molto più bravi di me..
L'attività sportiva che, mi è rimasta nel cuore, è il ciclismo che non mi ha mai abbandonato. Da ragazzo andavo, spesso, in bicicletta con quella del babbo, ricordo che ne aveva due, una Legnano, la mitica, ed una Ovium.
Chi non aveva la bicicletta poteva prenderla a noleggio dal signor Patara, detto "Fastidio" che aveva un locale in via Mazzini, dove svolgeva l'attività di ciclista nel senso di riparatore di biciclette.
Qualche volta accompagnavo gli amici, da Fastidio, per prendere, a noleggio, la bicicletta e… via per Viterbo.
Quando capitava qualche incidente e la bicicletta presa a noleggio si rompeva, qualche briccone la riportava a Fastidio lasciandola a qualche metro dall'ingresso della bottega, lo avvisava e poi scappava via, per non pagarne le conseguenze.
Certo dopo pochi giorni non poteva prendere la bicicletta, perché Fastidio lo riconosceva, ma dopo qualche giorno tutto passava nel dimenticatoio e la storia continuava.
Il mio babbo era molto meticoloso nella manutenzione delle biciclette, ricordo che si serviva, per quanto non poteva fare da solo, dai ciclisti Gino e Bruno Fiorucci, nella bottega in piazza della Rocca.
Ricordo che con un gruppo di amici si organizzò una corsa ciclistica, da farsi in una domenica, che chiamammo il giro della "sorca".
Si partiva da Viterbo per arrivare a Montefiascone. Dopo una sosta di circa trenta minuti, si partiva da Montefiascone per andare a Bolsena dove si mangiava quello che ognuno portava da casa, poi si ripartiva verso Montefiascone e giù per Viterbo.
La stanchezza, non sapevamo cosa fosse; la passione era tanta e, per saziarla, avevamo delle biciclette da passeggio molto pesanti e senza prestazioni che alleviassero la fatica; avevamo pochi anni, tanta forza e nessun pensiero; tutto era bello.
Ricordo che erano con me, o io ero con loro, i carissimi fratelli Giorgio e Marcello Taurchini, Franco Giammarioli, che aveva una bellissima bicicletta con il conta chilometri e il cambio. Non voglio di proposito citarne altri; questi tre, che il Signore ha chiamato a Sé, sono oggi nelle piste celesti del paradiso e sono certo che averli ricordati è stato un dovere perché mi sono vicini, come lo furono durante la tappa terrena.
I fratelli Taurchini abitavano al Pilastro, in via Emilia n.1; io li conosco da sempre e da sempre siamo stati ottimi amici, in particolare con Giorgio con il quale, oltre aver fatto delle scorribande, ho studiato sia alla scuola "Orioli" che all'Istituto Tecnico "Paolo Savi", dove insieme abbiamo frequentato e ci siamo preparati per gli esami di maturità.
Giammarioli, figlio unico di una simpaticissima coppia, abitava nello stabile della Banca d'Italia dove il padre svolgeva il lavoro di usciere.
Di amici, nella mia gioventù ne ho avuti sempre tanti; sono state amicizie pure, sincere, leali; sono state amicizie da non dimenticare ed io mi sono sempre considerato fortunato per il fatto di avere amici come quelli che ho avuto e che ho ancora.
Per qualcuno dei predetti sono stato un punto di riferimento, si potevano tranquillamente rivolgersi a me in ogni momento, come spesso hanno fatto, con la certezza che, nel loro interesse, mi sarei attivato il più possibile.
Ho da poco maturato il settantesimo compleanno e posso ben dire che gli amici di ieri sono gli amici di oggi e mi auguro, più a lungo possibile, poter dire che ho tanti, veri, cari, amici su questa terra e alcuni che mi hanno preceduto e mi stanno aspettando nel regno di Dio!
In un momento di ricordi, come questo, mi viene da dire: "Amici cari, in questa valle di lacrime io piango bene... nessuno di noi può sapere quando sarà il giorno del nostro incontro, certamente sarà un attimo di vera commozione, l'abbracciarsi e il rimembrare il nostro passato. Comunque siete stati e sarete sempre nel mio cuore!".
L'attività artigianale, di calzolaio di mio padre Giuseppe, successivamente chiamato “Maestro", ebbe inizio, con tanta gioia di tutti! Il babbo aveva già qualche cliente nella zona dove abitavamo, ma la mira era di far diventare clienti coloro che abitavano nelle vicinanze. C'era da tenere conto che nelle vicinanze erano altri calzolai: in via Mazzini ve n'erano tre, in piazza Crispi uno, in piazza Fontana Grande ce n'era un altro.
Per fare la clientela l'unica pubblicità valida era, come diceva il babbo: "lavorare bene, usare materiale buono, essere puntuale e praticare prezzi buoni”.
Il babbo praticò questi criteri, ma ne pretese uno che in un primo momento lasciò la clientela sbalordita, poi si adeguò ed apprezzò quanto il babbo pretendeva.
Il babbo non accettava scarpe se non ben pulite e, in certi casi, con una spolverata di talco all'interno delle stesse.
Il babbo restituiva il lavoro fatto talmente bene che non era possibile vedere, nel caso di una risolatura, il punto di congiunzione tra il nuovo ed il vecchio.
Il primo paio di scarpe nuove, le volle fare per me; ricordo che erano di vacchetta; erano un paio di scarpe che mi consentivano di fare l'esibizionista; infatti, le tenevo sempre lucide e, quando stavo a scuola, spesso mettevo i piedi in modo che si vedesse la scarpa. Ero orgoglioso di avere un babbo come il mio!
Non da meno il babbo trattò mia sorella Bruna, alla quale fece un paio di sandali con il tacco leggermente più alto del normale; cosa che fece tanto piacere a Bruna; che già aveva un atteggiamento da signorinetta!
La mamma intese dare un aiuto economico alla famiglia. Si ripartiva da zero, le esigenze della casa era tante; sia ben chiaro non che si faceva il lusso, ma un vestito con le pezze non lo abbiamo mai indossato, come pure un pezzo di carne lo abbiamo sempre mangiato.
I miei genitori chiesero al Comune di Viterbo la licenza ambulante per la vendita al minuto di frutta e verdura, licenza che fu loro concessa.
Il punto in cui decisero di svolgere l'attività commerciale fu quello di piazza Verdi, meglio conosciuta come piazza del Teatro, più precisamente davanti al palazzo Santoro, sul marciapiedi, sotto ai pini. Oggi, nel punto dove stava la mamma è l'edicola dei giornali.
Il punto di appoggio delle cassette e dei plateaux, contenenti le varie specie di frutta era un robusto carrettino, con due stanghe molto lunghe e due ruote che poggiavano su un forte assale.
Alla sera, terminata l'attività commerciale della mamma, si accatastava tutto sul carrettino e, spingendolo, ci si trasferiva in via della Pace n.73, nella bottega dove lavorava il babbo.
Si scaricava tutta la merce invenduta e, per evitare che rubassero il carrettino, si metteva dentro la bottega, già occupata da altre cose.
Per il poco spazio a disposizione, era necessario togliere le ruote al carrettino, sollevarlo di fianco e allo sforzo dei miei genitori, aggiungevamo le pur piccole forze di noi figli, che qualche volta erano determinanti, come ci facevano notare i nostri genitori, apprezzando la nostra collaborazione.
La mamma era una commerciante nata; sia per come conduceva le trattative per gli acquisti, che per come teneva i rapporti con i clienti, che grazie a lei aumentavano sempre di più, con buoni incassi giornalieri.
Non da meno era il babbo con la sua attività, anche se si affacciava il solito male di stomaco che da tempo logorava il suo fisico.
La mamma non era al massimo della salute; aveva postumi della guerra come la claustrofobia che contrasse quando rimase sotto il bombardamento durante la guerra; mentre, il reumatismo si era impossessato del suo fisico, a causa del tanto lavoro sostenuto nel passato.
Il babbo e la mamma affrontarono una spesa non indifferente per acquistare un chiosco con tre ruote, due davanti ed una, snodabile, dietro.
Il chiosco consentiva di stare all'interno dello stesso; quindi rendeva liberi dagli agenti atmosferici, non dico totalmente, ma riparava davvero molto.
Il chiosco era come una casetta di circa sei metri quadrati; aveva un lato che si apriva con un grande sportello che diventava il tetto della merce esposta sotto di esso.
In un lato aveva la porta d'accesso in cui potevano sostare comodamente anche tre o quattro persone; nella parte, davanti alla porta, era una grande finestra.
Alla sera, dentro il chiosco, dopo aver chiuso lo sportello, si collocavano tutte le cassette che servivano per conservare ed esporre la frutta. A quel punto veniva il bello! Il chiosco si doveva togliere dalla piazza per lasciare libero lo spazio occupato. I miei genitori avevano trovato un magazzino in via del Pavone, a fianco alle "Monachelle". Tutte le sere, noi quattro sapevamo che dovevamo fare questa faticaccia: dovevamo spingere con le nostre forze il chiosco fino al magazzino. La parte che aveva una sola ruota snodabile la tenevamo dietro e il tutto si comandava agendo sullo snodo della ruota.
Lasciato il chiosco si rientrava, soddisfatti, a casa in attesa di un meritato riposo; per ripartire l'indomani mattina per fare il percorso al contrario.
Noi figli, nel nostro piccolo, abbiamo sempre aiutato i nostri genitori.
Intanto Bruna ed io frequentavamo le rispettive classi con discreti, risultati, anche se il nostro pensiero non era sempre dedicato allo studio, forse per il fatto che la giornata la trascorrevamo quasi sempre soli.
Bruna, essendo la maggiore di età, ebbe l'ordine di poter comandare me per fare quanto lei avrebbe richiesto, nell'interesse della casa ed in particolare nel mio. Qualche volta litigavamo ed io, carogna, prendevo il sopravvento su di lei che, sempre dolce, sottostava alla mia prepotenza comunque affettuosa.
Ricordo che qualche volta mi faceva i compiti di scuola, mentre io stavo, magari, a giocare.
Un giorno, che non dimenticherò mai, accadde ciò. Io stavo nel cortile a giocare con gli amici, Bruna stava a casa perché, oltre che fare la scolara, faceva anche le faccende domestiche: Bruna è nata donna di casa.
Quel giorno il babbo, per un normale controllo, o per qualche motivo che ora non ricordo, venne a casa; trovò Bruna che stava studiando, domandò dove io fossi. Bruna, dolce come sempre rispose: Bruno è sceso proprio adesso, anche se non era vero, lei ha sempre avuto, nei miei, confronti lo spirito di protezione!
Il babbo le disse: "chiamalo!".
Bruna allora si affacciò dalla finestra e con voce sommessa chiamò due volte: "Brunoo..Brunooo...".
Io dal cortile feci un gesto con la mano, come per dire: "aspetta... aspetta!". Il richiamo, da parte di Bruna, fu ripetuto per due o tre volte, e per due o tre volte, fu la mia risposta con la mano.
A quel punto sentii sibilare nell'aria il fischio del babbo, molto noto a noi famigliari. Fu una gelata di sangue nelle mie vene, corsi verso casa, immaginando a cosa stavo andando in contro. Giunto che fui, con la lingua fuori per la corsa fatta, il babbo mi disse: "Riprendi fiato" ed io pensai me la sono passata liscia. Ma non fu così, a fiato ripreso e dopo aver bevuto un goccio d'acqua, mi giunse una sberla, che mi fece fischiare l'orecchio, seguita dalla frase: "E' così che ubbidisci a tua sorella?
Voglio, ora, ricordare, forse, l'ultimo episodio che accadde agli Occhi Bianchi prima della Santa Pasqua.
Era tradizione, che quando passava il prete per benedire le case, si facesse benedire anche un congruo numero di uova che dovevano servire per la colazione pasquale. Mamma, come sua abitudine, procurò una ventina di uova fresche che mise in un bacile, in attesa che, don Otello Ferrazzani, il nostro Parroco, venisse nella nostra zona a benedire e, dopo aver benedetto la casa avrebbe dovuto benedire le uova.
Ricordo la faccia di mia madre e di don Otello! Mamma sollevò il bacile contenente le venti uova, con tanta facilità perché, il tutto, era molto leggero.
Successivamente trovarono tutte uova vuote!
Io, uno o due al giorno, dopo aver fatto, con l'ago, un forellino all'uovo, bevetti tutte le uova. Il vizio non lo avevo perso; l'uovo era uno dei miei cibi preferiti!
Per il Corso Italia era la macelleria di Alicandro Vergati, nella quale lavorava Momo, un uomo alto, di poche parole, ma molto cortese. Quando passava in piazza del Teatro, la mamma gli ordinava sempre la carne. In particolare le costarelle di maiale e bollito; salvo per la domenica che, ricordo, chiedeva quattro belle bistecche.
Mamma, al signor Momo, faceva sempre l'omaggio di una busta piena di frutta perché ci sentivamo privilegiati in un momento di carestia e che, per fare degli acquisti, si dovevano fare sempre lunghe file.
La situazione non cambiava; anche nel negozio della Cooperativa del Popolo esistente in piazza del Teatro, dove oggi è la latteria si doveva fare molta fila. Ricordo che tale attività era gestita, sotto l'ottimo controllo amministrativo, del signor Alberto Jacchia, con la materiale collaborazione lavorativa di Osvaldo, Reno e di un terzo dipendente, del quale non ricordo il nome.
Tutto procedeva per il meglio, ma era sempre presente il problema della salute del babbo, mi sembra ancora di vederlo ritornare, verso il chiosco, proveniente dal Corso Italia, appena sbucava da via Mazzini, in un atteggiamento sofferente, curvo in avanti e, lamentandosi, si adagiava sul pavimento del chiosco.
Il babbo era in cura dal dottor Vespasiano Bottoni, con studio medico sopra il locale della Cooperativa del Popolo proprio davanti al chiosco di mamma.
La diagnosi, sullo stato di salute del babbo, per anni fu dubbia, fino a quando l'ottimo dottor Renato Quadrani, con studio radiologico, in via fratelli Rosselli, prese a cuore il caso, sostenendo che, secondo il suo parere, non era un cancro, ma un grosso problema allo stomaco, per la precisione disse che si trattava di ulcera duodenale e, solo una operazione chirurgica avrebbe potuto risolvere il caso.
Bruna, preparava il pranzo, noi due mangiavamo, poi lo portavo prima alla mamma, poi al babbo. Attendevo che quest'ultimo mangiasse e poi facevo ritorno a piazza del Teatro, dove mi incontravo con gli amici: Marcello Biagi, purtroppo da poco deceduto, ottimo amico, atleta e persona molto umana, Vinicio Colonna, ottimo amico il quale lo chiamavo, come ho già detto, Oiciniv Ottorocub mentre lui mi chiamava: Onurb Ottorocub; Luigi Gobattoni, sempre amico e grande ciclo amatore, Luciano e Franco Zaffamenti, non da meno degli altri; tutti abitanti in via San Marco.
Ricordo quanti "Giri d'Italia" e quanti "Tours de France" abbiamo fatto, sulle scale della Chiesa di San Marco, quando era parroco don Fiorino. Ricordo che facemmo anche una "banda" alla quale demmo il nome francese "Le leopard fanteau".
La domenica si andava al Cinema Corso, ricordo che i miei genitori mi davano la pagaccetta di 200 lire, che era più che sufficiente per pagare il biglietto dal costo di lire 60 per il cinema, lire 50 per la pizza napoletana e ricordo, che un supplì costava 10 lire, alimenti che mangiavamo, in una pizzeria esistente all'inizio di via Mazzini, angolo Corso Italia. Bruna aveva le sue amiche con le quali tutte le sere faceva una passeggiatina per il Corso nei punti ove era ancora transitabile, a causa dei danni provocati dai bombardamenti.
Intanto il ricordo della guerra, per noi bambini, si affievoliva; avevamo un futuro che ci aspettava, un presente da vivere ed un passato da dimenticare!
Terminai la scuola elementare e mi trovai davanti ad un bivio.
Il babbo non stava bene in salute, non ci si poteva permettere di prendere una strada scolastica lunga. Era necessario fare presto e bene, cioè prendere un indirizzo scolastico allo scopo di avere “un pezzo di carta", come diceva il babbo, e la possibilità di mangiare un pezzo di pane, quanto prima possibile.
Questo era il pensiero dei miei genitori che dopo, aver fatto le dovute valutazioni, ritenemmo giusto prendere.
Mi iscrissi alla prima classe della Scuola di Avviamento Professionale Commerciale "Francesco Orioli", con sede in via Emilio Bianchi, di fronte alle "Monachelle".
Era una scuola, nella quale si studiavano tante materie, utili nella vita; erano tre anni di avviamento poi, dopo un esame, si accedeva alla frequenza della Scuola Tecnica Commerciale che aveva due classi. Al termine delle quali veniva rilasciato il Diploma di Computista commerciale. Era poco, ma chi aveva questo diploma sapeva, più o meno quanto un ragioniere.
In questa scuola le materie di studio erano: italiano, storia, geografia, matematica, computisteria, ragioneria, tecnica bancaria, inglese, francese, istituzione di diritto, musica, calligrafia, stenografia, dattilografia e educazione fisica.
Delle predette materie, prima della frequenza della prima Tecnica, alcune si lasciavano, come: dattilografia, calligrafia e musica, mentre altre si iniziavano come ragioneria e inglese.
Nel primo anno di Avviamento ero veramente bravo, ricordo che mi fu assegnata la borsa di studio, come primo della classe. L'anno successivo ebbi nuovamente quel riconoscimento, solo che fui il secondo; mentre alla fine del terzo Avviamento, ebbi sì la borsa di studio, ma arrivai terzo.
C'era nell'aria qualcosa che mi distraeva, la mia attenzione era molto, molto attratta dalla grazia di qualche compagna di scuola.
I miei genitori, per premio della mia promozione, mi mandarono in villeggiatura dalla nonna Assunta e da zio Emilio, a Gubbio, dove trascorsi, tra l'affetto di tutti, giornate stupende. Intanto le condizioni di salute del babbo precipitarono, si dovette far operare allo stomaco. Di questo, triste avvenimento ne farò, in seguito, oggetto di una particolare narrazione.
Tre anni passarono veloci, sostenni felicemente gli esami e fui ammesso alla frequenza della prima Tecnica Commerciale. Quell'anno fui il miglior atleta della scuola, ebbi un riconoscimento con una medaglia; la mia specialità era il lancio del giavellotto e i millecinquecento metri campestri. Tra l'attività ginnica e le distrazioni sentimentali non è che andassi molto bene nel profitto scolastico.
La mamma venne a parlare con i professori i quali consigliarono un sostegno con qualche ripetizione. Fui mandato a lezione dalla professoressa Palmira Cuccioli, che abitava in via del Teatro Nuovo n.1, ultimo piano.
Era veramente un genio! Era in grado di insegnare qualsiasi materia, da quelle letterarie alle straniere, dalla matematica alla ragioneria; in poche parole non c'era argomento che lei non conoscesse.
Mio cognato Vinicio, di professione muratore; era un ottimo "mastro" che non aveva problemi per lavorare; tutti gli impresari edili conoscevano le sue doti e le sue qualità, quindi il lavoro non gli mancava.
I novelli sposi, Bruna e Vinicio abitavano con noi; avevano a disposizione la camera che era di Bruna. Di concerto babbo, mamma, Vinicio e Bruna, decisero di vivere come se fosse una sola famiglia, unificando pure le entrate, che venivano divise in due; considerato che a lavorare, con entrata economica, erano in tre, babbo, mamma e Vinicio.
Fu ritenuto che il lavoro in casa di Bruna e la mia collaborazione non potevano e non dovevano essere ignorati. Ecco perché decisero di dividere in due le entrate.
Fu deciso, pure, di cessare il commercio ambulante, a nome di mamma, e di prendere una licenza comunale per il commercio fisso di frutta e verdura.
Si prese in affitto, il locale, sito in via della Vittoria n. 8, oggi via San Bonaventura, di proprietà della famiglia Perugi, dove, infatti, iniziammo l'attività commerciale. Era un bel locale, aveva un bancone con il piano di marmo, rivestito con mattonelle bianche.
Aveva un retro bottega, che fu adibito a cucina; inoltre c'era un gabinetto, in un locale sotto la scalinata di accesso del n.10, dove abitavano: al primo piano il ragioniere Rino Lanzoni e ai piani superiori la famiglia Perugi.
L'iniziativa fu stimolata dal fatto che il Comune era entrato nell'ottica di eliminare le attività commerciali ambulanti, con postazione fissa, come era la nostra, prima in piazza Verdi, poi in piazza dell'Oca, oggi piazza della Vittoria, dove ci trasferimmo con l'autorizzazione da parte del Comune di Viterbo.
Gli affari iniziarono, con risultati discreti. Bruna ed io collaboravamo assiduamente nell'attività commerciale; mentre Vinicio e il babbo facevano il proprio lavoro.
Dopo un poco di tempo si decise di aprire un secondo negozio, per il commercio di frutta e verdura, in via Chiodaroli n.2, a nome di Vinicio, sotto la gestione di Bruna e mia, perché avevo smesso di studiare.
La predetta attività non dette i risultati sperati, prima di correre il rischio di andare in passivo, cessammo l'attività stessa perché, le entrate non compensavano i sacrifici di due persone, che lavoravano a tempo pieno.
Intanto Bruna e Vinicio "aspettavano", come del resto tutti noi, con gioia, la nascita di una creatura.
Il 2 gennaio 1951 "la cicogna", con la fattiva collaborazione dell'ostetrica Vera Ercolani Iacoponi, nell'appartamento di via del Paradiso, si fermò, lasciando un batuffolo di amore di maschietto.
Era nato Mauro Galeotti che da quel momento è stato per noi tutti un caro affettuoso figlio e nipote. Mi sentivo felice, ero uno zio, anche se portavo, ancora, i pantaloni alla zuava.
Mauro fu battezzato dal parroco della Chiesa di Santa Maria dell'Ellera, don Otello Ferrazzani.
Ricordo il bellissimo carrozzino, che i miei genitori acquistarono; sembrava un'auto fuori serie, era tutto di metallo bombato, di colore verde pisello.
Da quando andavo a scuola, alla raggiunta età di quindici anni, tanti ne avevo quando nacque Mauro, feci molti amici con i quali ho sempre tenuto ottimi rapporti che mi auguro di continuare a mantenere.
Della mia infanzia ho bei ricordi di vario genere. Proverò a raccontarne alcuni.
Una sera, penso del 1948, mi trovavo con il babbo in via San Egidio per prendere la legna da ardere che ci regalò un conoscente, che doveva liberare un locale.
Per il trasporto rimediammo, in prestito, un carrettino con due ruote.
Il tempo, per effettuare il carico, si protrasse fino all'ora che stava incominciando il passeggio lungo Corso Italia.
A carico effettuato il babbo legò il legname al carrettino ed io mi misi alle stanghe, alla guida del mezzo; mentre il babbo, con la sua forte mano lo tratteneva, nel tratto di discesa. Giunti su Corso Italia, il babbo tentò di prendere le stanghe dicendomi: “Cocco” che in umbro vuol dire caro, “vai avanti, ci vediamo a casa!”. Capii che il babbo non voleva farmi vedere dalla gente, o da qualche persona che conoscevo, mentre spingevo un carrettino.
La mia risposta fu immediata e sentita, cosa che ancora oggi, nel ricordala, mi commuove: "Babbo, vicino a voi non mi vergognerò mai, per me è motivo d'orgoglio farmi vedere che vi aiuto, poi questa legna scalderà anche me, quindi è giusto che io resti alle stanghe". Il nostro lavoro lo portammo a termine con tanta gioia perché i nostri cuori erano già stati riscaldati dai fatti e dalle parole.
Altri bei momenti, indimenticabili, che ho trascorso con il babbo sono quelli quando ci vedevano insieme durante le battute di caccia. Il babbo era un bravo tiratore sia a fermo che al volo, difficilmente sbagliava.
Una domenica, tutti noi, stavamo passeggiando lungo la strada Teverina, dove il traffico era quasi assente e la gente, ancora con le ferite della guerra nel cuore, non girava.
Ci fermammo in un cancello, sito a sinistra, direzione Viterbo-Celleno, dove è oggi un passaggio sulla ferrovia per andare a Villanova.
Ci mettemmo seduti sotto a due grossi pini, ad un certo momento sentimmo cinguettare tra i rami di una pianta, istintivamente, forse spinti dal fatto che il babbo aveva con se il fucile, ci mettemmo a guardare in alto.
Eravamo in cinque, solo io riuscii a vedere l'uccello e, mentre cercavo di far vedere al babbo dove era, lui mi disse: "Toh, prendi il fucile e sparagli".
Non me lo feci dire due volte.
Stavo seduto sopra un muretto, con a fianco il babbo, presi il fucile, misi sotto mira l'uccello e pumfete, cadde l'uccello, ma cadde pure il fucile dalle mie mani, perché ricevetti un sì forte rinculo che mi lasciò stordito.
La gioia fu tanta, era la prima volta che sparavo con il fucile da caccia, quel passero, sfortunato, fu la mia prima selvaggina abbattuta.
Con mio padre ho fatto varie battute di caccia anche se, con il trascorrere del tempo, il piacere di andare a caccia era solo quello di stare insieme, fare una bella colazione, respirare aria pura, camminare senza accorgersi di camminare, come diceva il babbo: "Con questo bastone in mano”, alludendo al fucile, “si fanno chilometri e non ci si stanca!". Aveva ragione, come del resto, ha avuto sempre ragione!
Solo ora mi viene in mente come il babbo imparò a fischiare.
Il suo fischio era un sibilo che si sentiva a distanza; metteva tra i denti, in un certo modo la lingua e giù, a tutti polmoni, fischiava.
Così mi raccontò, come imparò questo tipo di fischio: "Un giorno, avrò avuto otto o nove anni, nel buco di un tronco d'ulivo, avevo trovato un nido con le uova di un uccello che ogni tanto lo vedevo entrare quando andava a covare. Non vedevo l'ora che nascessero gli uccellini, avevo fatto i miei calcoli e preparato, con le mie mani, una bella gabbia di legno. Giunto il momento, che ritenni giusto, andai vicino all'ulivo, inserii la mano destra dentro il buco, dove era il nido, con lo scopo di prelevare gli uccellini. Sentii, non il contatto delle piume, ma qualcosa di viscido; fu un attimo, ritrassi il braccio e, contemporaneamente uscì, dal buco, un serpente che emetteva un sibilo. Spaventato, corsi via a debita distanza dal luogo, rallentai e mi misi a soffiare facendo, con le labbra e la lingua, un certo movimento perché volevo raccontare, al babbo, l'accaduto e mimargli il sibilo fatto dalla serpe.
Quando giunsi a casa, dalle mie labbra, uscì lo stesso fischio, come quello che faccio oggi".
Caro, amato, babbo quante volte siamo corsi al vostro richiamo; ricordate quella sera del 3 settembre, durante il trasporto della Macchina di Santa Rosa, quando piazza Verdi era gremita di persone ed altrettanto lo era il dintorno? Voi scommetteste, con un vostro amico, che sarebbe stato sufficiente un vostro fischio perché Bruna e Bruno giungessero, subito, vicino al chiosco, pur stando tra tanta gente festante.
Fischiaste, Bruna ed io, che eravamo tra la folla, giungemmo subito da voi.
Il vostro amico rimase a bocca aperta, mentre voi, soddisfatto gli diceste: "Hai visto?
I miei figli hanno un bel nome, per essere chiamati, ma quando serve, il fischio è più efficace".
Caro babbo sono tanti, tantissimi anni che mi manca quel caro fischio e, purtroppo, continuerà a mancarmi, ma forte è la speranza che un giorno, insieme, si possa sentire la "musica celeste", in compagnia di mamma, Bruna, Vinicio e tutti i nostri cari.
Il tempo, trascorreva, le cose andavano per il meglio, Mauro cresceva, in casa la serenità regnava ed io, che avevo sedici anni, iniziai, di nascosto dei miei, a "spippacchiare" qualche sigaretta, marca Macedonia.
Dell'anno 1952 ricordo due avvenimenti: il mio incidente stradale, ed il trasporto della Macchina di Santa Rosa, lungo via Guglielmo Marconi. L'unico e solo anno che fu fatto quel percorso, ma andiamo per ordine.
La sera del 30 agosto, già si sentiva il fragore della festa di Santa Rosa.
A piazzale Gramsci sostava il Luna park, in dispregio al fatto che a pochi metri era la Clinica Salus, dove erano persone degenti e sofferenti.
Abitavo in via Paradiso, n.16, alle ore 23 circa, di soppiatto, presi la bicicletta. Il babbo era andato a vedere uno spettacolo al circo equestre che si trovava in zona Pianoscarano. Bruna e Vinicio, erano in giro per Viterbo con loro figlio, mentre mamma, era in casa per accudire alle faccende, con tanto desiderio di potersi coricare al più presto.
Andai ai "giochi", mi fermai un attimo con gli amici, poi attratto da un interesse particolare, mi avviai, sempre con la bicicletta, lungo via Matteotti, giù verso la svolta con l'intento di immettermi sul Corso Italia ma, giunto alla "Svolta", sul punto di girare a destra, i freni, che avevo azionato, non risposero.
Fui violentemente proiettato contro la vetrina a muro, esistente sul lato destro dell'ingresso del negozio, sito in Corso Italia n. 119, di Italo Salcini, oggi gestito dal signor Mario Miani, con l'omonimo bar-caffè.
Fu un incidente tremendo! Grazie a Dio evitai di sfregiarmi, se non con altre più gravi conseguenze, solo perché ebbi l'istinto di mettere le mani davanti al volto.
Riportai varie ferite lacero contuse: alla mano sinistra, al braccio sinistro, alla spalla sinistra e alla coscia, nella zona trocanterica sinistra, con ritenzione di vetro. L'incidente ebbe una immediata grave conseguenza derivante da una grossa emorragia.
Mi fu raccontato che, al mattino, il proprietario del forno "Milanese" puliva il sangue sul selciato, davanti al locale, che si trovava in fondo alla via, dove è oggi un'agenzia di viaggi.
Ad incidente avvenuto, in stato confusionale, prima di perdere i sensi, sentii dire: "E' morto, è morto!". Mi è stato poi raccontato che a pronunciare questa frase fu Enrico Guidi, detto "Bocchettone" rivolto a "Putiferio", il gestore del bar che è all'inizio di via Marconi, verso piazza Verdi, ora gestito da altri conduttori.
Io ero in terra, qualcuno si avvicinò e, per mia fortuna, tra questi era la signora Teresa Turchetti la quale gridò: "E' morto! è morto 'sto c..., è vivo!, fermate quella macchina". In quel momento transitava il loco una Fiat 1400, nera che si fermò, mi caricarono sull'auto e fui trasportato alla Clinica Salus a Piazzale Gramsci.
Quando giungemmo nell'atrio della clinica, avevo ripreso conoscenza, sorretto, scesi e fui trasportato in sala operatoria dove mi furono messi, in totale, cinquantuno punti di sutura.
Nel momento in cui mi cucivano la coscia, si ruppe l'ago. Da un esame più attento il medico, alle prime armi, che precedentemente aveva informato dell'incidente il suo superiore, il professore Battaglia, si accorse che avevo dei pezzi di vetro dentro alla coscia.
Estrasse il vetro e pensò di guardare pure nella spalla e nelle altri parti dove ero ferito. Trovò, infatti, dei pezzetti di vetro, che estrasse.
Intanto mio padre, che ritornava a casa, passò alla "Svolta" e vide il sangue, riservato come era suo carattere, non chiese nulla, ma non fece a meno di rivolgere un pensiero allo sconosciuto infortunato chiedendo, per lui, un aiuto a Santa Rosa.
Intanto, un essere spregevole, che conoscevo e che non intendo nominare perché indegno di figurare su questo scritto, invece di andare nella sua abitazione, passò da casa mia, bussò, e fattosi riconoscere, disse a mia madre: "Voi eravate la mamma di Bruno?". A quelle parole la mamma rispose: "Come, ero la mamma di Bruno, sono la mamma di Bruno". Quel verme soggiunse: "Bruno è morto alla Svolta, l'hanno portato alla Clinica Salus."
La mamma, disperata, gridando, corse in clinica, dove la tranquillizzarono dicendole che ero solo ferito. Intanto il babbo giunse a casa e, dai vicini, fu informato del fatto.
Il babbo corse in clinica, ottenuto il permesso di entrare nel luogo dove mi stavano medicando, si avvicinò, strinse a sé il mio braccio destro sussurrandomi all'orecchio: "Prego tanto Santa Rosa che ti faccia guarire subito, per poterti dare un sacco di botte. Te lo avevo detto che la bicicletta aveva i freni non buoni!". Poi si abbassò e, con le sue labbra, bagnate dalle lacrime, sfiorò la mia carne, baciandomi.
Ricordo che i miei dovettero pagare una discreta somma per la prestazione medica fatta dalla clinica. Io per non aggravare la situazione l'indomani, con il consenso medico, feci ritorno a casa.
Il 3 settembre, i miei amici mi vollero con loro per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa, progettata dall'architetto Rodolfo Salcini che, per la prima volta, passò in via Marconi.
Una volta giunta al Sacrario, la Macchina doveva fare il ritorno verso la "Svolta", per poi procedere verso la Chiesa di Santa Rosa.
Io, abbondantemente ferito, ero al centro di un cerchio, formato da tutti miei amici, allo scopo di proteggermi da eventuali urti. Sebbene la ottima protezione un'ondata di pubblico, ruppe il cerchio ed io fui travolto, riportando la rottura dei punti che avevo nella spalla. Fui riportato in clinica, misero dei punti nuovi e: "Evviva Santa Rosa!", brindammo, con amici e famigliari alla festa.
I guai non finirono, il babbo pagò quanto dovuto per la sostituzione della vetrina, oltre ad una certa somma, che volle il titolare dell'attività commerciale, per danni, che aveva riportato a vari titoli.
I miei genitori avrebbero voluto ringraziare il proprietario dell'auto Fiat 1400, ma non gli fu detto il nome del mio soccorritore, perché lo stesso volle rimanere nell'anonimato.
Anonimato che è durato fino a quando, nel 1972 il mai dimenticato dottor Enzo Parenti, nella sua qualità di contribuente, venne in Comune all'Ufficio Tributi, dove ero direttore, per definire le sue pratiche dell'Imposta di famiglia.
Delicato come era, il dottor Parenti, parlò delle sue pratiche da concordare, che definimmo nel miglior modo che potevo fare e nella piena legalità.
Mentre il dottor Parenti si apprestava ad uscire, lo accompagnai alla porta e, nello stringermi la mano, mi disse: "Scusi direttore, ma lei, per caso, una ventina d'anni fa, ha avuto un incidente?". Non ci volle molto a capire, misi subito a fuoco l'episodio: mio incidente, trasporto in clinica con la Fiat 1400.
Alla risposta affermativa fece seguito un abbraccio che suggellò la mia, deferente,
amicizia ad una persona che ho sempre ricordato, per la quale pregai e mai finirò di dire: "Carissimo Enzo, grazie, grazie ancora!".
Altra persona che non dimenticherò mai, alla quale devo molto, è la signora Teresa Turchetti che, nel corso degli anni, ebbi modo di vedere spesso perché il fratello, signor Francesco, detto "Zi' Checco", abitava sullo stesso pianerottolo della nostra abitazione, in via Leonardo da Vinci n.17. La signora Teresa l'ho sempre chiamata, dall'incidente fino a quando il Signore l'ha presa con sé, Zia Teresa, alla quale ancora dico: "Zia Teresa, grazie, grazie... a lei devo la vita!".
Dicevo: i guai non finirono; sì non finirono, perché ebbi grossi problemi. Dopo sei mesi circa, grazie al dottor Cosimo Colasanti, ci accorgemmo che nella coscia, zona trocanterica sinistra, avevo una scheggia di cristallo di una mensola del peso di settanta grammi circa.
Passai un momento veramente, tremendo; avevo la gamba tutta nera, era piena di infezione. Fui ricoverato all'Ospedale Grande degli Infermi e sottoposto, dal professore Anacleto Cirenei, ad intervento chirurgico con rimozione del vetro e resezione della parte infetta. Inoltre, accertarono ed eseguirono un intervento chirurgico pure alla spalla sinistra per rimuovere pezzetti di vetro.
Il 1953 fu l'anno della mia iscrizione alla Democrazia Cristiana.
La domanda di iscrizione al Partito fu presentata con la firma di garanzia dell'onorevole professor Attilio Jozzelli, di cui, successivamente sono stato, per oltre due anni, suo segretario particolare, con reciproca soddisfazione. La segreteria era ubicata in via Matteotti n.50/D, scala B.
Dopo poco tempo, dalla mia iscrizione, fui chiamato, dagli organi del Partito, a far parte del Movimento Giovanile del quale ricordo solo il nomignolo del Delegato Provinciale tale Palletta e del Delegato Sezionale Rosato Rosati ed Aldo Morbidelli.
Per avere un quadro storico della nascita della Democrazia Cristiana viterbese, ritengo utile, necessario e doveroso, ricordare persone che ebbero un certo peso nella vita del Partito.
Sono: Cesare Lo Monaco, fratello del mio professore Michele, che è stato il primo Segretario Provinciale della D.C. a cui seguì, con lo stesso incarico Caliento, di Soriano nel Cimino che, con la fattiva operosità ostile dell'avvocato Gastone Filippi e del commendatore Vincenzo Bologna, fu indotto alle dimissioni, facendo spazio al professore Attilio Jozzelli di Orte Scalo.
Nel 1949, a livello locale, Segretario della D.C. era il ragioniere Gaetano Barili, dipendente del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo, del quale era presidente il commendator Ferdinando Micara. Oltre ai predetti era un fattivo rappresentante della D.C., il dottor Molini, dipendente della S.I.C.E.A, anch'egli amico, come Barili, di Micara.
Un giorno Barili, a Roma, incontrò, il ragioniere Mario Paternesi, che lo invitò a trasferirsi a Viterbo, per dare una mano, in seno alla Democrazia Cristiana.
Paternesi, che era in fase di nuova destinazione, giunse a Viterbo come Concessionario della Olivetti, con negozio in via Matteotti n. 20.
Dopo poco tempo, Mario Paternesi conobbe: Ferruccio Gatta e Mario Navas, i quali, in sede politica, assunsero un atteggiamento da fronda ostile a Gaetano Barili, chiedendo un appoggio politico a Paternesi.
Presto venne la goccia che fece traboccare il vaso.
In occasione di una assemblea sezionale, che si tenne in via dell'Orologio Vecchio n.34, presieduta da Barili, nella sua veste di Segretario sezionale, lo stesso tolse la parola a Gatta e a Navas, che non condividevano certe tesi di Barili, relative alla vita della Sezione.
Paternesi, in quell'occasione, condannò, con un applaudito intervento, l'operato di Barili, per aver tolto la parola a due iscritti. L'assemblea fu solidale con Mario Paternesi e da quel momento fu rivoluzionata la vita del Partito, con nuove idee, programmi e, tanta, tanta operosità.
Anche il Comitato Civico, del quale era a capo Fausto Mari e l'Azione Cattolica, sotto la direzione del dottor Poscia, condivisero l'operato di Mario Paternesi, apprezzando il suo lavoro e, in certe occasioni, affiancando le attività dello stesso.
Come ogni medaglia ha il suo rovescio, così fu nella D.C. viterbese; ci furono delle forze collaterali alla politica che non condivisero l'operato di Mario Paternesi, solo per il fatto che egli non era Viterbese. Come contraltare a Paternesi fu caldeggiata la nomina, a Segretario Politico della Sezione, del professore Tommaso Farisei, mentre Paternesi fu nominato Vice Segretario Politico e Segretario Organizzativo; carica che tenne fino al 1953.
Nell'aria ancora si sentiva il risultato delle elezioni politiche del '48. L'abilità dell'onorevole Alcide De Gasperi dette una certa serenità al Popolo italiano che vedeva, nel Partito Comunista Italiano, un nemico acceso della religione e della libertà.
Ricordo un manifesto diffuso dalla Curia vescovile di Piacenza, nel quale era scritto: "DOPO IL DECRETO DEL SANTO UFFIZIO - AVVISO - E' peccato grave:
1° Iscriversi al Partito Comunista.
2° Favorirlo in qualsiasi modo, specie nel voto.
3° Leggere la stampa comunista.
4° Propagare la stampa comunista. Quindi non si può ricevere l'assoluzione se non si è pentiti e fermamente disposti a non commetterlo più.
Chi iscritto o no al Partito Comunista, ne ammette la dottrina marxista, atea ed anticristiana e ne fa propaganda, è APOSTATA DALLA FEDE E SCOMUNICATO e non può essere assolto che dalla Santa Sede. Quanto si è detto per il Partito Comunista deve estendersi agli altri Partiti che fanno causa comune con esso.
Il Signore illumini e conceda ai colpevoli in materia tanto grave, il pieno ravvedimento, poiché è in pericolo la stessa salvezza dell'eternità".
Quello era il clima che aleggiava sulle nostre teste.
Nella D.C. viterbese era necessario un fermento di modernismo.
Spuntava la figura politica del professor Attilio Jozzelli, molto amico di monsignor Leopoldo Venturini di Capodimonte.
La presenta di Jozzelli creò il dualismo Jozzelli-Micara per le elezioni alla Camera dei Deputati. Viterbo capoluogo era per Micara, mentre la provincia era per Jozzelli, ciò causò uno sbandamento della D.C., che indusse Farisei alle dimissioni, lasciando campo libero a Mario Paternesi, che si mise alla guida di un Partito che andava alla deriva.
Grazie a Mario Paternesi, fu raggiunto un accordo con l'avvocato Vincenzo Ludovisi allo scopo di poter garantire una vita amministrativa comunale intesa a ricostruire Viterbo. Quindi si ebbe la necessità di inserire nuove forze politiche con nuovi uomini fra i quali: il dottor Giuseppe Benigni, l'insegnante Nazzareno Capoccioni, gli odontotecnici Santino Clementi e Gino Pierini.
Successivamente entrarono, quali consiglieri comunali, altri due amici; i cavalieri Giovanni Cardoni e Ferruccio Gatta.
Amministrare non significava solo gestire i Comuni o la Provincia, significava gestire tutti gli enti pubblici, fra i quali gli ospedali pubblici.
L'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo era amministrato dal commissario prefettizio, dottor Samaritani, nominato dal prefetto dottor Joannin.
A Viterbo fu il ragionier Paternesi a portare una folata di modernismo; tutti furono d'accordo sulla sua nomina a presidente dell'Ospedale Grande degli Infermi del quale è stato, per anni, il motore trainante, con risultati eccellenti, sia per gli ammalati che per i dipendenti e tutta la collettività che vedeva, nell'Ente ospedaliero, una struttura valida e funzionante. All'Ospedale di Viterbo esistevano solo due reparti: Chirurgia e Medicina. Paternesi fece in modo che si aprissero i reparti di Radiologia, Ostetricia, Pediatria e Cardiologia.
Inoltre, fu stipulata una convenzione con gli Ospedali di Roma e Siena per le specializzazioni di Medicina e di Chirurgia.
Successivamente fu trasferito, in altra sede, il cronicario, con la conseguente utilizzazione dei locali, per altre strutture sanitarie.
L'onorevole Attilio Jozzelli vedeva di buon occhio quello che faceva Mario Paternesi perché portava nella città un tocco da vero imprenditore.
La sua prestigiosa personalità era conosciuta quale capo della Democrazia Cristiana
viterbese.
La sede del Comitato provinciale della D.C., era in via San Marco n.6; segretario era il professor Gilberto Pietrella; fu proprio in quel periodo che la Direzionale nazionale del Partito, di cui era segretario l'onorevole Amintore Fanfani, inviò a Viterbo, quale funzionario, Saverio Binelli che volle fosse costituito il Comitato comunale della D.C., stante il fatto che sul territorio viterbese operavano varie sezioni del Partito.
A Segretario comunale, della D.C. viterbese, fu chiamato Mario Paternesi. Ci fu una frangia di Democratici cristiani, vicini all'Azione Cattolica, che prese atteggiamenti ostili al Comitato comunale; tutto era basato sul fatto che volevano dare un po' di potere a persone a loro vicine. Si decise di aprire altre sezioni della Democrazia Cristiana.
La campagna elettorale, per le elezioni politiche del 1953, l'ho vissuta in prima persona. C'era veramente fede politica e non interesse economico come, purtroppo, da un po' di tempo a questa parte, solo questo si nota.
Si faceva campagna elettorale per tre candidati, perché le preferenze, che si potevano esprimere erano quattro, ma per serietà politica, se ne segnalavano tre e, a volte, anche due. Non si poteva togliere all'elettore la possibilità di votare per chi voleva, all'infuori delle segnalazioni del Partito, che erano veramente ascoltate.
Io sostenevo, come la maggioranza dei d.c. viterbesi: Giulio Andreotti col n.1, che aveva come valente segretaria la signora Muzi, già segretaria di Pavolini; Paolo Bonomi n.2 e Attilio Jozzelli n.10, anche se in lista era pure Ferdinando Micara.
Altri candidati che gravitavano su Viterbo erano: Folchi, Simonacci, Darida, Pennacchini, Evangelisti, prima e poi Sbardella del gruppo Andreottiano.
I primi tre ebbero, sempre, un suffragio di voti. Andreotti, mio caro amico, era il numero uno in tutto e per tutto; Bonomi, era il Segretario nazionale della Coltivatori Diretti, mentre Attilio Jozzelli era il candidato di Viterbo, perché Viterbese di Orte, che abitava a Viterbo, prima in via della Vittoria, poi in via Zara n.70.
Ricordo che quando ero il segretario dell'onorevole Jozzelli ebbi l'incarico di fare visita in tutti i paesi della Provincia per prendere contatti con sindaci, consiglieri comunali d.c., segretari di sezione, parroci e dove era la sede vescovile, dovevo prendere contatti pure con il vescovo. Naturalmente non dovevo escludere dalle mie visite, i monasteri di frati e suore. C'era da lavorare a volontà!
Quando dovevo dare qualche contributo, a vario titolo, mi sono fatto sempre rilasciare la ricevuta allo scopo di operare, alla luce del giorno, con onestà.
All'età di diciotto anni fui inviato, dal comitato provinciale della D.C., a presiedere un'assemblea di soci a Corchiano.
Giunsi al paese con la Lambretta, mi fermai in piazza e chiesi di parlare con il segretario di sezione nella persona del signor Meconi; ci incontrammo, ci fu uno scambio di parole, ma io non dissi che ero il presidente dell'assemblea perché mi vergognavo.
Ad un certo momento, visto che il locale della sezione era gremito di iscritti, con voce sommessa, dissi: “Iniziamo?”. Meconi replicò: "Dobbiamo aspettare l'oratore ufficiale del Comitato provinciale", a questo punto dovetti presentarmi, non come avevo fatto, dicendo nome e cognome, dovetti aggiungere che ero io il presidente dell'assemblea, designato da Viterbo.
Ci fu un attimo di esitazione, entrammo in sezione e mi misi seduto al centro del tavolo di presidenza con a fianco il sindaco e il segretario di sezione.
L'assemblea, nel momento in cui fui presentato, fece un lungo applauso; portai il saluto della D.C. provinciale, dissi quattro parole sul regolamento per lo svolgimento delle assemblee sezionali e conclusi il mio compito parlando dell'anticomunismo e su certe opere che erano programmate per Corchiano.
Ricordo che gli amici mi trattennero a mangiare dell'ottima “paglia e fieno” con una squisita porchetta. Verso le ore una di notte, in Lambretta, presi la strada del ritorno.
Ero felice, mi sentii, utile e importante, ma non fu così per i miei genitori, che mi attendevano in finestra. Però, quando raccontai il tutto, anche babbo e mamma, furono contenti.
Dopo molti anni, quando ero il direttore dell'Ufficio tributi del Comune di Viterbo ebbi, come impiegato una bravissima persona di Corchiano, Giuseppe Rita, che si ricordava di me.
La campagna elettorale si svolgeva in vari modi: con comizi in piazza, dibattiti, giornali parlati, affissione di manifesti sui muri delle abitazioni; a volte si procedeva alla copertura di altri manifesti o addirittura si attaccavano più in alto degli altri.
Altro valido sistema, di propaganda elettorale, era il volantinaggio o la propaganda rumorosa che consisteva nel fissare gli altoparlanti sul tetto dell'automobile e girare per la città invitando il cittadino a votare per tizio o caio.
Ricordo che, spesse volte, di notte, ci si incontrava con gruppi di altri partiti con i quali avvenivano scambi verbali, poco amichevoli. Comunque io posso ben dire che mi sono comportato sempre bene e sono stato sempre rispettato dalle opposizioni, perché rispettavo gli altri. Quindi tutto andava bene se c'era il reciproco rispetto.
Di campagne elettorali ne ho fatte tante, tra quelle politiche, provinciali e comunali si stava sempre a votare.
Un anno, ricordo che il Partito Comunista Italiano, per mano del compianto, grande amico, Domenico Boccolini, detto Memmo, fece disegnare, in piazza del Plebiscito, una grande falce e martello.
Era veramente un capolavoro; sia ben chiaro parlo del disegno e non del valore politico!
Io, nel contempo, stavo, con i miei collaboratori in altra parte della città, più precisamente, in piazzale Gramsci dove con lunghe scale, buoni pennelli e calce bianca, disegnammo scudi crociati alti circa quattro metri e larghi due metri e mezzo. Fu, secondo me, veramente un capolavoro, sia nel disegno che nel valore politico!
Verso le ore tre, con i miei amici pensammo di fare un tiro sinistro al Partito Comunista, scrivemmo, vicino alla falce e martello disegnata in piazza del Comune: "COSI' SI VOTAVA IN UNGHERIA".
Mentre ci rallegravamo della bravura fatta; ci comunicarono che in piazzale Gramsci, verso le ore quattro, i comunisti avevano scritto nei quattro spazi vuoti intorno alla croce dello scudo crociato, che avevamo poco prima disegnato, la parola "FAME".
Ci cadde una tegola in testa. Mentre ci avviavamo verso via Matteotti, percorrendo Corso Italia, alla Svolta, incontrammo Memmo con i suoi amici.
Ci parlammo, ammettendo reciprocamente ciò che avevamo fatto. Fu una risata collettiva, non litigammo anzi, unimmo i soldi che avevamo. Memmo, diceva che erano dell'avvocato Morvidi ed io, dissi che quanto avevo erano dell'onorevole Jozzelli. Fatta una certa somma, andammo a Porta Romana, nel bar dell'AGIP e, tra una risata e una sigaretta, mangiammo e bevemmo alla salute di tutti. Ci salutammo ed ognuno prese la strada della propria casa.
Quando giungemmo a Porta Fiorentina, dove lasciammo dietro la pesa pubblica le scale e i secchi con la vernice; mi venne pensato di ritoccare la scritta "FAME" trasformandola in una parola che si addiceva alla Democrazia Cristiana, ossia, "PANE".
Detto e fatto: con due colpi di pennello chiusi la effe poi modificammo la emme in enne.
Giunse il mattino, soddisfatti e contenti del bel lavoro andammo a casa. Al risveglio venni a conoscenza che i fatti della nottata ebbero vasta eco.
Gli scudi crociati disegnati sulle mura castellane con la scritta PANE, sono stati letti dai Viterbesi per molti anni... la vernice fu buona e il significato è stato foriero di fortune politiche e benessere per gli Italiani.
Come dicevo ho fatto tante campagne elettorali con i miei fedeli amici, che poi chiamavo "la squadra"; con loro ne combinavamo di tutti i colori.
Un giorno doveva venire a Viterbo il sottosegretario agli Interni, onorevole Mazza.
Ebbi l'incarico di preparare una buona accoglienza visiva. Ordinammo e affiggemmo molti manifesti con le scritte: VIVA l'On/le MAZZA; BENVENUTO On/le MAZZA; VITERBO SALUTA l'On/le MAZZA.
Per gli avversari politici fu facile sminuire e annullare il significato del nostro saluto, infatti, scrissero: "BU BU" al termine di ogni "MAZZA" che divenne così "MAZZA BU BU".
Quella volta mi incavolai, non tanto per quanto era stato fatto sui manifesti, ma litigai a brutto muso con dei tipi che la politica la facevano solo con l'arroganza e il manganello.
Quando, in compagnia di Mario Savelli, arrivai sulla Cimina, dove erano affissi i manifesti, fui aggredito verbalmente da quattro elementi che tentarono anche di mettermi le mani addosso; feci appena in tempo ad aprire il cofano dell'auto e prendere il crick con il quale affrontai gli energumeni che, vista la mia reazione, se la dettero a gambe.
Il termine della campagna elettorale era alle ore 24, nell'ultima ora accadevano cose da pazzi perché, da quel momento, non si potevano più attaccare manifesti, né fare propaganda rumorosa.
L'interesse di molti era che, dopo mezzanotte, risultassero affissi i manifesti del proprio candidato.
Io, con la mia squadra, di concerto con gli organi del Partito, decidemmo che, nell'ultima ora, i manifesti che dovevamo affiggere, dovevano essere solo, quelli raffigurante lo scudo crociato e non fare la lotta per attaccare manifesti reclamizzanti tizio o caio.
Dopo la mezzanotte intervenivano le forze dell'ordine che contravvenzionavano coloro che disattendevano tale disposizione. All'epoca era consentito coprire altri manifesti.
Ricordo una notte, allo scadere del termine fissato dalla legge, eravamo a fare la battaglia della carta, cioè attaccavamo i manifesti nel senso voluto. A piazzale Gramsci trovammo tre persone al comando di una signora, moglie del candidato d.c. Giorgio Magnani che, contrariamente a quanto concordato in sede politica, attaccava i manifesti reclamizzanti il nome del marito.
A pochi metri era la Polizia; noi non potevamo fare altro che coprire, con lo Scudo crociato il manifesto che la signora faceva affiggere; lei faceva altrettanto copriva con il manifesto del marito, i nostri.
Ad un certo momento si formò uno spessore tale che i manifesti scivolarono tutti in terra. Un mio collaboratore fu così veloce che attaccò, senza passare la colla, un manifesto con lo Scudo crociato, mettendolo però, per la fretta, capovolto. Non ci fu il tempo materiale di sistemarlo, scoccarono le ore 24 e da quel momento non si poteva fare più nulla. La Polizia, attenta, controllava!
Le vittorie politiche si susseguivano anche se c'erano delle flessioni.
La presenza di un partito solido, come la D.C., favorì la ripresa dell'ascesa di altri piccoli partiti, come il Partito Liberale Italiano, il Partito Repubblicano Italiano e il Partito Socialista Democratico Italiano, con i quali, al Comune, aprì un discorso politico amministrativo per la gestione del Palazzo dei Priori formando una coalizione di centro. Ricordo che spesso mi capitava di far parte alle delegazioni che andavano a trattare con altri partiti.
Ne ricordo, per esempio, una delle prime. Andammo a trattare con i rappresentanti del Partito Repubblicano Italiano nelle persone dell'avvocato Battaglia, del cavalier Duilio Mainella, che mi accolsero con tanta simpatia; in quell'occasione conobbi il ragionier Domenico Mancinelli; avevamo le nostre mamme che erano amiche perché esercitavano lo stesso tipo di commercio.
La conoscenza di Domenico Mancinelli detto affettuosamente "picchio e palla"; probabilmente perché quando giocava al biliardo a boccetta, nel dichiarare il tiro diceva quella frase; mi fece avvicinare al sindacato della CISL, che aveva sede in via Mazzini, 71, di cui Mancinelli era il rappresentante della FILCA, incarico che successivamente, verbalmente, dettero a me e che lo tenni per breve tempo perché la politica mi attraeva più del sindacato.
Dal mio professore, Michele Lo Monaco, mi fu presentata una persona, che poi seppi essere un odontotecnico, che si chiamava Santino Clementi, il quale aspirava concorrere quale consigliere al Comune di Viterbo. All'inizio ebbi poca simpatia verso di lui, poi, frequentandola a causa di un malaugurato mal di denti, potei apprezzare la sua modestia.
Non mi sbilanciai nel promettere aiuto, il tempo mi avrebbe consigliato il da farsi. Diventammo amici, politicamente inseparabili. Ho intrapreso per lui varie campagne elettorali di cui, con poco entusiasmo, ne parlerò appresso.
Una persona che, a mio parere, merita essere ricordata per la sua operosità è il commendatore Carlo Minciotti, a cui si deve molto per la ricostruzione di Viterbo; fu vice sindaco al Comune di Viterbo, con il sindaco avvocato Felice Mignone, poi presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Viterbo, fino a quando subentrò a lui l'avvocato Gastone Filippi. Penso che l'unico ex amministratore comunale, a cui è stata, meritatamente, intestata una via, sia proprio il compianto commendator Carlo Minciotti, a cui va il mio caro ricordo.
Voglio raccontare un episodio che mi è tornato alla mente per il solo fatto che giorni addietro ho incontrato il professore Corrado Buzzi, già assessore comunale, in rappresentanza del P.L.I.
Il posto che occupava l'emblema del Partito, nella scheda elettorale e nei manifesti, era lo stesso della presentazione della lista elettorale in Comune. Il giorno che scadeva la presentazione delle liste, ci fu un duello tra Buzzi ed il sottoscritto; stava per scadere il termine, il segretario iniziò a contare partendo da cinque verso lo zero. Furono momenti palpitanti, entro le ore 12, le liste dovevano essere depositate sul tavolo; mancava un secondo alla scadenza; gettammo i plichi stando con i piedi fuori della segreteria; il mio plico cadde sopra a quello di Buzzi, quindi la lista di Buzzi toccò il tavolino prima della mia, quindi io arrivai ultimo; avevo vinto il duello al quale assistettero, trepidanti, molti cittadini.
Nel corso dell'anno i miei genitori mi consentirono di trascorre le vacanze a Gubbio; fu una esperienza magnifica, a cominciare dal viaggio, alla permanenza in casa di nonna Assunta e zio Emilio, sempre affettuosi e cari.
Non da meno erano gli altri zii, dallo zio Ubaldo, zio Dante, zio Peppino e zia Peppina con le relative famiglie ed in particolare con zia Letizia.
A proposito della zia Letizia, sorella del babbo, voglio raccontare quanto segue.
La zia mi invitò a pranzo nella sua piccola abitazione, mi fece un ottimo pranzo a base di pastasciutta fatta in casa, piccioncini, bistecche e con ottime castagnole con il miele.
Seppi, poi, che, per procurarsi il miele, fece a piedi una decina di chilometri per andare a prenderlo dalla sua cugina Santina.
Oggi, cara zia Letizia, l'unica cosa che posso fare per te è pregare e venirti a trovare al Cimitero di San Lazzaro. Sei qui grazie all'affetto della mamma e del babbo, che hanno fatto sì che da Gubbio, dove sei deceduta il 25 dicembre 1969, fosti traslata a Viterbo dove ora riposi nella pace del Signore.
A Gubbio trascorsi oltre un mese tra l'affetto di tutti e il corteggiamento di belle bambine. Intanto in famiglia si ritenne utile acquistare dai signori Petroselli, genitori di Vittorio, titolare del bar in piazza della Vittoria, la licenza di commercio per la vendita al minuto di frutta e verdura in via della Cava n.3.
Era una attività che aveva un certo avviamento commerciale, perché i signori Petroselli la gestivano da molti anni. L'esercizio commerciale fu curato da Bruna e da me per un certo periodo, tanto per non stare in ozio.
Le giornate le trascorrevo tra l'affetto infinito e contraccambiato di mamma, babbo, Bruna, Vinicio e il piccolo Mauro. Appena pranzato andavo al bar Petroselli detto "la kasbah", dove era una bellissima sala biliardi, sotto il controllo dell'americano.
Il gioco che mi affascinava, e non ero uno dei peggiori, era la boccetta e l'Italiana con la stecca. Miei compagni di gioco erano, normalmente, Elio Fontana e Giorgio Proietti.
Spesso si facevano scampagnate con amiche che allietavano la nostra età, ricevendo in cambio un'amicizia sincera e disinteressata. Quasi tutte le domeniche organizzavamo feste da ballo che, a turno, si tenevano nelle nostre abitazioni.
Dal signor Galliano Lorenzini, con negozio al n. 4 di via della Vittoria, si acquistava il Vermouth o la Marsala; dal pasticcere si compravano le paste che, durante la pausa del ballo, servivano per fare bisboccia. La spesa veniva divisa, in parti uguali, fra i maschi; le donne erano gradite ospiti.
Durante gli incontri sbocciavano amori e simpatie fra i quali tre o quattro coppie sono giunte al matrimonio. Ballare era la mia passione, i balli che maggiormente gradivo erano il valzer, la polka e il tango.
A volte, con l'auto Augusta, di proprietà del signor Orlando, padre di Emanuele Filiberto Pace, che la prendeva di nascosto, facevamo escursioni in provincia.
Una sera che pioveva a dirotto, venivamo da Vetralla, verso Ponte di Cetti due carabinieri in bicicletta, bagnati come pesci, ci fermarono, uno dei due, con una lampada tascabile, tentò di vedere i nostri volti, ci riconobbe dicendo: "Ah, vi vedo spesso dalla zia", fu una risata generale. Uno di noi girò la lampada verso il volto del carabiniere e riconosciutolo, calorosamente lo salutammo.
Un'altra domenica avevamo l'intenzione di fare una gita, sempre con la macchina di Pace che era posteggiata sul piazzale del Paradiso, lui abitava al n.16.
Con Filiberto, oggi stimato medico, andammo per prendere, la macchina, ma ci accorgemmo che il padre aveva tolto la batteria; non ci demmo però per sconfitti, rimediammo una batteria, che prendemmo nel garage, dove mio padre teneva la Topolino. Sistemata la batteria andammo a Soriano nel Cimino ma, nell'abbordare una curva, la macchina sbandò, facendo testa coda. La parte posteriore andò a sbattere contro il muretto del ponte, per fortuna la macchina riportò solo una piccola ammaccatura.
Un Venerdì Santo partimmo, a piedi, da Viterbo e andammo a Bagnaia per vedere la processione del Cristo Morto. Il gruppo era così composto: Elio Fontana, Mario Laurenti, Gabriele Mancinelli, detto Lello, Mario Mancinelli, detto Ciccio, Dino Massi, Giulio Municchi, Giorgio Proietti, Giacomo Scarsella ed io; quella sera mancava Angelo Petroselli.
A Bagnaia quasi tutti mangiarono la porchetta e bevvero vino; io e qualcun altro, che ci tenevamo al rispetto della vigilia, mangiammo uova sode e lupini; per bere, non gradimmo il vino, ma una gassosa, nella caratteristica bottiglietta con il tappo a pressione. E' comprensibile il fatto che dopo aver assistito al passaggio della processione siano volati dei complimenti verso le belle Bagnaiole.
La cosa non fu gradita ai Bagnaioli, i quali ci attesero sul ponte impedendoci di attraversarlo.
Le soluzioni erano due: o saltare il ponte, ma non era "consigliabile", o rimboccarci le maniche e affrontare i Bagnaioli.
La lucidità, di chi non aveva bevuto vino, riuscì a far calmare i bollenti spiriti dei Bagnaioli, facendogli capire che noi si andava a Bagnaia una o due volte l'anno; mentre loro dovevano venire a Viterbo, per lavoro o per studio, tutti i giorni, quindi una loro aggressione contro di noi, sarebbe equivalsa a cento nostre aggressioni contro di loro.
Tutto filò liscio, fino a quando Giorgio, che credeva essere un uccello, gridando: "cip cip cip" voleva volare dal ponte. Fui svelto come un fulmine, presi Giorgio, che stava in piedi sul parapetto del ponte, e lo trattenni; evitai così una sicura tragedia.
Come pure guai ci furono dati da Giacomo che, per fargli smaltire la sbornia, alla Quercia, lo immergemmo dentro la fontana.
Giunti a Viterbo, si poneva il problema di accompagnare a casa, chi non era in grado di farlo da solo. Accompagnammo Giorgio in via Chiusa, lo appoggiammo alla porta, bussammo e scappammo via. Il signor Eugenio, padre di Giorgio, aprì la porta, noi sentimmo che Giorgio, avendo veduto sul tavolo una bottiglia di vino gridava: "I bino... i bino!". Accertato che Giorgio era in buone mani, andammo via di corsa.
Arrivati all'altezza del palazzo Mancinelli, in prossimità dell'abitazione di Laurenti, ci accorgemmo che all'appello mancavano due persone, Lello e Mario Laurenti che ritrovammo dentro lo scavo delle fondamenta di un palazzo in costruzione che ora fa angolo tra via Postumia e via Vicenza.
Tutto fu bello, tanto che ancora oggi, nel ricordare i fatti, un sorriso di rimpianto è vivo nei nostri volti; come è vivo, nel mio cuore, il ricordo di tutti, tutti i miei cari amici.
A proposito, dell'automobile del babbo voglio raccontare un fatto che è rimasto nel mio cuore, come lo fu in quello dei miei famigliari. C'è da premettere che, quando l'auto Topolino del babbo era in movimento, era difficile, per non dire impossibile inserire la prima marcia; c'è da tenere conto che le marce non erano sincronizzate come quelle attuali.
Una domenica a bordo della stessa era tutta la famiglia, eccetto me, che ero con gli amici; quindi, in tutto, erano quattro adulti ed un bambino di circa tre anni.
La destinazione di quel giorno, per la mia famiglia, era Bolsena passando da Montefiascone.
L'auto, alla guida del babbo procedeva, di qualche decina di metri, avanti al pullman della Società Garbini, diretto a Montefiascone, guidato dall'amico del babbo, Giovannino Di Francesco che sapeva della difficoltà, che aveva il babbo, di ingranare la prima marcia, stando in movimento. Giunti alle falde di Montefiascone il babbo, proseguì diretto verso la salita che termina davanti all'Albergo Italia.
Giovannino rallentò la corsa del pullman, pensando che il babbo si sarebbe dovuto fermare, a causa della difficoltà accennata e della ripidezza della strada, oltre al carico che era sull'auto.
Mentre il motore perdeva i giri, il babbo, con decisione ed una doppia debraiata, inserì la prima e, con uno scossone, tra la meraviglia di Giovannino e di tutti i passeggeri del pullman, continuò il suo andare, soddisfatto della prestazione della sua fedele Topolino.
Ci si avvicinava all'anno 1955, Bruna, ed io iniziammo a pensare che, a febbraio, ricorreva il 25° anniversario del matrimonio dei nostri genitori, cioè sarebbe stata la ricorrenza delle nozze d'argento.
Pretendemmo, che babbo e mamma festeggiassero quella data con una visita a Santa Rosa, un bel pranzo ed un viaggio a Gubbio, con la Topolino, accompagnati dal nipotino Mauro che aveva quattro anni.
Furono fatti pensierini ai nostri genitori. Io certo di fare loro cosa gradita, promisi che mi sarei rimesso a studiare per conseguire il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
Non per disprezzare gli altri doni penso che quello mio, sia stato per loro, ma anche per Bruna e Vinicio, il migliore.
Giunse l'8 febbraio, facemmo festa, salutammo gli sposi, che partirono per una quindicina di giorni. Intanto Bruna gestiva il negozio di via della Vittoria ed io quello di via della Cava, mentre Vinicio continuava a fare il suo lavoro.
Tutto procedeva in sereno accordo, perché tra noi c'è sempre stato tanto, tanto affetto.
Ritornati gli sposi feci dei sondaggi per sapere cosa avrei dovuto studiare e cosa avrei dovuto fare per essere ammesso al IV Ragioneria; sì perché volevo tentare il salto triplo.
Fui sconsigliato a tentare l'ammissione al IV Ragioneria; mi consigliarono di andare tranquillo per l'ammissione alla III classe perché sarebbe stato come se i due anni di Tecnica fossero sostitutivi alle due classi del "Paolo Savi".
La prima cosa che dovetti fare, fu quella di trovare un insegnante di latino perché, per accedere al Ragioneria, necessitava sostenere un esame integrativo di latino perché all'Avviamento non era previsto come materia di studio.
Per il latino andai dalla professoressa Marianna Sorbello, che abitava in strada Cimina; altre lezioni, per essere in grado di sostenere un esame in una scuola che non conoscevo, le presi, per chimica, dal professore Salvatore Battaglini, che abitava in via del Suffragio, tuttora mio carissimo amico; per ragioneria e matematica, dal professore Ferdinando Montemari, che abitava in piazza Vittorio Veneto, più che insegnante era un caro amico, che ora gode la luce di Dio; per diritto dal professore Massimiliano Montanaro, che abitava in via Saffi, per la lingua inglese dal professore Filelfo Paccosi, che abitava in via delle Mura. Per le altre materie studiavo da solo, per esempio per la lingua italiana era sufficiente ripetere quello che la professoressa Luigia Giglio Donati ci aveva insegnato alla Scuola Francesco Orioli.
Studiai, studiai tanto come, tanto fu l'aiuto che mi dettero i miei genitori nel mandarmi a lezione, che costava brave lire. Prima degli esami, su loro insistenza, vollero mandarmi, per una "rinfrescata", a lezione d'italiano, dal professor Mantovani, che abitava in via Sant'Agostino.
Arrivò il giorno degli esami; mi presentai sicuro di essere ammesso alla frequenza della III classe, insieme all'amico Vincenzo Bruzziches. Infatti, fu proprio così, fui ammesso alla frequenza del III Ragioneria, Sezione C, la mitica sezione C, che è rimasta nei cuori di tutti gli studenti e dei professori, con i quali ancora, ci vediamo e ci incontriamo a tavola, per rinverdire i nostri ricordi e le birbonate fatte.
Il mio arrivo al "Paolo Savi", fu oggetto di una particolare, meditata attenzione da parte dei docenti. Questo mi riferì il professore Ferdinando Montemari: "Pur non conoscendoti, hanno avuto sentore della tua personalità, per non dire 'fama', relativamente ai rapporti con le compagne di scuola e, addirittura, hanno alluso ad una particolare simpatia che avrebbe una professoressa nei tuoi riguardi la quale ha avuto una discussione con una collega, che propendeva per te".
Ciò giocava sfavorevolmente alla mia posizione scolastica. Con buoni propositi e tanta volontà iniziai l'anno scolastico con i professori: Elena Duca, italiano e storia; Ferdinando Montemari, ragioneria e tecnica; Antonino Rositani, matematica; Mario De Faccendis, diritto; Salvatore Battaglini, chimica e merceologia; Lia Sperapani, geografia economica; Elsa Vannucci, inglese; Gabriello Currò, educazione fisica; don Pietro Frare, religione. preside dell'Istituto Tecnico Commerciale "Paolo Savi" era il professor Adolfo Speranza, che mi prese a benvolere, come diceva lui, "sebbene il biglietto da visita che avevi quando sei arrivato". Vice preside era Gabriello Currò, che era un trascinatore ginnico, che portò l'Istituto, per tanti anni, ad essere il primo della provincia.
La classe era così composta e rimase tale fino al 1958, data del diploma: Luigi Alunni, Mario Barbati, Sergio Bastiani, Giancarlo Bettini, Valentino Brunori, Quintilio Capati, Giovanni Colla, Guido Crisanti, Pompeo Di Andrea, Francesco Felli, Bruno Gregni, Franco Iovenitti, Bruno Matteacci, Antonio Mattei, Francesco Miceli, Riccardo Migani, Mario Minissi, Arnaldo Moneta, Vittorio Pannucci, Paolo Pantalei, Pietro Pezzato, Giancarlo Ricci, Ciro Rufino, Giorgio Ruggeri, Emilio Santini, Giuseppe Sirena, Giorgio Taurchini, Carlo Alberto Toniolo. Mio compagno di banco era Sergio Bastiani.
In quel periodo, Vinicio e Bruna, acquistarono, dal commerciante Vittorio Ranaldi, con negozio in via Matteotti, una bellissima motocicletta Parilla 175 cc. "Paperina" di colore nero con il serbatoio rosso. Era uno spettacolo!
Quando la vidi, nel retro-bottega, impazzii di gioia, Bruna disse: "Gli hai fatto tante feste, come se fosse la tua..., ma è anche la tua, vero Vini?" Mio cognato, Vinicio, annuì e quando la moto non gli serviva per andare al lavoro, mi consentiva di usarla. Ricordo che qualche mattina andavo a scuola con la moto, tutti venivano intorno per vederla; era una cosa magnifica!
Vinicio, con alcuni amici, prese dei lavori a Montalto di Castro, nella zona dell'Ente Maremma; ogni tanto Bruna voleva portargli il pranzo; ricordo che gli cucinava dei piatti prelibati, che gli portavamo con la moto: univo l'utile al dilettevole.
Anche se all'epoca non era obbligatorio indossare il casco, ne avevamo uno rigido di colore rosso e nero che indossavo io, con un bel paio di occhiali e un paio di guanti da corridore e gli immancabili stivaletti. Mi si creda, si era giunti all'assurdo, Vinicio mi diceva: "Ti serve la motocicletta?". Logicamente la risposta era sempre negativa, ma lui faceva in modo che anch'io godessi dell'uso della Parilla.
Ricordo che la moto aveva il tubo di scappamento a destra, ogni tanto dovevo cambiare la marmitta perché quando abbordavo le curve strisciava per terra.
Alla domenica si andava al mare, mamma, babbo, Vinicio e Mauro partivano al mattino, con la Fiat Topolino, portando il pranzo e quanto necessario; mentre Bruna ed io, che tenevamo il negozio aperto fino alle ore 13, con la moto raggiungevamo poi i nostri famigliari per l'ora del pranzo che le donne di casa avevano preparato sin dalla sera precedente e cucinato al mattino.
Giunse anche il momento di avere una abitazione, migliore di quella che avevamo, ci trasferimmo in un appartamento al Pilastro, in via Cesare Pinzi n. 9, interno 5.
L'appartamento, assegnato ai due nuclei familiari, Giuseppe Matteacci e Vinicio Galeotti era, al terzo piano e si componeva di tre camere, una sala, una cucina, corridoio e bagno, oltre ad uno scantinato. Io ho diviso la camera da letto con Mauro, fino a quando con il babbo e la mamma ci trasferimmo in via Leonardo da Vinci n.17, abitazione che è divenuta di proprietà di mamma. Il nuovo appartamento, sito al 3° piano, è piccolino, ma carino; si compone di una camera da letto, un sala, dove dormivo io, un ingresso, corridoio, cucina e bagno, oltre ad un ampio scantinato, due sgabuzzini ed un bel terrazzo, che il babbo chiuse, parzialmente, con una veranda in ferro.
A Bruna e Vinicio rimase un ampio appartamento di circa 98 metri, più che sufficiente per il nucleo familiare che, il 3 gennaio 1959, aumentò per la nascita di Carlo Galeotti.
Nell'ambito della politica, mi destreggiavo in maniera soddisfacente, ero benvoluto ed avevo già un certo peso politico derivante anche e soprattutto dal seguito che avevo nella base elettorale.
A scuola le cose procedevano bene, dopo la frequenza della terza classe, frequentai la quarta e la quinta con ammissione agli esami di diploma.
Gli esami furono affrontati con serenità, avevo studiato in compagnia di vari amici, come Giorgio Taurchini, Arnaldo Moneta, Emilio Santini, Sergio Bastiani e altri che non ricordo.
Il giorno degli esami mi presentai vestito di scuro, tranquillo e sereno; il primo esame che sostenni fu quello d'italiano. Dietro alla scrivania erano tre professori uno dei quali mi declamò un brano di una poesia e più precisamente: "Oh pianta alta e ombrosa / tu che fai ombra al morto che riposa / nella bara dell'eterno sonno / fa sì che quella sosti sotto il tuo sommo / e gigantesco ombrello / morì di mio padre il fratello / io piansi e mi rivolsi a Dio / per la salvezza del mio caro zio....".
Poi mi chiese: "Conosce l'autore?". Con grande sorpresa ascoltai quella poesia, rimasi di stucco, come si suol dire in certe occasioni risposi: "Modestamente professore, l'autore sono io, per il solo fatto che lei ha declamato i miei versi, per me è come se avessi già superato gli esami". Lui replicò: "Mi risulta che lei svolge attività politica; si vede e si sente, mi parli, ora, della differenza che trova nel Manzoni, leggendo le sue opere: "Il 5 maggio e i Promessi sposi". Non fu difficile dare la risposta, feci un figurone.
Qui terminarono i miei esami d'italiano. Gli altri esami furono una passeggiata. Tutto terminò positivamente con una stretta di mano ed un augurio, che nella vita mi ha fatto molto comodo.
Non sto qui a raccontare la felicità che ci fu in famiglia quando seppero della mia promozione, il babbo disse: "Cocco ce l'abbiamo fatta!".
Avrò peccato di immodestia, ma appena avuto in mano il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, andai dal signor Giuseppe Salvotti, titolare della tipografia "La Commerciale" in via Matteotti, per ordinare cento biglietti da visita con tanto di "Rag.", che il caro signor Giuseppe non volle farmeli pagare.
Erano gli anni che un giovane si guarda intorno e se, come capitò a me, gli fanno capire che è un bel ragazzo, la vita diventa movimentata, agitata, tormentata e bella da vivere.
L'ape vola da fiore in fiore e si nutre; così io svolazzavo: da bionda a mora, da rossa a castana, da adulta a giovane; da città a paese; da Viterbo a Gubbio, Roma ed altre città; e... amavo!
Il tempo non mi mancava, la faccia tosta l'avevo; il resto me lo aveva dato Dio e i miei genitori!
Ma non tutte le ciambelle, vengono con il buco. Pazienza, ci si deve accontentare, perché "domani è un altro giorno".
Di fiori ce ne erano tanti, bastava dargli, ogni tanto, una spuntatina ed una annaffiata; importante era evitare le "piante rampicanti" e "l'edera" che, normalmente, soffocano le piante sulle quali si attaccano o muoiono insieme alla pianta.
Questo è, e sarà l'unico riferimento al "mondo della donna" perché nessuna deve essere esaltata, come nessuna deve essere umiliata; perché una e tutte, tutte e una, in quel momento che furono, mi resero soddisfatto!
Avevo scritto "felice" ma il mio carissimo amico don Bruno Marini, al quale ho confidato il mio pensiero, mi ha fatto ricredere; ha ragione, come ha sempre avuto ragione, quando mi dava i suoi preziosi consigli.
Tanto per alleggerire lo scritto, voglio raccontare un episodio che avvenne in epoca elettorale. Al Comitato Provinciale della D.C. presi un'autovettura, predisposta con l'altoparlante, per annunciare un comizio che l'onorevole Jozzelli doveva tenere nella serata a Monterosi.
Partii da Viterbo in compagnia dell'amico Alberto Delle Monache, strada facendo, con il microfono, invitavamo gli elettori a votare per la D.C. e dare le preferenze ad Andreotti, Bonomi e Jozzelli. Giunti sulla piazza di Monterosi, facemmo l'annuncio previsto e ci fermammo davanti ad una Fiat 500, che aveva gli sportelli controvento. Ad un certo momento vedemmo che una bellissima signora stava aprendo lo sportello per entrare in auto; davanti a quel bello spettacolo, Alberto disse: "Guarda, guarda che belle gambe!".
Nella piazza risuonò il nostro stato di meraviglia; ci eravamo distratti e non calcolammo che avevamo l'altoparlante acceso e al massimo volume. La bella signora, compiaciuta, ci sorrise mentre le persone, che erano in piazza, annuirono.
Noi partimmo di corsa, vergognandoci dell'accaduto.
Normalmente si organizzavano sempre due o tre comizi, quella sera l'ultimo comizio si teneva a Roma-Prati.
Ricordo che, con gli altri collaboratori della campagna elettorale, quel giorno ci demmo appuntamento a Roma per ascoltare e vedere il comizio del "Capo", come chiamavamo l'onorevole Jozzelli.
Per l'onorevole fu una bella sorpresa vederci e, al termine del comizio, ci offrì la cena al ristorante Cesare Augusto, che si trovava nei pressi di Corso Francia.
Al termine delle elezioni l'onorevole Jozzelli, che ebbe una bella affermazione, stanco e soddisfatto decise dopo qualche giorno di andare a Chianciano, non prevedendo quello che sarebbe avvenuto.
Ci giunse una telefonata con la quale ci fu detto che Jozzelli era stato nominato Sottosegretario alla Difesa e che si doveva presentare urgentemente a Roma per il giuramento.
Il sindaco Salvatore Arena, Santino Clementi, Orlando Pace, Mauro Galeotti ed io partimmo da Viterbo e ci recammo a Chianciano dove trovammo, lungo la strada del paese, l'onorevole, che stava passeggiando, al quale comunicammo la bella notizia. Contattammo subito la Polizia Stradale che accompagnò l'onorevole a Roma il quale fece appena in tempo a presentarsi davanti al Presidente del Consiglio, per prestare il giuramento di rito.
Al ritorno, felici di avere un Sottosegretario nella persona dell'amico Attilio Jozzelli, ci fermammo, lungo la strada Umbro Casentinese, nel ristorante "da Biagio" dove mangiammo pastasciutta, varie qualità di carne con dell'ottima anatra arrosto e brindammo in onore del "Capo", l'onorevole Attilio Jozzelli.
L'anno del Signore 1958 lo ricordo con un'ottica particolare. Ci tenevo a guardare il domani con un occhio diverso dal passato. Varie vicende politiche della nostra Viterbo mi avevano spronato a "fare" per chi e a "dare" a chi; si trovava in condizioni non tanto brillanti.
Il 22 Maggio1956 fui sottoposto a visita medica al Celio Militare perché volevo provare a non fare il militare a causa dell'incidente stradale che ebbi nel 1952; il risultato fu negativo, fui idoneo.
Avevo l'età prevista per la visita medica di leva, che sostenni il 18 Novembre1957, prima nei locali della Rocca Albornoz, poi in via Cardinal La Fontaine, dove ottenni, per motivi di studi, il rinvio con il 2° scaglione del 1937.
Però feci queste considerazioni: "Dovrei partire nel giugno, luglio 1959; se invece, partissi volontario, nel 1958, con la classe del primo scaglione 1937, dato che ho già il rinvio, quando è luglio ho già fatto sette mesi di militare, dei diciotto che debbo fare; prima parto e prima ritorno; può darsi che questo anticipo mi può dare la possibilità di trovare un impiego".
Presentai, subito al Distretto Militare di Viterbo, una domanda per essere arruolato con il primo scaglione della classe 1937.
Intanto nella D.C. viterbese c'erano scontri fra le varie correnti. Sì, purtroppo, erano nate le "correnti" interne al Partito. Ricordo, non con piacere, che un gruppo della sinistra D.C. a cui faceva capo il compianto Ettore Guidobaldi, con gli amici Ovidio Cusi, Giorgio Puri, Aldo Centolani, Alfredo Tola, Luigi Paradiso, il professor Fanti ed altri, di cui non ricordo il nome, crearono una fronda che si dissociò dalla maggioranza e, non avendo una sede politica, effettuarono le elezioni, interne del gruppo, dentro al cassone di un camion parcheggiato nelle vicinanze di San Leonardo. Il gruppo, da quel giorno, prese il nome: "Gli Amici di San Leonardo".
Il ragionier Mario Paternesi era il segretario politico del Comitato comunale della D.C. ed io ero il vice segretario comunale e il segretario amministrativo, al posto del cavalier Giovanni Cardoni. Quest'ultima carica la tenni pochissimo, perché mi dimisi, a seguito di una scorrettezza, fatta da una certa persona che, per quieto vivere, non nomino, ma cito l'episodio.
Fu chiesto, a mia insaputa, un contributo economico a Giulio Andreotti, il quale, molto correttamente, mi scrisse per informarmi della richiesta. Non ci sono commenti, come non ci furono all'epoca; preferii tacere e dimettermi, anche in considerazione del fatto che in quel periodo si entrò nell'ottica di aprire nuove sezioni della Democrazia Cristiana e più precisamente: al Pilastro, a Pianoscarano, all'Ellera e ai Cappuccini.
Per quanto riguardò la Sezione del Pilastro trovai dei locali, al piano terra, in via San Faustino n.19, che presi in affitto dal signor Eraldo Damiani. Rimediai due tavoli, un armadio ed una scrivania, trenta sedie ed acquistai, dal signor Lamberto Vittori, in via Matteotti, una macchina da scrivere portatile.
Io non potei assumere incarichi politici perché ero prossimo a partire per il servizio militare, quindi si nominò commissario, in attesa della individuazione degli iscritti e la elezione degli organi sezionali, il dottor Costantino Kuzminsky, degna persona, al di sopra delle parti.
Dopo pochi giorni mi giunse la cartolina per partire e raggiungere il reggimento; la classe 1937 era già stata arruolata da circa venti giorni. Lessi, con stupore, la destinazione, che era la Sardegna; feci le mie rimostranze a chi di dovere ottenendo buoni risultati, fui destinato all'80° Reggimento Fanteria "Roma" C.A.R. -2 M.O. di stanza ad Orvieto.
Il pomeriggio del 14 dicembre1958 partii da Viterbo, lasciando i miei cari addolorati, io non ero da meno; giunsi a tarda sera ad Orvieto; attraversai la grande piazza, antistante la Caserma e mi avvicinai alla sua porta di accesso. Il piantone mi rivolse la parola dicendomi: "A recluta c'hai 'na sigaretta?". Visto, che oltre a lui c'era anche la sentinella nella garitta, gli stavo per dare quattro sigarette ma, ascoltata la successiva frase: "Hai da scoppia'", mi fece ricredere; gli detti solo due sigarette, aggiungendo a quanto detto: "Intanto scoppia tu, io questa sera me ne vado in albergo". Andai a cena e a dormire, anche se non chiusi un occhio.
Al mattino del 15 novembre 1958, verso le otto entrai in caserma, ricordo che ero vestito con un gessato, con camicia bianca e farfalla al collo, con scarpe di capretto ed una elegante borsa da viaggio. Varcai la soglia dell'ingresso della Caserma e, davanti ai miei occhi si presentò un immenso piazzale dove erano alcuni militari che con le ramazze lo stavano pulendo.
Riconobbi un mio amico di Viterbo che faceva il fornaio nel panificio del signor Mario Gasbarri, in via della Cava, il quale esordì dicendo: "Ragionie', non stiamo a Viterbo, qui si ramazza!". Certo fu un brutto biglietto da visita della caserma nei miei confronti.
Fui destinato, alla 6^ Compagnia, 3° Plotone, che aveva sede proprio davanti all'ingresso, sopra allo spaccio e al refettorio. Il primo impatto lo ebbi in fureria, dove mi presero in "forza"; poi fui avviato al magazzino, dove mi dovetti spogliare, lasciando il mio elegante gessato, con tutto il resto che avevo e mettermi, non dico e vestirmi, la divisa che mi dettero perché era come un sacco.
Andai alla sartoria interna, “unsi”, con qualche centinaio di lire, mi presero le misure e, seduta stante, mi cambiarono la divisa. Quello, per loro, era un sistema buono per fare qualche lira.
Nel momento in cui entrai nella camerata provai un senso di repulsione, un cattivo odore mi colpì, c'erano i finestroni chiusi, era una giornata fredda con molta nebbia, cosa che ad Orvieto è normale.
Il mio posto letto doveva essere nel secondo "castello", nella parte inferiore, però grazie alla benevolenza del commilitone Rossi di Roma, al quale regalai delle sigarette, potei cambiarlo con quello al di sopra, che era di mio gradimento perché sopra di me, non c'era nessuno, mentre, alla mia destra, era il letto di Benito Vitali, di Bari, via F. Crispi -Case Popolari G/28, con il quale divenni subito amico inseparabile, non da meno fu l'amicizia che intrapresi con Emilio Rozzi di Milano, via Ampere 25.
Con Benito ci siamo riveduti, dopo molti anni, a casa mia e a Bari, quando andai per un convegno dell'ANCI, come direttore dell'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, mentre con Emilio ci siamo sentiti, un paio di volte, per telefono.
Erano appena passati un paio di giorni, dal mio arrivo in caserma ad Orvieto, che chiesi, al comandante del plotone, di voler parlare con il colonnello comandante.
Sembrava che avessi chiesto di parlare al Papa, il sottotenente, a cui mi ero rivolto, mi rispose: "Sì, ora ti faremo parlare con il ministro!!!".
La mia risposta fu lapidaria: "No, signor tenente, io voglio parlare con il colonnello comandante, Ettore Radica, perché con il ministro ho già parlato!".
L'ultima risposta del sotto tenente fu: "Aspetti, le farò sapere". Notai subito che, alla prima risposta dell'ufficiale, mi fu dato il tu, mentre alla successiva mi fu dato il lei.
Il giorno successivo cercai il sottotenente, senza alcun risultato. Avevo fretta di parlare con il colonnello perché ero già stato comandato come piantone alla camerata, dalle ore 20 alle 22; quindi quella sera non sarei potuto andare in libera uscita.
Decisi di avviarmi verso la palazzina comando, che aveva sede alla destra dell'ingresso. Quel tremendo piazzale non finiva mai, più camminavo e più la palazzina mi sembrava lontana.
Giunto davanti al portone, un graduato mi chiese dove andassi, risposi: "Mi aspetta il signor colonnello comandante".
Il graduato si spostò e lì incominciò la manifestazione della mia imbranatura.
Bussai alla porta del colonnello, mi fu detto: "Avanti!"; entrai, impacciatissimo; il colonnello, che penso capì la mia situazione, domandò: "Lei chi è, cosa vuole?".
Risposi: "Sono il ragionier Bruno Matteacci..." non finii la risposta che il colonnello soggiunse: "Lei è la recluta Bruno... non ho ben capito il cognome, che dovrebbe stare sull'attenti, non tanto per me, quanto per la bandiera".
A questo punto si avvicinò un ufficiale, molto alto, seppi poi essere il capitano Bianco, aiutante maggiore del colonnello, il quale parlò sottovoce al comandante, che alzò la cartellina sottomano, estrasse una lettera, la lesse e mi disse: "Da domani mattina lei prende servizio, all'Ufficio Presidio, con il maresciallo Carlo Del Sole". Iniziò così la mia bella vita da militare ad Orvieto, con la qualifica di scritturale insieme al caporale Dario Ceraso, con il quale, il 16 gennaio 1959, facemmo una fotografia, nel nostro ufficio, mentre il 24 dicembre 1958 feci delle fotografie in camerata, stando sull'attenti, tra il mio letto e quello del capo squadra.
Conobbi, in quel periodo, il maresciallo dei Granatieri Raimondi, di Viterbo, il quale era maestro della banda musicale e ritrovai anche il vecchio amico viterbese, Selvaggini con il quale feci un po' di fotografie.
Non avevo mai indossato gli scarponi perché esonerato da tutti i servizi.
Il giorno precedente al giuramento, che volli fare, mi accorsi che non ero più in possesso degli scarponi, me li avevano rubati; l'indomani, per sfilare, era d'obbligo indossare: la tuta mimetica, gli scarponi, le ghette, il cinturone, l'elmetto ed imbracciare la gloriosa carabina Winchester.
Dopo aver fatto qualche telefonata, riuscii a trovare quanto necessario per essere vestito in ordinanza. Fino al giorno del giuramento non era consentito indossare, sul bavero della divisa, le mostrine che erano di colore rosso con due strisce gialle; i colori di Roma.
Il 21 dicembre 1958 presenti in tribuna, in prima fila, erano babbo e mamma; giurai fedeltà alla Patria, fu una giornata indimenticabile; nel momento che, nell'aria, risuonò l'eco del grido: "Lo giuro!", un brivido di commozione attraversò il mio corpo.
Emozionato sfilai, con il mio plotone, all'ottava fila di testa, a sinistra. Trascorsi la giornata con i miei genitori, che vennero ad Orvieto con la Topolino; andammo poi a mangiare fuori dalla caserma.
Alla sera, mentre rientravano verso Viterbo, ricordo che, tra una lacrima e l'altra, seguii il loro viaggio guardandoli dalla rupe di Orvieto; per un poco seguii la luce dei fari dato che all'epoca di auto in circolazione ce ne erano poche.
Ogni volta che i miei cari venivano con l'auto e si fermavano fino a tardi, stavo in pensiero per il loro ritorno.
Arrivò il giorno di fare le famose dolorose iniezioni sul petto; al mattino, di una giornata fredda e nebbiosa, ci inquadrarono davanti ai bagni, ordinandoci di fare la doccia con acqua calda, poi, ad alta voce, ci ordinarono di togliere il sapone; per spronarci a fare presto, ci tolsero l'acqua calda, mandando quella fredda.
Data la brevità del tempo a disposizione, alcuni rimasero insaponati. Sempre incolonnati dovemmo presentarci, subito, davanti ad un ufficiale medico e ad un infermiere per fare la famigerata puntura. Uno degli aghi, quando lo estraevano dalla carne strappava, causando la fuoriuscita di sangue.
Mentre mi facevano la puntura non volevo guardare il petto perché già sapevo, che alla vista del sangue, sarei svenuto perché, a Viterbo assistetti, a Porta Romana, ad un incidente mortale di un ragazzo che, finì con la testa sotto alle ruote di un autotreno. Da quel giorno, come vedevo una goccia di sangue, perdevo i sensi.
L'ufficiale medico mi ordinò di guardare; guardai, sentii il tocco dell'ago e, appena vidi la goccia di sangue, che uscì dal foro praticato dall'ago, svenni.
Cosa che non capitò alla seconda iniezione perché non condivisi l'operato, seguito a suo tempo, perché il corpo subiva una reazione derivante dalla doccia e dalla paura.
Sapendo di dover fare la puntura, la sera precedente mi preoccupai di fare la doccia, in una struttura a pagamento e il mattino successivo, bevvi un bel grappino e mi presentai a fare la iniezione.
L'ufficiale in servizio mi voleva imporre di fare la doccia, io rifiutai dicendo che non ne avevo la necessità perché l'avevo fatta la sera precedente. Feci la puntura senza subire l'inconveniente della prima volta.
Una cattiva esperienza l'ebbi quando fui colpito da una grossa febbre; al mattino marcai visita e fui sottoposto a visita medica in infermeria dove sul tavolo avevano un barattolo pieno di pasticche che venivano date a tutti, come se tutti avessimo avuto la stessa malattia.
Durante la notte mi sentii malissimo, chiamai, ma nessuno venne a prestarmi qualche cura, allora mi avvolsi con un paio di coperte da campo e tornai in camerata dove avevo la certezza di poter ottenere un aiuto. Tutto ebbe fine nell'arco della giornata, potei così andarmene all'Ufficio Presidio per lavorare.
L'essere in servizio al Comando, come detto, mi esonerava da tante incombenze.
Una mattina, mentre stavo in ufficio con il Comandante e il maresciallo Carlo Del Sole, sentimmo cantare i militari del mio battaglione, che stavano per andare a fare i tiri al poligono sul fiume Paglia, spontaneamente dissi: "Beati loro!".
Il colonnello, che mi voleva bene, disse: "Bruno, se lei vuole, può andare”.
In un attimo mi recai nella camerata, mi spogliai e indossai la divisa e la tuta mimetica con i tremendi scarponi che erano diventati rigidi e duri.
Mi presentai al comandante del plotone e partimmo.
Una volta giunti nelle vicinanze del fiume Paglia dove, in qualche punto, era ancora la neve, incominciammo le seguenti esercitazioni: lancio della bomba a mano "S.R.C.M"; tiri al bersaglio "sagoma uomo", da posizione: sdraiati, in ginocchio e in piedi con "Moschetto 91/38", "Garand", e "Winchester"; inoltre prima della fine delle esercitazioni, ci fecero sparare con il M.A.B. sia a colpo singolo che a raffica.
Il freddo divenne il nostro nemico, stare oltre due ore sulla linea di tiro significò
aver fatto una esperienza da non dimenticare, in particolare quando, al termine della prova, si contarono i bossoli rimasti, e si rapportarono alle munizioni fornite dall'armiere.
Mancava un colpo, la probabilità era che fosse rimasto, inesploso, nella canna di qualche arma. Subito dettero ordine di non sparare, anche a vuoto, perché si correva il rischio di sparare, involontariamente e fare qualche danno serio.
Durante il ritorno ero dolorante; gli scarponi, che avevo indossato solo il giorno del giuramento, mi avevano causato una vescica al piede; zoppicavo, ma l'orgoglio vinceva.
A vent'anni tutto può capitare, come capitò che il colonnello, passando con l'auto di servizio, guardandomi, mi ordinò di salire sull'auto, con la scusa che era urgente la mia presenza in ufficio. Salii e ci avviammo verso la caserma; il colonnello, carinamente, mi tolse dall'imbarazzo, sia del marciare che da eventuali giudizi dei commilitoni.
Il Natale 1958, non potei andare a casa perché facemmo dei turni; chi andava a casa per Natale non andava per Capodanno.
La vigilia la trascorsi da solo, girando per Orvieto letteralmente deserta.
Che delusione, mai mi sono sentito così solo quando intorno c'era aria di grande festa!
Il giorno di Natale venne a trovarmi mio cognato Vinicio, che arrivò, con una borsa in mano; per la prima volta lo vidi con il cappello. Mangiammo insieme quanto i miei cari mangiavano a casa. Non poterono venire per l'avanzata gravidanza di Bruna che attendeva l'arrivo di Carlo, che poi nacque, come ho già scritto, il 3 gennaio 1959.
Era mia abitudine portare i capelli un poco lunghi, la sera del 24 gennaio 1959, mentre stavo per andare in libera uscita fui fermato dall'Ufficiale di Picchetto il quale, con un paio di forbici in mano, pretendeva dare una sforbiciata ai miei capelli.
Gli dissi che non si doveva azzardare a toccarmi, che era nella sua discrezione farmi uscire, o no, ma che non facesse un ulteriore passo verso la mia persona, perché non avrei risposto della mia reazione.
Tutto finì dopo tale discussione, il suo ordine fu: "Domani, quando uscirà, voglio vedere la sua testa, come quella degli altri". Durante la discussione, che prese un tono acceso, si formò un gruppetto di militari e il personale civile, che operava nella caserma, fra questi era il gestore della barbieria militare che l'indomani, 25 gennaio 1959, mentre il suo dipendente mi tagliava i capelli, sotto la sua guida, mi fece fotografare.
Sono stato ad Orvieto tre mesi, dove ero rispettato, apprezzato e amato.
Proprio quest'ultima dote mi fu fatale.
La sera del 19 febbraio1959 seppi che ero stato trasferito da Orvieto a Sulmona.
Non ci volevo credere, perché avevo avuto assicurazione che avrei trascorso tutto il periodo militare ad Orvieto, ma ebbi la sventura di guardare, con troppa attenzione, la figlia di un ufficiale superiore, e di essere contraccambiato e forse, anche perché, non avallai l'operato di qualche fornitore.
Tanto per citare un episodio voglio raccontare cosa avveniva quando pesavano i quarti di carne di bue.
La carne, congelata, proveniva dall'estero, la scaricavano alla Stazione di Orvieto e la prendeva in carico una ditta locale che la conservava nei propri frigoriferi e, dopo scongelata, la consegnava alle cucine del Reggimento, previa pesatura, allo scopo di verificare la differenza tra il peso della carne in arrivo, il calo per scongelamento e la quantità consegnata.
Mi accorsi che quando pesavano, su una basculla, le mezzene di bue, le stesse erano portate sulle spalle da due persone, di cui una magra e l'altra grassa.
Contavano le avvenute pesature e, alla fine, pesavano l'operaio magro e moltiplicavano il peso dello stesso per il numero delle pesate; il risultato veniva detratto dal peso totale.
Era un modo di operare che consentiva attestare la consegna di una certa quantità di carne, mentre in realtà mi accorsi che, ad ogni peso, rubavano sette chilogrammi di carne; tale era la differenza di peso dei due operai.
Il coltello, dalla parte del manico, lo teneva qualche carogna che si avvalse della sua posizione e dell'assenza del Comandante, approfittando così di trasferirmi con la seguente motivazione: "Poiché al 17° Reggimento Fanteria "Aqui" M. d'O., di stanza a Sulmona, necessita un ragioniere, visto che Bruno Matteacci si è distinto, come scritturale, in questo Reggimento, lo si trasferisce".
La sera che seppi del mio trasferimento sentii la necessità di avvisare i miei genitori, quindi dovetti recarmi a Viterbo.
Vidi che, vicino alla pompa della benzina era un'autocisterna targata Viterbo, con scritto "Shell Molinari", approfittati, dato che conoscevo sia la ditta che l'autista; mi avvicinai chiedendo un passaggio.
Aspettai nascosto tra la siepe della porta carraia, arrivato il camion, con un balzo salii; giunsi a Viterbo sul tardi; non sto qui a dire il dolore, che provarono i miei cari, nell'apprendere che ero stato trasferito a Sulmona, luogo che nessuno di noi sapeva dove fosse; guardammo una cartina geografica e ci rendemmo conto della nuova sede.
La mamma mi fece portare via i viveri tra i quali due piccioncini ripieni.
Non mi soffermo sulle vicende del viaggio, che fu fatto in "tradotta".
Il 21 febbraio 1959, giunsi a Sulmona, sede del 17° Reggimento Fanteria, Granatieri di Sardegna, "Aqui" M.d'O.
Avevamo le mostrine, con i seguenti colori: fondo giallo, con due righe nere, che portavamo sul bavero della divisa e, al braccio sinistro, avevamo uno scudetto, con fondo bianco, cordoncino d'oro con i quattro mori di Sardegna.
Alla Stazione di Sulmona, ci vennero a prendere con dei camion, ci rifocillarono con un goccio di brandy e, nel momento in cui stavamo inquadrati nel cortile, chiesero: "Tra voi ci deve essere un ragioniere, faccia un passo avanti". Mi presentai e subito fui avviato alla Compagnia Comando Reggimentale, con la qualifica di scritturale.
Nel momento in cui stavo prendendo possesso del mio posto letto, che era in basso, manifestai l'intenzione di fare il cambio con quello di sopra; fui avvicinato dal solito bullo romano il quale mi disse che gli avrei dovuto rifare la branda.
Dissentii e lui replicò dicendo: "A more' io qui so' er sinnaco o fai quanto chiesto o stasera sarti", gli risposi dicendo: "Fai attenzione, oggi qui è arrivato il prefetto; questa notte non ti avvicinare perché potresti intruppare con il pugnale del Garand".
Dal commilitone, con cui stavo parlando prima della discussione, ebbi la possibilità di dormire sulla branda superiore ed io, per ringraziarlo, gli regalai un piccioncino; lui rimase mio fedele amico, per tutta la durata del servizio militare a Sulmona.
La mia attività di scritturale la svolsi, prima in fureria, poi ebbi la seguente disposizione: prendere in consegna il materiale del, disciolto, 46° Reggimento Fanteria e passarlo al 17° Reggimento Fanteria "Aqui", mediante la compilazione di buoni di consegna e buoni di prelevamento. Era un lavoro come tanti; importante era essere tenuto in considerazione, essere rispettato e tornare a casa ogni tanto.
Infatti, a seguito dei buoni rapporti con il capitano Sigismondi, comandante la Compagnia ed il tenente Parenti, ogni tanto tornavo a casa, con una motivazione o l'altra; importante era andare a casa.
Non tutti i ritorni a casa furono di piacere, ce ne fu uno che lasciò un segno non indifferente nel mio cuore.
Un giorno, nel tardo pomeriggio, ebbi notizia che mamma era malata, preoccupato della situazione chiesi una licenza, che mi fu subito concessa per la durata di quindici giorni; mi sembra che sia stata una licenza "per gravi motivi di famiglia".
Partii sul far della sera; non trovando, a Sulmona, un treno diretto a Orte, fui costretto andare a Roma e prendere un secondo treno per Orte. Giunsi alla Stazione di Orte Scalo verso le ore 23 e nessun treno era in partenza per Viterbo, come non trovai neppure un taxi. Tra i militari, che stavano dormendo in sala d'aspetto, non trovai chi volesse affrontare un viaggio, a piedi, fino a Viterbo.
La fretta di vedere mia madre era incalzante; decisi di avviarmi verso casa.
Era una notte fredda, indossavo un cappotto molto pesante e a causa della pioggia che veniva a catinelle, era diventato ancora più pesante.
Sebbene qualche automobile transitasse a quell'ora nessuno, al mio segnale di autostop, si fermò.
Giunto a Bagnaia verso le ore quattro, ebbi un passaggio da un camionista, che mi lasciò a Porta Fiorentina. Giunsi a casa e, grazie a Dio, riabbracciai mia madre che stava veramente male.
La mia presenza le dette un senso di tranquillità, sebbene mia sorella e il babbo le stavano vicino più del normale.
La forte fibra di mamma ebbe la ragione sul male e tutto riprese per il verso giusto.
Approfittai della mia presenza a Viterbo per organizzare, nella Sezione, un incontro nel quale decidemmo che la Sezione D.C. si chiamasse "Pilastro Monterazzano"; si prese atto dei nominativi dei soci che, d'ufficio, vennero trasferiti dalla ex Sezione alla nostra.
Come da programma, rientrai in caserma allo scopo di seguire il lavoro, relativo al passaggio dei beni da un reggimento all'altro che svolgevo sotto la direzione del maresciallo Secondo, di cui ho un bel ricordo.
Un episodio mortale offuscò la vita del reggimento; in una manovra di "campo" accadde che ad un militare sfuggì una bomba a mano che cadde sopra ad una cassetta piena di munizioni, fu un disastro il giovane militare fu investito in pieno stomaco dalla esplosione rendendo l'anima a Dio.
A Sulmona, notai certi fatti che non vidi a Orvieto, anche se c'era un certo piglia, piglia. Notai che il militare, quando veniva congedato, doveva riconsegnare quanto gli era stato dato nel momento dell'arruolamento, o meglio di quando giunse per la prima volta in caserma. Ad ognuno veniva richiesta, pena il pagamento: la riconsegna delle posate, che erano di volgare fattura e di materiale scadente; la restituzione del coltello e delle scatole di latta che contenevano, a suo tempo, il grasso e la vernicetta per le scarpe. Inoltre si dovevano riconsegnare: le lenzuola, le coperte e la federa del cuscino.
Per quanto riguarda il materiale, nessuno, dico nessuno, aveva conservato le posate e le scatolette, perché, dopo poco tempo, venivano gettate via, ad eccezione del coltello che era un molti uso, quindi si teneva gelosamente e a volte era preferibile pagare il valore richiesto, che era sempre troppo, rispetto al ricordo di un periodo della vita militare.
Quando il congedante consegnava le lenzuola e le coperte, le stesse venivano meticolosamente controllate allo scopo di vedere se erano bucate da qualche bruciatura di sigaretta. Quando dal personale, preposto al ritiro, veniva trovato il buco, al povero congedante veniva richiesto il pagamento della coperta o del lenzuolo.
Quest'ultimo non discuteva, pagava perché era desideroso di lasciare alle proprie spalle la caserma e tornare, dopo diciotto mesi, a casa.
C'è da osservare che quando dai C.A.R, arrivavano nuove reclute, venivano consegnate le lenzuola e le coperte, che giacevano in magazzino; erano quelle riconsegnate dai militari delle classi congedate. Quindi la coperta con il buco, che era stata pagata dal “nonno", entrava in uso alla ignara recluta, che poi, quando diventava a sua volta "nonno", pagava nuovamente e così via. Qualcuno ci mangiava a sette canasse. Ma non finiva qui.
Una domenica, con degli amici, per ragioni di servizio, fummo trattenuti in caserma, ad una certa ora, lo stomaco reclamò del cibo; lo spaccio era chiuso e l'unica soluzione era sentire se il magazziniere viveri, Sberna, ci poteva dare qualcosa da mangiare. La risposta fu immediata e la richiesta fu subito concretizzata, ci furono dati dei salamini. Il pane lo avevamo perché era usanza che, nei giorni di festa, il pane, per la cena, venisse dato all'ora del pranzo.
Sul tardi, a lavoro concluso, ci mettemmo a mangiare, rotto il salamino ci accorgemmo che, all'interno, erano presenti degli animaletti che, in dialetto umbro, chiamavamo "barbecce". Ci fu un ribollimento di stomaci perché qualcuno aveva già deglutito il cibo.
Ricordammo, che ogni lunedì, giorno chiamato "di libero pasto", ci veniva data a pranzo la pastasciutta condita con il sugo fatto con i salamini o salsicciotti, come si vogliono chiamare.
Si vede che, del fatto, ognuno di noi parlò con qualcuno e, per effetto del passa parola, tutti vennero a conoscenza di ciò che avremmo dovuto mangiare quel lunedì. Alla consueta ora del pranzo ci presentammo nel refettorio senza portare lo sgabello e nessuno iniziò a mangiare. Era fatto obbligo portare, dalla camerata, lo sgabello allo scopo di poter stare seduti a tavola, durante il pasto.
La reazione, del sottufficiale presente, fu violenta; voleva sapere il motivo della contestazione, gli fu risposto che, mangiando, si era notato un qualcosa che aveva la parvenza di un verme.
La risposta data, da due o tre dei presenti, fra i quali me, doveva servire a non far capire come venimmo a conoscenza dell'animaletto che stava nel salsicciotto. Fummo minacciati di essere messi tutti in "consegna" perché avrebbero poi preso dei provvedimenti perché, quanto fatto, era un ammutinamento, gesto condannabile.
La cosa non finì con quel problema, infatti, una notte venne una ispezione inviata dal Ministro della Difesa per accertare certe strane inadempienze che, sembra, da tempo si notavano nell'ambiente. La vita diventava difficile, non solo per me, ma per tutti. La sera del 18 maggio 1959, mentre ero in libera uscita ed ero in ristorante, a cena, con una jepp, mi vennero a prendere, per portarmi in caserma ed accompagnarmi, subito, alla stazione perché era giunto, da Roma, un fonogramma, a nome del Ministro della Difesa, con il quale venivo trasferito d'autorità nella sua segreteria.
Infatti, era scritto: "Trasferisco, d'autorità at mia Segreteria Granatiere Bruno Matteacci stop Destinazione predetto est at Comando 1° Reparto Autonomo Ministeriale Roma stop d'ordine del Ministro - F.to Risi".
A dire la verità, nell'apprendere la notizia ebbi una stretta di cuore, lasciandomi prendere dall'emozione. Telefonai subito a casa, trovai mamma che informai del mio trasferimento a Roma.
A Sulmona, sebbene tutto, mi trovavo discretamente, soprattutto per l'amicizia che avevo fatto con qualcuno. Però dovetti considerare che quel trasferimento era stato voluto dal mio carissimo amico, Giulio Andreotti, Ministro della Difesa. Viaggiai con il cuore in mano, ricordo che indossavo una divisa favolosa, nella stoffa e nel taglio; ci aveva messo le mani mia sorella Bruna. Aveva cucito una divisa che mi stava a pennello. Nel momento del mio trasferimento indossavo, questa magnifica divisa con una camicia di stoffa, simile a quella degli ufficiali; calzavo, poi, un paio di scarpe con tomaia di vitello.
In poche parole a Sulmona certe libertà erano tollerate, cosa che non capitò quando, il 19 maggio 1959, arrivai a Roma, al 1° Reparto Autonomo Ministeriale (R.A.M.).
Giunto alla Stazione Termini, non sapendo in quale direzione andare, noleggiai una carrozza dicendo al vetturino: "Mi porti alla caserma "Macao", in viale Castro Pretorio, dove ha sede il 1° R.A.M.". La carrozza, trainata da un vecchio ronzino, a passo cadenzato, si avviò sulla sinistra della stazione, percorse poche centinaia di metri e si fermò davanti ad un lungo muraglione, dove era la porta carraia, della mia nuova caserma. Il vetturino mi chiese una somma, che io ritenni, non proporzionata al servizio fatto, perché mi voltai e vidi che la stazione era a poca distanza; capii che si stava approfittando; allora gli detti quanto ritenni equo e me ne andai.
Non ci furono commenti da parte del furbo vetturino; il suo silenzio mi fece capire che avevo ragione. Varcai il grande cancello e, appena messo piede sul piazzale della caserma, vidi venire verso di me due militari che, avvicinatisi mi alleggerirono dall'ingombrante e pesante zaino e della valigia.
Quello fu veramente un bel biglietto da visita del posto, in cui dovevo trascorre il resto della mia vita militare.
Seguii i due commilitoni, che poi seppi essere due piantoni della palazzina, sede del comando, che si trovava davanti all'ingresso, mentre le camerate, il refettorio, lo spaccio e tutte le altre strutture, erano ubicate sulla sinistra dell'ingresso.
Mentre mi avvicinavo alla palazzina, notai che sotto una pergola d'uva, posta sopra all'ingresso, erano quattro ufficiali: un colonnello, due capitani, un tenente e quattro marescialli.
Poi seppi essere: il tenente colonnello Edoardo Mollica, comandante del 1° Reparto Autonomo Ministeriale; l'aiutante maggiore, capitano Enzo Petrucci; il capitano Marcello Riccobon e il tenente Sardisco rispettivamente: comandante e vice comandante della Compagnia Comando e i marescialli: Antonio Arbia, dell'ufficio personale; Gaetano Consoli, della maggiorità; Americo Frontori furiere della Compagnia Comando e Marcello Iannacci, addetto alla contabilità.
La prima impressione fu buona e i volti delle persone che stavano confabulando tra loro, a prima vista, mi sembrarono famigliari.
Il colonnello Mollica era grassottello con baffetti biondi, molto sorridente; il capitano Petrucci era snello, alto con baffetti neri, occhi piccoli e sempre sorridente;
il capitano Riccobon, anche lui con i baffetti, con mostrine della cavalleria; il tenente Sardisco serio e pensieroso; i marescialli: Consoli, radioso, simpatico e paterno; Arbia, con pochi capelli, ma molto simpatico; Frontori, uomo tutto di un pezzo, affabile; Iannacci, paffutello con baffetti con sorriso molto accattivante.
Questo fu il quadro che apparve ai miei occhi il primo giorno che vidi queste persone e queste sono le immagini che, da oltre quarantacinque anni, ho nel mio cuore; perché di loro serbo un magnifico ricordo ed è grazie a loro se ho un bel ricordo della vita militare.
Appena giunto davanti agli ufficiali e sottufficiali, che si erano voltati verso di me, ho salutato militarmente e sono rimasto sull'attenti; oramai avevo imparato come dovevo comportarmi. Mi fu comandato il "riposo", il colonnello mi domandò: "Da dove viene e cosa viene a fare?". Recepito il comando assunsi la posizione di riposo e dissi: "Dal 17° Reggimento Fanteria "Aqui", di stanza a Sulmona, sono stato trasferito, d'autorità, dal signor Ministro della Difesa." Il capitano Riccobon mormorò: "Una volta, nemmeno gli ufficiali venivano trasferiti d'autorità del Ministro".
A questo punto l'aiutante maggiore ricevette, dal maresciallo Consoli, il fonogramma con il quale veniva ordinato il mio trasferimento e lo fece vedere al comandante, il quale così esordi: "Lei è tutto fuori ordinanza, vada a mettersi in ordine, poi ritorni".
Da uno dei piantoni, che poi seppi essere Di Pinto da Palese (Bari), fui accompagnato, prima in fureria della Compagnia Comando, poi nella camerata, dove trovai il caporale Cascella, simbolo della ignoranza e della prepotenza, con il quale ebbi una discussione per il fatto che non volle recepire il mio desiderio di farmi occupare la branda, che era libera e che a me piaceva.
La discussione si concluse con la mia promessa che fu: "Stai tranquillo, con il tempo pure le nespole si maturano, figurati se non si matureranno le zucche". Successivamente andammo al magazzino vestiario dove era un sergente che mi ascoltò, sia per quanto concerneva la sostituzione della divisa, "fuori ordinanza", che della presa d'atto che una delle mie divise era rimasta in lavanderia, a Sulmona, insieme alle camicie, ai calzini e alla biancheria intima.
Ad un certo momento giunse un maresciallo maggiore, che lasciò ben intendere essere il responsabile del magazzino vestiario, il quale avallò l'operato del sergente e mi fece firmare una dichiarazione, che attestava quanto detto. La cosa più importante fu, che mi lasciò intendere, che avrei potuto, dopo conosciuta la mia destinazione, riprendere la divisa, previo nulla-osta del comandante di compagnia.
Fu doloroso lasciare la divisa, ma vidi che il sergente attaccò al bavero del giubbino un foglietto con scritto: "Compagnia Comando - Matteacci Bruno e la data".
Prima di ritornare dal comandante Mollica e dall'aiutante Maggiore Petrucci, feci una telefonata al mio carissimo amico Gilberto Bernabei, segretario del Ministro della Difesa, al quale dissi che ero arrivato a Roma. Mi fu risposto che ci saremmo sentiti nel corso della settimana.
Andai dal colonnello comandante che mi dette una scrutata dalla testa ai piedi e mi disse: "Lei dovrebbe andare al Ministero, aspettiamo un paio di giorni, poi vedremo il da farsi, intanto rimanga qui, al Comando del l° R.A.M..
Il maresciallo Gaetano Consoli mise gli occhi sulla mia persona, mi disse che a Viterbo aveva i parenti, che si chiamavano Scapecchi, dei quali ero amico del figlio e che conosceva la città ed avrebbe avuto piacere che io mi fossi fermato, come scritturale, nel suo ufficio, la "Maggiorità".
Quel maresciallo maggiore, che era anche Cavaliere della Repubblica Italiana, mi piacque, era elegante nel suo portamento; aveva una divisa che gli stava a pennello, scarpe lucidissime, occhiali a stanghetta e restio nel parlare, cioè calibrava le parole, come calibrava il suo modo di camminare e spostarsi in un piccolo spazio. In poche parole, il carissimo cavalier Consoli fece colpo su di me, fu lui che mi indusse a rinunciare di andare al Ministero, per rimanere nell'ufficio Maggiorità, ai suoi ordini.
Presi servizio; mi fu assegnata la scrivania, vicino alla porta di accesso, appresso era quella di un caporal maggiore, Gualtiero Gentili di Roma, via Mazzini n.145, prossimo al congedo, e davanti era la scrivania del maresciallo che, da questo momento in poi, lo chiamerò solo "Cavaliere", perché a lui, tutti ci si rivolgeva, chiamandolo "Cavaliere".
Nel primo giorno festivo, dopo il mio arrivo a Roma, mi fu concesso un permesso domenicale per andare a casa.
Il tempo volò, il sabato a sera, dalla stazione Laziale partii per Viterbo, dopo un paio d'ore circa ero tra le braccia dei miei famigliari, trascorrendo la serata tutti a casa di Bruna e Vinicio, perché Mauro era già grandino, ma Carlo aveva poco più di un anno e non era il caso di stare fuori casa.
Ricordo che quando mia sorella mi vide, notò subito che non avevo la divisa che mi aveva aggiustato; a quel punto mi disse se doveva modificare quella che indossavo.
Rassicurai Bruna dicendole che, visto il clima che regnava in caserma, quasi sicuramente, al mio prossimo ritorno a casa, avrei indossato la "sua divisa".
Non finivo mai di raccontare quanto mi accadeva nella vita militare, ogni volta era la stessa cosa: parole, parole, parole; ascoltate con amore e dette con altrettanto amore.
Ogni giorno vedevo che il mio operato e il mio comportamento venivano premiati, il primo regalo che ricevetti, proprio dal comandante, fu il poter indossare nuovamente la divisa che mi aveva aggiustato mia sorella.
Mi fu concesso di dormire nell'ufficio, con l'incombenza di rispondere al telefono quando dal Ministero trasmettevano eventuali fonogrammi, cosa che capitò raramente.
C'è da precisare che il telefono degli uffici, ad eccezione di quello del comandante Mollica, erano telefoni interni, cioè collegati tra loro e con il Ministero, quindi era impossibile avere contatti telefonici con l'esterno, sia in entrata che in uscita.
Ricordo che una notte rientrai verso le ore 23,30, ero veramente stanco, mi coricai vestito e mi addormentai; ad una certa ora squillò il telefono, risposi e sentii una voce femminile, che diceva: "Fonogramma, trasmette Farina, chi riceve?"; io risposi: "Matteacci, vada!".
La persona che stava al di la del telefono continuò a dettare il fonogramma, ma io mi addormentai ed alla mattina trovai che sul foglio, che stava per terra, mancava il testo del fonogramma e l'orario dell'avvenuta comunicazione; erano scritti solo i nostri cognomi.
Mi prese il panico; telefonai alla signora Farina, ma non la trovai perché aveva terminato il suo turno di lavoro, al suo posto era un'altra persona che pregai di effettuare una ricerca per trovare il fonogramma che doveva figurare trasmesso a Matteacci.
Quella persona, che poi volli conoscere, fu tanto solerte che, in breve tempo, mi richiamò per comunicarmi quanto non avevo trascritto. Certo passai un brutto momento!
La bontà del colonnello Mollica consentì di farmi telefonare, da mamma, quasi tutte le mattine.
Verso le ore 7,15 sentivo squillare il telefono nell'ufficio del Comandante che era in fondo, dopo quello dell'Aiutante Maggiore, che stava attaccato al mio; un salto e rispondevo a mamma. Era il momento più bello della giornata.
Qualche volta il colonnello veniva in ufficio al mattino presto, perché poi era impegnato a Castel Fusano, dove era lo stabilimento militare del 1° R.A.M., oppure doveva andare al Ministero.
La mamma telefonava, ma era il colonnello che rispondeva; io sentivo il trillo a cui faceva seguito, la voce baritonale del Comandante che mi chiamava, con queste parole: "Matteacci, Matteacci... la mamma!". Quattro passi ed ero nella stanza del Colonnello a parlare con mamma.
Alla sera, terminato l'orario d'ufficio, andavo in libera uscita; prendevo due mezzi di trasporto il 45 e il 90 per giungere Monte Mario dove, in via Teresa Gnoli,16, abitavano le mie zie, Anna e Ida le quali mi hanno sempre consentito, quando mi faceva comodo, di cambiarmi e mettermi in abiti civili.
Spesso, tanto spesso, mi facevano trattenere per mangiare qualcosa.
Alla sera, ad una certa ora, il piantone al comando di un graduato della Compagnia Comando, doveva portare la mia branda, dal magazzinetto adiacente ai servizi, nel mio ufficio. La branda bastava aprirla lateralmente e dall'interno uscivano il materasso, le lenzuola, il cuscino e la coperta; in un attimo il letto era pronto.
Avevo un conto in sospeso con il caporale di giornata Cascella, della Compagnia Comando. Il fatto, che lui si oppose a farmi occupare la branda che gradivo, mi rimase sullo stomaco, non tanto per il diniego, quanto per l'ignoranza ed il modo in cui si rivolse a me, oltre al fatto che, quei pochi giorni che ho dormito in camerata, quel letto rimase libero. Cosa feci? Mi si presentò l'occasione di essere io l'arbitro della scelta del graduato che doveva farmi portare la branda in ufficio; scrissi sull'ordine di servizio: Cascella.
Quando alla sera si presentò il caporale per dirmi che stavano per portarmi la branda, lo guardai e gli chiesi di portarmi pure quanto era rimasto in camerata, aggiungendo: "Cascella, che ti avevo detto? Che con il tempo tutto maturava, figuriamoci se la zucca tua non maturava, anzi nel tuo caso è marcita". Veramente non fui tanto soddisfatto dell'esito del mio dire: Cascella era talmente zuccone che non capì un fico secco di quello che gli dissi.
Stavo veramente bene. Sia ben chiaro io avevo, perché davo. Non lesinavo di lavorare; ad ogni momento ero sulla breccia assumendomi anche responsabilità più grandi di me, ma sempre nel rispetto dei regolamenti e soprattutto della volontà dei miei superiori. Il 1° ottobre del 1959 fui nominato caporale ed il 1° gennaio 1960 fui promosso al grado di caporal maggiore.
Il colonnello comandante mi lasciava dei moduli di licenza in bianco, con solo la sua firma ed una certa somma in danaro, che avrei dovuto utilizzare, in casi di urgenza di qualche militare, di andare a casa per gravi motivi di famiglia.
Il mio lavoro consisteva nel redigere l'Ordine del Giorno; il Permanente e tenere aggiornate le schede personali dei militari in forza al 1° R.A.M..
La macchina da scrivere era il nostro più importante strumento di lavoro. Di ogni atto, scritto su carta intestata del Ministero della Difesa, si faceva una copia su un tipo di carta chiamata velina.
Alla mattina mi svegliavo, il piantone di servizio veniva a portare via la branda mentre io mi preparavo ad affrontare la nuova giornata, che certamente non era monotona.
Gli amici che roteavano intorno a me erano: Michele Bonvino, via Vallona, 8, Bari, Nicola Chieppa, via Ferruccio, 175-Andria (BA); Pietro Favero, via Castello, 9, Sernoglia (TV); Di Pinto di Palese, Carmelo Pistorio, via Caserta, 14, Catania; Angelo Testaquadra, via Bixio, 23, Caltanissetta; Giovanni Toniolo, via Chiericati, 4, Piazzona sul Brenta (PD); Vincenzo Beatrice via Piegarelli, 38, Terracina (LT); Leopoldo Virgilio via Plebiscito, 52, Venafro (CB); Bruno Grossi via Cavour, 80, Frascati (Roma); Giovanni Testa via Merulana, 183, Roma; Vincenzo Occhino, Salita Cortina (Sicilia). Poi divenni amico di Antonio Lardera, in arte Tony Dallara, del quale parlerò successivamente.
Alla data del 14 Ottobre 1959 avevo la tessera di riconoscimento n.1388, su di essa, sulla parte sinistra, erano la fotografia, la firma del titolare e i seguenti dati: statura 1,72, colorito roseo, barba rasa, capelli neri, occhi neri, segni particolari, nel lato destro era scritto: Rilasciata al caporale Matteacci Bruno della Compagnia Comando 1° R.A.M. nato a Gubbio (Perugia) il 15.7.1936, Scritturale al Comando 1° R.A.M. la data e la firma del Comandante, dietro era scritto che potevo restare in libera uscita fino alle ore 22.
Fatti da ricordare ce ne sarebbero tanti, ma spesso sono ripetitivi, quindi narrerò solo quelli che possono far sorridere chi leggerà questo scritto o che, ricordandoli, possano farmi rivivere quei momenti.
Come programmato, tutti i sabati potevo tornare a casa. Ricordo che ebbi una licenza premio di 10 giorni, che utilizzai per dare una regolamentata alla Sezione della Democrazia Cristiana, della quale sarei dovuto diventare il Segretario Politico, ma che, come già detto, non potevo assumere tale incarico, a me tanto caro, solo perché indossavo una divisa che mi sarei tolto a metà del 1960, con la fine della leva militare, che all'epoca era di diciotto mesi.
Facemmo il direttivo della Sezione: Segretario politico, fu nominato il dottor Costantino Kuzminsky che era affiancato da un gruppo di miei amici.
Intanto avevo assunto un impegno, non indifferente, nei confronti di mia sorella Bruna e mio cognato Vinicio Galeotti, che aspirava avere un impiego al Comune di Viterbo con la qualifica di vigile urbano.
Vinicio era un gran lavoratore ed era pure una persona che leggeva molto e, quel che apprendeva, restava nella sua memoria, determinando, così, una base culturale che non tutti avevano.
Era preparato, studiava ed era, a mio parere, in condizioni di poter ben figurare in un concorso che doveva essere tenuto nel corso dell'anno. Non nascondo che temevo certi giochi politici che potevano fare, in mia assenza. Comunque Vinicio riuscì vittorioso nel concorso, arrivando secondo in graduatoria, ricordo che gli scrissi una lettera, che mia sorella apprezzò molto. Gli dissi che: "Ero orgoglioso di avere un cognato come lui" e lo assicurai che, il giorno in cui avrebbe indossato la divisa di Vigile urbano, sarei stato presente, infatti, venni in licenza per due giorni e festeggiammo tutti la mèta raggiunta. Anche questa era fatta!
Ricordo che un giorno, vicino a Ferragosto, in caserma non c'era quasi nessuno, ero di servizio al Comando, giunse un fonogramma, con il quale veniva comunicato che alla Stazione Termini, inviati dai C.A.R, sarebbero giunte alcune reclute.
In un primo momento ebbi un attimo di smarrimento, poi guardai in una cartella, che mi fu data la sera precedente, in cui trovai gli atti relativi al trasferimento di centocinquanta reclute. Presi i dovuti contatti con il Comando del 13° Reggimento Artiglieria, che aveva sede nel complesso della Caserma "Macao", pregando, chi di dovere, di mettere a disposizione del I R.A.M. un certo numero di autocarri per prelevare i militari alla stazione.
Mi furono messi a disposizione idonei mezzi che dopo poco tempo trasportarono tutti nel piazzale antistante la palazzina Comando.
Nel contempo, dalle cucine, avevo fatto preparare il caffè che fu dato ai militari, come temporaneo ristoro, che gradirono molto.
Il sergente maggiore che accompagnava i soldati ordinò alle reclute di mettersi schierati davanti alla palazzina e mi consegnò i documenti di viaggio, con l'elenco nominativo dei militari.
Fatto il dovuto riscontro con i documenti che avevo, messe le dovute firme, con l'apposizione del timbro tondo in metallo, recante al centro lo Stemma della Repubblica Italiana, con scritto Ministero Difesa Esercito - Comando Reparto Autonomo Ministeriale; il sottufficiale, che accompagnò le reclute, mi salutò.
Io, come saluto al sergente maggiore, che stava per andarsene, ordinai alle reclute, l'attenti e il destr-riga, perché il sottufficiale stava sulla destra dei militari che, commossi, dopo il riposo gridarono un "hip hip.. urrà!
Non a sproposito mi sono soffermato, più del dovuto, sul contenuto nel timbro tondo; l'apposizione di detto timbro, a inchiostro grasso nero ratifica qualsiasi firma rendendo legale e valido l'atto su cui è messo.
Da quel momento tutti gli adempimenti, per la presa in forza delle reclute, erano miei. La prima cosa, fu quella di avvisare la cucina dell'arrivo dei militari, anche se avevo precedentemente ordinato il caffè; avvisai i furieri della Compagnia Comando e della 3^ Compagnia, allo scopo di predisporre sufficienti posti letto.
Di ogni militare dovevo compilare una scheda, intestandola con i dati anagrafici, il titolo di studio, la compagnia assegnata e l'eventuale desiderio di svolgere la mansione di attendente o meno. All'epoca esisteva la qualifica di attendente che significava "attendere", prestare attività, alle dipendenze di un ufficiale, celibe, o della sua famiglia.
Mi venne spontaneo domandare se, fra i presenti, erano degli Umbri; alzò la mano uno, della seconda fila, al quale domandai di quale paese era.
La risposta fu, proprio quella per la quale avevo fatto la domanda: Gubbio.
Lo tenni presente fino al momento in cui scrissi la sua scheda: Giulio Berettoni, insegnante elementare, al quale domandai se gradiva fare lo scritturale.
La risposta fu affermativa; da quel giorno Giulio Berettoni prestò servizio alla maggiorità, al mio fianco, beneficiando di tanti privilegi.
Ci vollero ore per terminare l'arruolamento; alla fine avevo fatto tre categorie di incarichi: scritturali, attendenti, zappatori, tutti eravamo soddisfatti. Prima di andare a mangiare al refettorio dissi ai caporali di giornata ed alle reclute che, la mattina successiva, alle ore sette e trenta, dovevano essere tutti davanti alla palazzina Comando, per essere presentati al signor colonnello comandante e agli altri superiori.
Quella notte non feci portare la branda, tanta era la mia preoccupazione di controllare tutte le schede e gli atti fatti, per la presa in forza delle centocinquanta reclute; a tarda notte feci un pisolino stando sdraiato su due sedie.
Al mattino, i vari caporali di giornata, condussero le reclute, a loro assegnate, davanti alla palazzina Comando, dove furono da me prese in consegna, in attesa che arrivasse il Comandante, con il consueto seguito.
Ai nuovi commilitoni anticipai quello che avrebbero dovuto fare; la raccomandazione fu quella di ascoltare attentamente i vari comandi e di eseguirli all'unisono.
Quando da lontano, provenienti dallo spaccio, vidi il gruppetto di Ufficiali, con al centro il Colonnello Comandante e appresso vari Ufficiali e Sottufficiali che venivano verso la palazzina Comando, ordinai l'attenti.
L'emozione fu tanta, la soddisfazione di aver fatto tutto da solo era anch'essa tanta che, giunto il Comandante a pochi passi da noi, invece di comandare il sinistr-riga, perché proveniva dalla sinistra, erroneamente, comandai nuovamente l'attenti.
Il Colonnello Mollica, con un sorrisetto sotto i baffi, disse a bassa voce: "ma che li vogliamo far volare?". Capii subito l'errore fatto, comandai il riposo e presentai, con voce forte e sicura, la "forza", con una elencazione dei neo scritturali, delle mansioni varie e degli aspiranti attendenti.
Il Colonnello Mollica, in quell'occasione, nel prendere atto dell'operato, dispose la concessione di una licenza premio, che mi fu subito data e trascritta negli atti del Comando, con la pubblicazione sul "Permanente", atto Ufficiale del Ministero della Difesa Esercito.
L'eco di quanto avevo fatto, da solo, in occasione dell'arruolamento dei centocinquanta nuovi arrivati, ebbe una certa risonanza ed anche una bella conseguenza: ebbi cinque giorni, più due, di licenza premio che utilizzai per prendere contatti con amici di Viterbo allo scopo di potenziare l'attività della Sezione D.C.
Ricordo che conobbi Angelo Prosperini, che lavorava saltuariamente al molino Parenti, ma non aveva la certezza di un lavoro continuo. Capii al volo che Angelo era un ottimo elemento, una persona onesta, che aveva fantasia di lavorare e che sarebbe stato un fedele collaboratore. Ci volle poco a diventare amici per la pelle; amicizia che è durata molti anni, fino sa quando ci trovammo in ospedale, entrambi malati.
Dopo pochi giorni io fui dimesso, Angelo invece, fu trasferito in una clinica privata dove, purtroppo rese l'anima a Dio. Caro Angelo, quante battaglie abbiamo fatto insieme, ti porterò per sempre nel mio cuore, grazie per quello che hai fatto.
Nello stesso periodo conobbi Carlo Quintarelli, che lavorava in cucina nella caserma della Polizia Stradale; anche lui si lamentava del lavoro che svolgeva, stante il limite dello stipendio in rapporto ai sacrifici che doveva fare. Pure per
Carlo mi sento di dover, meritatamente, spendere due parole affettuose. Carlo non sapeva dire no, era sempre a disposizione, leale nell'operare.
Altre care persone che conobbi sono: Renzo Cappelli, impagabile persona, educato, silenzioso, disponibile, onesto, anche lui un vero collaboratore e amico per sempre, era l'unico a darmi il voi, anche se io preferivo il tu; Renzo, pur essendo tanto, tanto affettuoso, mi ha sempre dato il voi.
Antonio Cappuccini, Franco Paoletti, Primo Paolucci e Vincenzo Petroselli, tutti amici che mi sono stati, per tanti anni, molto vicini, in ogni elezione politica, con la loro presenza disinteressata, ma molto valida sotto l'aspetto propagandistico. Dei tre dovrei ripetere per tre volte tutti i sentimenti che nutrivo per loro e l'affetto che loro mi riservavano. Sono stati grandi, magnifici, instancabili.
Mi aspettavano con gioia quando rientravo a Viterbo; trascorrevo la maggior parte dei giorni della licenza stando in Sezione, dove molta gente veniva per vari problemi, che si augurava venissero risolti con il mio interessamento.
Devo ammettere che godevo di una certa simpatia e che molti cittadini speravano su un mio aiuto. Cominciai a sentire il piacere di aiutare la gente di una certa estrazione sociale: la mia, quella di chi conosce i sacrifici, di chi sa attendere, di chi sa sacrificarsi e decorosamente combattere per la giustizia e l'uguaglianza.
Stavo a Viterbo e pensavo all'Ufficio Maggiorità, dove avevo la certezza di essere ben voluto dai miei superiori e dai miei commilitoni. Quando stavo a Roma il mio pensiero volava: a casa mia, a mia sorella e alla sezione della Democrazia Cristiana.
Era un vivere sofferto, perché avevo tanto desiderio di fare quanto prima la valigia per tornare a casa, ma nel contempo immaginavo che quel "bellissimo" periodo militare, trascorso a Roma, lo avrei rimpianto. Cosa vera, che ora posso confermare: rimpianto per i miei vent'anni e per la vita spensierata, che conducevo.
A Roma la vita era bella viverla, si faceva il proprio dovere lavorando in caserma; all'ora del pranzo, obiettivamente, si mangiava bene, per non dire benissimo; si aveva la possibilità, giornaliera, di uscire e rientrare a tarda notte, beneficiando, oltre che del normale permesso, fino alle ore 22, anche del permesso T.S.T. (Termini Spettacolo Teatrale) che consentiva di rientrare all'alba del giorno successivo a quello in cui veniva rilasciato.
Di questi permessi si potevano avere anche tre alla settimana; io li ho sempre avuti.
Alla sera raramente mangiavo in caserma, spesso ero ospite dalle zie, a Montemario o, non mancando né il danaro né la compagnia, per mangiare una pizza o qualcos'altro, andavo in vari locali romani, dove si mangiava veramente bene.
Normalmente uscivo con gli amici: Angelo Testaquadra, siculo; Nicola Chieppa di Andria; Michele Bonvino di Bari, Carmelo Pistorio, siculo; Giulio Berettoni di Gubbio e qualche volta, con Antonio Lardera, in arte, Tony Dallara, cantante urlatore che era al centro dell'attenzione nel mondo della canzone.
Erano i tempi di "Ghiaccio bollente", di "Julia"; canzoni che avevano vasta eco, in particolare nel mondo femminile. A proposito di Dallara avemmo un piccolo guaio causato da una sua leggerezza.
Alla uscita, sugli schermi, di un film, in cui Tony appariva come attore principale; alla Camera di Deputati, le opposizioni al Governo, fecero una interrogazione per sapere come poteva essere possibile che Tony Dallara, avesse potuto prendere parte ad un film se era militare.
Ci fu una caccia fotografica nei confronti di Tony che, per un certo periodo, gli rese la vita difficile e, di conseguenza, siccome anche lui godeva di certi benefici come era anche nel mio caso, furono fatte ristrettezze a tutti.
Tony spesso andava a cantare a Castelfusano dove il M.D.E. aveva uno stabilimento balneare riservato ai dipendenti del Ministero stesso e gestito dal Comando 1° RAM, con l'opera dei militari di truppa, chiamati zappatori.
Tutto finì, come previsto e, ogni precedente abitudine si rinnovò nel tempo.
Di quel bel periodo militare voglio ricordare il cavaliere Gaetano Consoli.
Era un maresciallo maggiore, di quelli che ce ne dovrebbero essere in tutti gli uffici e compagnie militari; più che un maresciallo era un padre, un amico, uno con cui potevi tranquillamente parlare di tutto; era schivo dalle maldicenze, per lui tutti erano bravi. Era elegante: nel portamento, nel parlare e soprattutto nell'ascoltare.
Aveva un simpatico vizio. Quando gli si diceva un qualcosa di particolare, abbassava leggermente la testa, si fregava le mani, faceva un passetto indietro ed abbozzava un simpaticissimo sorrisetto, mentre emetteva un piccolo soffietto tra le labbra.
Faccio prima a dire che era un grande, grandissimo uomo!
Dopo tanti anni, dal nostro ultimo incontro, che avvenne, presso suoi amici, a Vetralla, in epoca in cui eravamo entrambi congedati, venni a conoscenza dalla figlia che il cavaliere stava male e che avrebbe avuto piacere essere sepolto a Viterbo.
La figlia mi chiese un aiuto che io le detti, anche se avrei preferito fissare una camera d'albergo, per un soggiorno del cavaliere a Viterbo e non un posto al cimitero, in un colombario dove è seppellita mia zia, Letizia Matteacci.
Il ricordo del cavaliere Gaetano Consoli sarà sempre vivo nel mio cuore e, finché avrò le forze, lo andrò sempre a trovare e lo ricorderò, con affetto, nelle mie preghiere.
Un episodio che ha offuscato il periodo militare a Roma, accadde una domenica sera quando, verso le ore 22, stavo per entrare nella palazzina Comando.
Non vedendo la sentinella, prima di entrare, ad alta voce, dissi la parola d'ordine; anche se non ebbi il preventivo segnale, "dell'alto là, chi va là" e della richiesta della parola d'ordine che avrebbe dovuto effettuare la sentinella.
Cautamente entrai; vidi che la sentinella, alla cassaforte, dormiva stando seduta sull'elmetto; aveva il fucile "Garand", con la baionetta innestata, appoggiato al muro.
Ebbi un'ulteriore attimo di esitazione, poi mi misi tra lui e l'arma dandogli, con la mano, un colpetto sulla spalla.
Si svegliò, rimase per un attimo assente, si guardò intorno e mi disse: "ragionie', tengo 'na fame da lupo". C'erano dei militari che mi chiamavano ragioniere come del resto ad altri laureati dicevano dottore, contro la volontà ed il regolamento che imponeva chiamare i superiori con il grado che avevano.
Ritornando al caso della sentinella che dormiva, gli detti due uova sode ed un panino ripieno di mortadella, che avevo nel cassetto; pasto che ci avevano dato all'ora del pranzo della domenica, che doveva servire per la cena.
Mentre la sentinella mangiava l'uovo, gli dissi: "Ti rendi conto della gravità della situazione? Per fortuna che sono giunto io, se passava l'ispezione, che poi oggi compete al 13° Artiglieria, per te sarebbero stati guai seri. In questi casi se ti dovesse ricapitare, suona il campanello e chiama il capo posto per farti dare il cambio, questo è previsto dal regolamento".
Mi sembrò di essermi comportato cristianamente e non militarmente, perché avrei dovuto prendere provvedimenti nei suoi confronti, ma anche lui era un figlio di madre e, come tale, meritava il mio affetto.
Tutto ebbe fine; andai in branda, con un buona notte.
Non riuscivo a prendere sonno perché la sentinella, che passeggiava nel corridoio, faceva rumore con gli scarponi chiodati.
Mi alzai dalla branda, aprii la porta del mio ufficio e pregai la sentinella di spostarsi sul lato dove era la cassaforte, evitando di venire davanti alla mia porta, in modo di non disturbare il mio sonno.
La risposta fu inaspettata, la sentinella gridò: "Non rompere la minchia, u sticchio 'e soreta" e, con due colpi di baionetta, inserita nel "Garand", si avventò contro la porta, che feci appena in tempo a chiudere.
Mentre gli gridavo di smetterla, il commilitone dette un terzo e un quarto colpo contro la porta; sino al punto che, intimorito che sparasse qualche colpo, mi spostai da dietro la porta e telefonai all'Ufficiale di picchetto, chiedendo un immediato intervento.
Sentii il rumore dei passi dei militari in corsa, che si avvicinavano, nel corridoio ci fu un certo parapiglia.
Aprii la porta, l'Ufficiale di picchetto inquadrò subito l'incresciosa situazione e immobilizzò la sentinella, che fu messa agli arresti.
Al mattino, giustamente, riferii ai miei superiori con una relazione scritta e la questione sfuggì dalla mia attenzione fino a quando venni a conoscenza che quel commilitone, trasferito come aggregato in Sardegna, morì, per una grave malattia al cervello.
Venni a conoscenza del fatto perché, compilando il "permanente", dovetti prendere atto del suo decesso; fu un dolore che mi accompagnò per mesi, perché fu, da parte mia, un episodio strano da comprendere, ma facile da perdonare.
Del periodo della vita militare, trascorso a Roma, ci sarebbe da parlare per giornate intere.
Fatti ed avvenimenti che, come detto, esulano da incontri galanti o avventurosi, ma che meritano essere ricordati perché accaduti e vissuti quando avevo vent'anni, età che nella vita di una persona lascia segni particolari.
Un giorno, con Giulio Berettoni e Nicola Chieppa, andammo in libera uscita all'E.U.R.
Dopo essere stati, per lungo tempo, a contemplare le bellezze del quartiere; visitando la zona del Palazzetto dello Sport, il laghetto e zone limitrofe, ci spostammo verso il Palazzo dei Congressi.
Stavamo leggendo quanto scritto sulla sommità del palazzo, quando due signore passarono vicino a noi, ognuna con un bambino in braccio.
Lessi, ad alta voce, la famosa frase, scritta sulla sommità del Palazzo dei Congressi, alla quale aggiunsi: "Gli Italiani sono un popolo che ama le signore, che hanno un bambino in braccio".
Una soggiunse: "e se sono bei ragazzi, come quelli che ci stanno davanti!".
Fu un attimo per scambiare due parole e, in segno di tenerezza verso i bambini e per far colpo sulle mamme, prendemmo i bambini in braccio, uno Chieppa ed uno io.
Ci facemmo scattare una fotografia da una delle mamme.
Dopo qualche giorno commentavamo il fatto con il capitano Petrucci e i marescialli Consoli e Arbia, ai quali facemmo vedere le fotografie.
L'aiutante maggiore, capitano Petrucci, guardando la fotografia, ci disse: "Bravi vedo come trattate la vostra divisa: i cappotti sono stati gettati in terra!!!".
Era capitato che tra le fotografie, prese in mano dall'aiutante maggiore, dove eravamo eleganti ed impettiti davanti al Palazzo dei Congressi, era anche una nostra fotografia dove si vedevano i nostri cappotti, ammucchiati per terra.
E' proprio vero, il diavolo fa le pentole e non i coperchi.
Un altro episodio, che voglio raccontare, è quello relativo al vitto.
Era e sarà ancora usanza che all'ora del pranzo, dalla cucina portavano, al comandante, in un paio di piatti, l'assaggio di quanto, nel refettorio, veniva somministrato, alla truppa.
Capitava spesso che il comandante, occupato per questioni importanti, demandasse ad altri l'assaggio del cibo.
Quel giorno fui comandato ad assaggiare il pasto; lo feci in presenza del piantone Di Pinto, il quale, quando vide che, tagliato in due l'involtino, all'interno c'era parte di un uovo sodo, disse: "Vedi, nell'involtino, cucinato apposta per il comandante, mettono l'uovo sodo, mentre in quello cucinato per noi non c'è".
Mentre Di Pinto parlava, entrò l'aiutante maggiore, che sentì tutto, e disse: "Di Pinto, se è vero quanto dici, avrai una licenza premio, ma se non è vero, prenderò seri provvedimenti disciplinari a tuo carico".
Di Pinto, s'incamminò verso l'uscita invitando il capitano a seguirlo verso il refettorio dicendo: "Venga, venga signor capitano". Di Pinto era sicuro di quanto aveva detto!
Giunsero nel refettorio e il capitano, al maresciallo addetto alla cucina, dette disposizione di tagliare qualche involtino.
In nessuno degli involtini, esaminati, era presente l'uovo sodo.
Di Pinto, come promessogli, ebbe una licenza premio mentre il maresciallo, addetto alla cucina, fu trasferito a Castelfusano, a comandare gli zappatori.
Da quel giorno negli involtini era sempre presente un pezzo di uovo sodo.
Con questo non voglio dire che si mangiava male, ma il meglio e sempre meglio. Spesso capitava che, mentre stavamo nel refettorio a mangiare, entrasse qualche ufficiale al seguito di qualche generale, ricordo che spesso veniva il Generale Mari, comandante della Caserma Macao, il quale faceva un giro tra i militari, intrattenendosi ora con uno, ora con altro.
Questo era un segno di benevolenza che ci trasmettevano i nostri superiori, facendoci vivere attimi famigliari e quindi momenti da ricordare.
Ho sempre sostenuto che il servizio militare era necessario per tanti motivi fra i quali: far sentire l'amore per la Patria; far capire quanto si stava bene a casa; far sentire quanto si amano i famigliari e quanto pesa la loro assenza; far capire che la disciplina è essenziale per un vivere sociale.
Non è retorica quanto affermato, certo è che, alla mia età, posso dire che tante persone non provano alcuna emozione quando sentono l'inno nazionale e che, se stanno seduti, non sentono il dovere e il rispetto di alzarsi in piedi.
Ringrazio i miei genitori che mi hanno dato una educazione e molti esempi di vita; si è trattato di un'educazione solida ed essenziale perché, con il tempo, ho capito che quanto mi insegnarono mi è servito di base, per quanto appreso nella scuola e nella vita militare.
Mai potrò non ricordare le parole del babbo; parole che, nel momento in cui le diceva, sembravano frasi fatte, invece erano vicende da lui vissute e sofferte, ma che alla fine erano foriere di ottimi risultati nell'interesse della famiglia.
Oggi, alla mia rispettabile età di settanta anni suonati, spesso mi accade di fare azioni o discorsi che, a suo tempo, erano il modo di comportarsi di mio padre.
La prima persona che mi fece costatare quanto sopra fu mia mamma, la quale il giorno che noi due andammo a Roma per un pellegrinaggio al Divino Amore, mi disse: "Cocco, spesso quando stiamo insieme ho la sensazione di stare con il babbo, tu hai un modo di fare e di dire certe cose, come faceva il babbo tuo".
Quel giorno trascorsi tutta la giornata con un imbarazzo tale che condizionò il mio agire, ma fui felice perché, grazie a Dio ed alla Madonna del Divino Amore, dopo molto tempo, rividi il sorriso sulle labbra di mia madre.
Nello spaccio del 1° Reparto Autonomo Ministeriale veniva venduta ogni grazia di Dio dagli alimenti, al vestiario e, come di consueto, era gestito da militari che dovevano rendere conto ad un maresciallo.
Quando alla sera restavano delle paste perché non vendute, verso le ore 21, il responsabile dello spaccio aveva avuto disposizione di svendere le paste ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato. In poche parole una pasta, dopo le ore 21, si pagava un terzo del prezzo praticato.
Un giorno ne combinammo una veramente grossa. Con voce camuffata uno di noi telefonò allo spaccio ordinando, a nome di un generale, quaranta paste, in prevalenza bignè, con la crema e con la panna.
Ad una certa ora, andammo allo spaccio per prendere una bibita, ci soffermammo e vedemmo che dentro una vetrinetta erano dei pacchi, chiaramente, contenenti le quaranta paste, in attesa di essere prese dal generale o da chi per lui.
Giunti quasi alle ore 22, orario di chiusura dello spaccio, mentre il maresciallo, nervosamente si aggirava tra il bancone e la cassa, noi aspettavamo, meno "nervosamente" del maresciallo che, dopo aver guardato l'orologio, che portava nel taschino del giubbetto, dette uno sguardo ai due militari, che stavano dietro il bancone, attendendo un segnale per potersene andare.
Il segnale fu fatto con un segno del braccio, come per dire: "vai".
Ci fu offerto l'acquisto delle paste a dieci lire cadauna. Eravamo in cinque, in un attimo i contenitori delle paste erano vuoti, mentre le nostre gole erano saziate.
A volte, anche un "generale immaginario" può servire la truppa; senza recare danno a nessuno.
Tante altre vicende ho vissuto, a Roma, con i miei amici, all'epoca del servizio militare.
E' da premettere che, prima del servizio militare a Roma, ero stato nella Città eterna, solo un paio di volte in compagnia dei miei e sotto la guida di mio cognato Vinicio, che conosceva la città.
Ricordo la prima sera che uscii da solo, mi avventurai fino a piazza Cinquecento, consumando un caffè al bar Giuliani andando poi, a fare una esplorazione dentro la mastodontica stazione Termini, dalla quale uscii stordito, anche se all'epoca era ancora possibile girare senza correre quei rischi che oggi, sono all'ordine del giorno. Ogni sera facevo qualche chilometro in più fino a che riuscii ad andare a San Pietro, una delle mie mete preferite.
Una volta presa un certa conoscenza della città ed un'autonomia nel muovermi, senza chiedere informazioni, incominciai ad uscire anche di notte per ammirare le bellezze di Roma ed avere anche il piacere di sentir cantare il biondo Tevere e provare quelle piacevoli sensazioni, che solo la Città eterna può dare.
Veramente non mi stancavo mai di scoprire cose nuove. A me piaceva tanto stare, in silenzio, a guardare il Tevere; mi dava una sensazione tutta particolare, mi sembrava di sentire delle voci, come se qualcuno mi parlasse.
Non nascondo che, nella spensieratezza del momento, ogni tanto affiorava il desiderio di avere vicino i genitori, mia sorella e Vinicio con i due piccoli nipoti di cui Mauro già frequentava la seconda elementare, mentre Carlo aveva appena un anno.
Una mattina, dopo essermi preannunciato, telefonicamente, con l'amico Pinci, andai alla Segreteria del Ministro della Difesa, dove trovai il dottor Gilberto Bernabei, Segretario dell'onorevole Giulio Andreotti, con il quale ebbi un piacevole scambio di saluti.
Quello non fu il solo ed unico incontro, altri ne seguirono, sempre amichevoli ed affabili.
Appena avevo tempo libero, andavo nella Basilica di San Pietro, soffermandomi prima come, cristiano, a pregare, poi come turista per vedere le bellezze, che non stancano mai.
Un giorno ebbi il piacere di conoscere un monsignore americano che aveva il cognome, in lingua straniera, simile al mio, mi sembra che disse di chiamarsi Matteaxj il quale, molto carinamente, mi rimediò due permessi per visitare i Giardini vaticani.
Quella fu un'esperienza che non dimenticherò mai.
Ricordo pure che lo stesso monsignore, che incontrai successivamente, procurò due permessi per l'udienza pontificia alla quale ci andai, mi sembra, con Giulio Berettoni.
Altre zone di Roma divennero mio punto di riferimento per fare passeggiate che potessero, saziare la mia sete di conoscere fra i quali: i Fori imperiali, Trinità dei Monti, il Pincio, Villa Borghese, il Gianicolo, Fontana di Trevi e, di giorno, l'EUR.
Queste sono state zone che hanno lasciato un segno nella mia vita militare, perché a Roma, mi sono divertito e mai mi sono annoiato, perché in quei luoghi si può solo sognare e sperare di poterci ritornare.
Un giorno il mio compaesano Giulio Berettoni manifestò il desiderio di assistere ad uno spettacolo musicale alle Terme di Caracalla, ma non riuscì a trovare il biglietto perché era tutto esaurito; lo vidi accorato, pensai di fargli un bel regalo.
Telefonai alla segreteria dell'onorevole Giulio Andreotti, che era ubicata in Piazza Montecitorio e, grazie alla segretaria, signora Enea, rimediai il tanto sospirato biglietto. Ci volle poco per fare felice un amico.
Questo episodio deve essere rimasto molto impresso a Berettoni che, dopo circa quarant'anni, si è ricordato del fatto, ringraziandomi ancora, in occasione di una mia visita a Gubbio ed un incontro con il dottor Mauro Fumanti, medico di famiglia dei miei zii, Adamo e Ida.
Si avvicinava il giorno di richiedere la licenza ordinaria perché la data del congedo era vicina e già si diceva che, probabilmente, la ferma militare sarebbe stata leggermente ridotta
Attendevamo il famoso fonogramma che iniziasse con il numero 4000; era ormai certa e consolidata la notizia che, il fonogramma, recante norme per il congedo, avesse il numero 4000 come iniziale di un numero più lungo di protocollo.
Ritornare a casa, con il bagaglio di esperienza della vita militare era un fatto positivo, come il ritornare tra le quattro mura di casa era cosa ambita, ma pensare di dover abbandonare una città come Roma, faceva male al corpo e all'animo.
Roma è una città che non stancherà nessun visitatore, perché non si finirà mai di scoprire nuove cose, nuove tradizioni, nuovi ristoranti ed apprezzare il turismo, con tutto quello che rotea intorno.
Roma è Roma, quindi è veramente la città più bella del mondo, in particolare se si guarda con gli occhi dei vent'anni.
Certo da qualche tempo, Roma, la vedo come il centro di un grande ospedale dove purtroppo, sono dovuto andare molte volte, ma grazie a Dio sono sempre ritornato a casa, guidando la mia macchina.
Ciò che oggi, attira la mia attenzione a Roma è soltanto la Basilica di San Pietro, centro della cristianità, dove ho trovato la vera serenità dell'anima e del corpo.
Comunque i ricordi sono il miglior carburante della vita; soffermarsi a pensare per ricordare, significa accendere un interruttore nel cervello che ti fa vedere, nello schermo della fantasia: come eri, quello che hai fatto, quello che volevi fare, quello che non dovevi fare.
Questo interruttore, spesso, si fa funzionare, soprattutto se nella vita non si ha nulla, di immediato, a cui dedicarsi o nulla che possa intrattenere la fantasia, per distogliersi dalla sofferenza del silenzio.
Allora, per vivere e per far vivere il mio cervello, spesso chiudo gli occhi per fare un viaggio, nel passato, in compagnia di chi mi ha fatto sorridere e delle volte di chi mi ha fatto piangere.
Sì perché non è vero che un uomo non deve piangere.
Se quel pianto serve a lenire certe sofferenze o a rimpiangere certi bei momenti, ricordando chi ti è stato vicino, dico: "Piangi, piangi e sii sereno nel proporre, a te stesso, che l'ultima cosa che vorrai fare è morire".
Però, finché in questo mondo, hai la fortuna di sorridere o piangere, non dimenticarti di coloro che furono, perché se tu sei, sei, solo perché loro sono stati.
Quindi parla, parla di loro, perché: "Si muore quando si è dimenticati!".
Quel periodo lo ricorderò sempre come la fine di un tempo importante della mia vita e l'inizio del secondo periodo che ho vissuto serenamente per molti anni.
La cosa che mi dava particolarmente fastidio era il sentir dire, dalla quasi generalità dei giovani, che la vita militare era brutta; poi al termine della stessa sentir dire dagli stessi che avevano dei rimpianti per i bei momenti trascorsi in grigio verde.
Parte della correzione delle bozze del presente testo, come questa, l'ho fatta in data 21 settembre 2007; in quell'occasione, nel ringraziare Dio, per la benevolenza dimostratami, gioisco per quello che ho, in particolare per la nascita di quattro magnifici nipoti: Federica, Daniela, Iacopo e Viola.
Di più da Dio non potevo avere! Grazie Signore!
E' pur vero che ogni età ha i suoi obblighi, i suoi svaghi, le sue abitudini, i suoi doveri; senza dimenticare i propri difetti, con le sue esigenze, e i suoi diritti, i suoi malanni che troppo spesso, non sono tenuti nella debita considerazione.
Comunque la vita è bella, bisogna saperla vivere o meglio bisogna saper "portare la propria Croce" che, sicuramente, è più leggera di quella che ha portato, per la nostra salvezza, nostro Signore Gesù Cristo.
Con l'approssimarsi del mio congedo dal servizio militare chiesi la licenza ordinaria che consisteva in giorni 15, più due di viaggio. Non nascondo che, quando giunsi vicino al momento di tornare a casa, dopo diciotto mesi, di cui oltre dodici trascorsi a Roma, in me c'era un poco di tristezza.
E' pur vero che tornavo dai miei cari, che comunque vedevo ogni settimana, ma era giunto il momento di togliersi la divisa, anche se è vero che tutte le sere, quando volevo, potevo mettermi in abiti civili. Allora riflettei e ringraziai Iddio e i miei genitori per quanto ebbi.
Una cosa che non avrei voluto mai dire, soprattutto perché gli attori principali del fatto, i miei amatissimi genitori non sono, materialmente, qui con me; ma sono certo che, come ieri anche oggi mi stanno vicino e mi accompagneranno fino a quando li raggiungerò in quel luogo dove il tempo non conta. Amato babbo, amata mamma, ricordate quello che volevate vedere quando ritornavo in licenza? Volevate vedere il mio portafogli, per accertarvi se io avevo sufficiente danaro, allo scopo di evitare, come dicevate, " che io soffrissi". Avevo sempre, danaro a sufficienza; voi vi lamentavate dicendomi che spendevo poco denaro, anche se il babbo mi aveva insegnato quella famosa frase che così diceva: "Entra povero, che uscirai ricco".
Questo insegnamento il babbo me lo diede affinché io lo mettessi in pratica, nel modo in cui mi sarei dovuto comportare nella società, cioè, apparire modesto, all'arrivo in un certo ambiente o nel presentarmi in qualche riunione, per uscire poi, ricco di stima e ammirazione. Se poi, il motto lo si vuole trasferire nel lato economico, esso vuol dire, non ti allargare ad offrire e spendere perché, al momento apparirai ricco, ma quando uscirai, dal luogo dove ti troverai, sarai povero. Caro babbo, quella fu una grande lezione di vita! Sebbene tutto, voi e mamma vi preoccupavate “che io soffrissi”. Ebbene io, il danaro che voi mi davate, l'ho sempre "companaticato" e, quando tornavo a casa, sapendo il vostro "vizietto", di voler vedere quanti soldi avevo, mi facevo prestare, da un caro commilitone, una certa somma, che restituivo subito al mio rientro in caserma. Voi eravate troppo magnanimi ed io, con quanto mi davate, potevo star bene e, credete, sono stato sempre bene, mai mi è mancato qualcosa, se non la vostra presenza, il piacere di sentire il babbo russare e la vostra benedizione serale.
Grazie miei cari, grazie di tutto quello che mi avete insegnato, dato e consigliato; soprattutto, grazie, grazie per avermi dato la vita. Oramai ero diventato pratico di Roma, era piacevole uscire conoscevo: mezzi di trasporto, luoghi, trattorie, e quant'altro poteva far comodo frequentare a vent'anni. Dovevo lasciare "l'eredità" ai miei amici che avevano ancora da fare qualche mese di naja, eredità che ebbi quando altri amici andarono in congedo. In altre occasioni, quando un militare va in congedo si dice che lascia la "stecca" che poi sarebbe una tavoletta dove si tracciano dei segni atti a contare quanto tempo manca per andare in congedo. Al mattino, dal mio ufficio, sentivo gridare un numero, che andava giornalmente a diminuire , per esempio: "30 all'alba"; il giorno dopo "29 all'alba" e così via.
Ricordo che, quando ero recluta ad Orvieto, la sera suonarono il silenzio fuori ordinanza, vorrei essere creduto; piansi, piansi per la commozione; quel suono di tromba, quelle parole entrarono nel mio cuore e ancora, alla mia non più giovane età, risuonano come se li sentissi ora anche se, veramente alla sera, sento suonare il silenzio nella caserma dei Sottufficiali di stanza sulla strada Cimina.
Il comandante, su proposta del maresciallo Consoli, mi concesse una licenza di giorni tre più due, in attesa di sapere, più o meno, la data del congedo. Venni a casa e mi dedicai completamente alla politica; trascorrendo tutte le giornate nella Sezione della D.C., in via San Faustino n.19, dove conobbi, in quell'occasione, la signorina Giuseppina Cuccodoro, che incaricai di organizzare il Movimento femminile della Democrazia Cristiana. La signorina Pina, come la chiamavamo noi, di professione bidella comunale, è stata un elemento portante della D.C., era instancabile, correva da tutti ed era a disposizione di coloro che chiedevano un aiuto.
Mai le ho sentito dire che era stanca, mai, le ho sentito dire una parola di critica verso qualcuno; più che democristiana era veramente una grande cristiana dalla quale tutti, tutti avevamo da imparare. Altra cara persona era la signora Ida Smafora, vedova Sensi, di professione infermiera al civico ospedale. Della signora Ida ho anche un ricordo per la assistenza data a mio padre quando era ricoverato in ospedale nel 1949. Mamma, sempre grata, divenne molto amica della signora Ida che in un suo particolare difficile momento fu ospitata, a casa nostra, per circa due mesi, come se fosse stata una componente della famiglia. In quel periodo conobbi tanti altri amici che sono stati perni della D.C. Ricordo Michele Guagliardo di Monterazzano, Pasquale Benvenuto, altro caro amico, che poi è stato un mio braccio destro, fu Primo Paolucci che, ci dette in locazione un appartamento in via Amendola 17, dove trasferimmo la sede della D.C.
Altro grande amico, più che collaboratore, è stato mio cognato Vinicio Galeotti il quale mi è stato sempre vicino per ogni attività propagandistica, come pure l'amicizia di Pellegrino Fallea fu sempre preziosa. Fallea, detto Rino, aveva un'auto Fiat 1100 di colore nero che spesse volte ho guidato; fu con quell'auto che detti gli esami per prendere la patente di guida. A tale proposito, voglio ricordare quanto accadde il giorno che sostenni gli esami per ottenere la patente. Premetto che non presi lezioni di guida e di teoria, mi presentai in viale Trento con la 1100, mi incolonnai dietro alla fila di auto che seguivano quella dove era l'ingegnere della Motorizzazione con l'istruttore di guida. Mentre la macchina che era capo fila si stava per muovere, si avvicinò a me un signore, alto e biondo, molto sorridente, che mi disse: "Ma che lei deve sostenere gli esami per la patente?".
Alla mia risposta affermativa, soggiunse: "Guardi che se la vedono alla guida dell'auto, senza avere seduto, al suo fianco, uno che abbia la patente, lei viene subito bocciato". Fu un attimo, per capire che stavo commettendo un grosso errore; infatti, avevo solo il foglio rosa e, per poter condurre l'auto, dovevo essere affiancato da un patentato, che rimediai subito. Sostenni gli esami di guida nel breve tratto che va da via Annio a Fontana Grande: fui promosso. Ringraziai poi quella persona che, mi dette quel prezioso suggerimento, seppi essere il signor Montemari, padre di un giovane che conobbi quando venne a lavorare, come impiegato, al Comune di Viterbo. Per quanto riguardava la organizzazione della Sezione incominciai a redigere l'elenco dei soci, prendendo in carico gli iscritti, provenienti dalla ex sezione del Partito.
Ebbi una grande richiesta di iscrizioni al Partito, ma noi eravamo restii a concederle se non sufficientemente avallate da vecchi soci. Al ragioniere Gianfranco Faperdue, collaboratore del Messaggero, fu conferito l'incarico di organizzare il Movimento giovanile e di curare la SPES (Servizio Propaganda e Stampa). Il Consiglio della Sezione era composto da persone che avevano il solo scopo di fare gli interessi della D.C., sacrificando il tempo della famiglia per metterlo al servizio del Partito. I giorni passarono veloci, la mia presenza a Viterbo era attesa e gradita, come del resto notai che a Roma c'era un certo malumore sul fatto che era giunto il momento di abbandonare tutto e di cedere le mie incombenze all'Eugubino Giulio Berettoni e al siculo Carmelo Pistorio. Arrivai al giorno di dover fruire della licenza ordinaria, praticamente tra un permesso ed una licenza non mi mancò il piacere di stare a casa, il più possibile.
Per dovere, debbo ricordare che a Roma fui ospite, non solo di zia Anna e zia Ida, ma anche dallo zio Giulio Picchi, che era cugino di mio padre, il quale è stato sempre molto caro, come lo è stata sua moglie. Ricordo che ho frequentato la loro casa, nel quartiere Prenestino, i primi giorni in cui sono stato trasferito a Roma poi, per il fatto che le zie di Montemario erano le sorelle di mamma, quindi affettuosamente più vicine a me, optai per quest'ultime, serbando sempre un senso di gratitudine e di affetto per lo zio Giulio e famiglia, che conobbi poco tempo prima del servizio militare. Sinceramente, ciò che accadde il giorno del mio congedo, non lo ricordo; ho tanto la sensazione che sia stato un giorno che non ha lasciato alcun segno se non quello di dover abbandonare care persone che, quasi sicuramente, non avrei mai più riveduto, come poi è capitato, ad eccezione del cavaliere Gaetano Consoli, che rividi a Vetralla; del maresciallo Americo Frontori che, nel '78, venne nella mia abitazione per chiedere un favore che, riuscii a fargli, grazie all'amicizia che avevo con il colonnello Localzo, comandante della Scuola Sottufficiali di Viterbo. Altro gradito e magnifico incontro lo ebbi, nella mia casa, con l'amico Nicola Chieppa, avvocato di Andria.
Oggi ricorre il trentanovesimo anniversario di matrimonio, posso ben dire che ricordare e guardarsi intorno è scioccante, per il fatto che molti, troppi, non sono più tra noi; importante è aver avuto, da questo matrimonio due, magnifici figli: Patrizia e Giuseppe, che mi hanno dato e mi danno tante soddisfazioni. Comunque importante è essere stato, essere ed impegnarsi a continuare ad essere, perché la vita è bella, va vissuta, amata come attore principale e non come fantoccio, perché già ce ne sono tanti, forse troppi. Quei troppi hanno rovinato il mondo, perché hanno fatto sì che certi valori sono venuti meno e il mondo va a rotoli.
In questo ruzzolone, mi auguro che quelli a me cari, ne restino fuori. Chiedo scusa, a chi sta leggendo, per la mia divagazione; ne avrà trovate altre come, sono certo, ne troverà ancora; forse serviranno a rendere meno pesante la lettura. La sera che giunse l'attesa comunicazione, a mezzo fonogramma, era il 23 Marzo 1960 ed ero di servizio, ricordo che trillò il telefono, stavo all'erta per sentire se i primi quattro numeri di protocollo, erano 4000, perché si aveva così la certezza che il testo parlava del congedo; così fu, infatti la circolare aveva il numero 40001/211/T.
Si diceva che il congedo, per fine ferma, doveva avvenire il 6 Aprile 1960; emisi un grosso sospiro, misto di gioia e di tristezza. Comunque era finita! Come ogni avvenimento atteso e desiderato viene festeggiato, anche il congedo fu festeggiato; chiedemmo il permesso T.S.T.che ci fu concesso con la raccomandazione dell'aiutante maggiore, capitano Enzo Petrucci: "Mi raccomando non ritornate ubriachi". Organizzammo una cena in un locale, in via Gioberti, dove normalmente andavamo a mangiare; devo dire la verità, come l'ho detta in tutto quello che ho scritto, non ricordo coloro che andarono in congedo insieme a me, se non Chieppa, e Di Pinto, certo è che a quella cena eravamo cinque o sei. Mangiammo moltissimo, ricordo, che mentre aspettavamo gli antipasti, vedemmo venire verso di noi un cameriere con dei supplì fumanti che domandò se li avevamo ordinati noi; non ce lo facemmo dire due volte, con tanta faccia tosta uno disse che li avevamo ordinati, li prendemmo e li mangiammo.
Dopo un pochino tornò il cameriere infuriato perché nella saletta confinante erano delle persone che rivendicavano i supplì. Iniziò la cena sulla base di quanto avevamo ordinato, mangiammo tanto, veramente tanto che un signore che stava seduto vicino a noi, in procinto di mangiare una mozzarella e due foglie di verdura, disse: "Io vi pagherei un pranzo solo perché questa sera, vedendovi, mi avete fatto venire l'appetito; rinuncio alla mozzarella e mi faccio portare una pastasciutta e una bistecca come quella che avete mangiato voi; se accettate vi voglio offrire... "non terminò la frase che uno di noi, penso Di Pinto, disse: "un'altra pastasciutta". Scoppiammo a ridere e la risata fu seguita da un: "grazie, si accomodi nel nostro tavolo e mangi questa pastasciutta insieme a noi". Ci fu portata un'altra pastasciutta che mangiammo tranquillamente, tra una risata e l'altra, il gradito ospite mangiò tanto anche lui che volle pagare la pastasciutta, i supplì e due bottiglie di spumante. Voglio evidenziare che io ero astemio, quindi quella sera un bicchiere di buon vino ed un bicchiere di spumante, tanto per fare brindisi augurali, li bevvi, ma mi erano arrivati alla testa. I miei amici stavano peggio di me. Alle ore 3 del mattino, ci avviammo verso la caserma, ma alle nostre orecchie risuonò quanto ci disse il capitano Petrucci nel momento che ci concesse il permesso T.S.T. Rinunciammo di entrare in caserma, in quelle condizioni, decidemmo di andare a Villa Borghese, trovammo alcune panchine libere dove ci mettemmo a dormire. Non è il caso di dilungarmi su quanto accadde, per rispetto di chi legge e di chi sono stati gli attori dell'avvenimento.
Certo è che, verso le ore sette, fummo svegliati da due signori che transitavano vicino a noi. Ci vergognammo come ladri, ci rinfrescammo in una fontana e ci avviammo poi in caserma "lucidi", tanto che l'Ufficiale di Picchetto disse: "Si sente che avete bevuto, ma vedo che rientrate in posizione verticale, questo è già tanto". La nostra preoccupazione era quella di deludere il capitano Enzo Petrucci perché aveva tanta stima nei nostri confronti e, per la sua bontà, non avrebbe meritato vederci in certe condizioni che, oltre alla persona offendevano pure la divisa. La mia vita stava per prendere una nuova strada perché quella che avevo intrapreso, al servizio dello Stato, era finita. Fui collocato in congedo illimitato il 6 aprile 1960, con l'idoneità al grado di sergente, in caso di richiamo alle armi, a decorrere dal 5 aprile 1960. Il mio numero di matricola era 42236 e le note caratteristiche erano: Robustezza/ molta; condotta in servizio e fuori servizio/ottima; cura dell'arredo sufficiente , istruzione militare/sufficiente, istruzione letteraria /ragioniere, attitudine all'avanzamento/sergente.
Le amicizie le avevo continuate ad alimentare, anzi notai che ero atteso, sia per quanto riguardava il trascorrere delle giornate festive, che per quanto riguardava il vivere giornaliero. Il babbo, come già detto vendette il "Topolino" allo scopo di farmi stare tranquillo ed evitare la tentazione di fare lunghi viaggi per venirmi a trovare; in particolare volli che vendesse l'auto allo scopo di evitargli di venire a Sulmona. Appena giunto a Viterbo il babbo, dal signor Stelio Stavagna, dipendente comunale e grande sportivo quale giocatore di calcio, mio amico, acquistò un Lambretta 125, che utilizzava per andare a bottega e qualche volta a caccia. Ricordo che una mattina, molto fredda, andammo a caccia alla Bicocca, alla guida della Lambretta ero io; il babbo stava dietro di me, ricordo che, caramente, mi teneva le sue mani sulla fronte allo scopo di riscaldarmi la testa, evitando così un eventuale malanno.
Oggi la Lambretta del babbo è di mio nipote Mauro Galeotti, il quale ci teneva molto ad averla come ricordo del nonno, che gliela donò, ed al quale ha sempre voluto tanto bene. Ripresi a collaborare con l'onorevole Attilio Jozzelli, il quale ha sempre fatto capire che apprezzava il mio lavoro. Con il tempo sentii necessità di prendere una strada diversa, che mi rendesse indipendente e fossi valutato per quel che valevo, facevo e dicevo e non per quello che rappresentavo. Questo discorso lo feci all'onorevole Jozzelli che lo apprezzò molto. Nel 1961 si fece il Censimento della popolazione e dell'agricoltura, pensai che sarebbe stato opportuno farlo, come rilevatore statistico, presentai la domanda, sostenni gli esami risultando vincitore. Vari funzionari gestivano le operazioni, fra i quali il dottor Filippo Franchi, funzionario della Camera di Commercio e Agricoltura di Viterbo il quale, nei miei confronti, fu di una squisitezza infinita. Altro funzionario era il dottor Quarantotti, di Tuscania, che credette sulle mie capacità. Mi fu assegnata la zona dei Cappuccini, Paradiso fino ai piedi della Palanzana. Partivo al mattino, portandomi appresso uno sfilatino per il pranzo in modo di non perdere tempo perché mi fu detto che: "Se terminavo il lavoro prima degli altri, sarei stato utilizzato, come impiegato, per lavori interni".
Mio cognato mi mise a disposizione la sua moto Parilla con la quale potevo muovermi più velocemente. In poco tempo consegnai gli stampati idonei ad effettuare la dichiarazione censuaria che si doveva effettuare ad una determinata data, presa per base di riferimento del censimento. Una volta trascorso quel giorno, si dovevano ritirare i modelli, accertarsi che fossero stati, correttamente, compilati e restituirli al Comune all'Ufficio Centrale del Censimento. Da quel lavoro derivarono apprezzamenti, sulla mia persona, che mi sono stati utili; fui chiamato a prestare attività lavorativa nell'Ufficio Centrale del Censimento. Intanto nel mondo politico di Viterbo ci furono mutamenti nella direzione della D.C. fra i quali ci fu la realizzazione del mio grande desiderio di intestare la sezione a "Luigi Sturzo", cosa che avvenne con una bellissima cerimonia. Nei primi del mese di giugno 1961 scrissi all'onorevole Giulio Andreotti per chiedergli un equipaggiamento da calcio perché avevo idea di fondare il gruppo sportivo "Luigi Sturzo". Il carissimo ministro Andreotti mi inviò un completo "Gradella" sport da 18 magliette, pantaloncini, scarpe, due palloni, due paia di guanti e due cappellini. In data 6 luglio 1961, a firma del dirigente "Libertas" della Sezione D.C. "L. Sturzo", Vinicio Galeotti, mio cognato, valido collaboratore, di poche parole, molto stimato e conosciuto per la suo modo di fare; con protocollo n.172/BM/lib/bm, fu inviata una lettera, a tutti gli iscritti di sezione ed ai reverendi don Angelo Massi, della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ed a don Gabriele Jannariello, parroco di San Faustino, con la quale portavamo a conoscenza che avevamo intenzione di istituire il Gruppo sportivo "Luigi Sturzo" e chiedevamo, nel contempo, i nominativi dei giovani che intendevano indossare la maglia della nostra squadra.
Con deliberazione Consiliare, n.7 del 23/01/1962, del Comune di Viterbo, fui nominato deputato del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio della Presentazione, insieme al professore Trento Grani, al cavaliere Stelio Murri ed al geometra Raffele Berretta. L'Ente, del quale era presidente l'avvocato Luigi Maria Boni, era in piazza san Sisto; la carica, non remunerata, cessò il 23 gennaio1966. Quella del Conservatorio fu una bella esperienza perché si stava a contatto con le bambine che avevano bisogno di affetto, anche se in detto Istituto, era presente la Superiora suor Carlomagno, che era veramente da encomiare per l'amore che aveva per le bambine. Accertato che le ospiti dormivano su materassi di crine, volli che si acquistassero di gomma piuma, che all'epoca erano le novità commerciali, allo scopo di rendere, a quelle creature, meno disagevole la notte. Altre cose notai che per me era necessario essere annullate o modificate, come il fatto che le bambine dovevano lavare la biancheria; cosa che vietai disponendo, subito, l'acquisto di una macchina lavatrice per la comunità. Ricordo che dalla Ditta Prosperoni, che aveva un avviata falegnameria, facemmo fare un progetto con la conseguente fornitura di camerette da istallare in un immenso salone diviso da strutture di legno, cosa che le bambine apprezzarono molto. In quel periodo fui nominato anche membro della Commissione Elettorale Mandamentale (CEM) che doveva procedere alla revisione delle liste elettorali di vari paesi, fra i quali Viterbo.
La predetta Commissione era presieduta da un magistrato, la mia prima presenza fu fatta in sostituzione dell'avvocato Eugenio Fiore Melacrinis, di cui mio padre si onorava essere amico. Intanto dal Comitato Provinciale della D.C, su interessamento dell'amico Onio Della Porta , fui nominato Segretario di Zona per Viterbo-Montefiascone e responsabile per l'emigrazione interna ed estera di amici vicino alla Democrazia Cristiana. Il mio compito, in quest'ultimo incarico, era di far parte di una "maglia" di responsabili che seguivamo il movimento dei Democratici cristiani sul territorio nazionale ed estero, allo scopo di rendere meno pesante la loro emigrazione e di non perdere delle forze politiche elettorali. Avevo contatti epistolari con tutti i paesi d'Italia e con l'estero con lo scopo di agevolare i movimenti degli elettori, che si spostavano per varie ragioni. Quando lavoravo con l'onorevole Jozzelli, presi l'onere di soddisfare una richiesta di forze lavorative della "SNIA Viscosa" di Torino, la quale mi contattò, quale segretario dell'onorevole stesso.
Mi furono richieste settanta unità di personale lavorativo, garantendomi tutto l'aiuto possibile per rendere meno gravoso il trasferimento degli stessi. Presi contatti con vari segretari di Sezione della provincia allo scopo di avere segnalazioni nominative, di persone che avevano intenzione di accettare il lavoro a Torino. Gli appetiti di un buon lavoro fecero accorrere molte persone nello studio di via Matteotti, 50/D, dove aveva sede la segreteria dell'onorevole Attilio Jozzelli. Notai che molti, futuri, dipendenti della SNIA Viscosa erano sposati ed avevano a carico, oltre che la moglie, anche i figli; compenetrandomi nel loro stato d'animo, che era rattristato per il distacco con la famiglia, tentai di giocare una carta con il Direttore generale della SNIA Viscosa. Chiesi di poter ottenere un alloggio per ogni capo famiglia allo scopo di consentire l'emigrazione di tutto il nucleo famigliare dei settanta lavoratori; logicamente con una compartecipazione, minima, di spesa da parte del lavoratore.
La richiesta, che logicamente rappresentai a nome dell'onorevole, fu accettata come pure fu richiesto l'interessamento per la frequenza dei bambini negli asili locali, allo scopo di esaminare la possibilità di far lavorare, se richiesto e gradito, anche le mogli. Ricordo che l'onorevole Jozzelli rimase molto soddisfatto del mio operato. Gli procurai, poi, un incontro con le nuove forze di lavoro della SNIA Viscosa, convocandoli nello studio, per un ultimo saluto, prima di partire per Torino. Un giorno, di un periodo pre-elettorale, quando tutte le nostre attività erano indirizzate verso gli elettori, l'onorevole Jozzelli mi pregò di andare a sentire cosa avrebbe detto, l'onorevole Terracini in un comizio che, sul tardi, avrebbe tenuto a Bracciano. Il motivo derivava dal fatto che l'indomani, sulla stessa piazza, per la Democrazia Cristiana, l'onorevole Attilio Jozzelli avrebbe tenuto un comizio. Mi recai sul luogo dove era già preparato il palco sul quale l'onorevole Terracini, noto personaggio politico del Partito Comunista Italiano, avrebbe dovuto parlare. Intorno erano tutte bandiere rosse, la gente affluiva in massa, proveniente da un punto in cui si erano fermati degli autobus. All'ora stabilita il comizio incominciò; l'oratore iniziò ad attaccare la politica della Democrazia Cristiana e i suoi uomini.
Stenografai quanto diceva l'onorevole Terracini, senza lasciare né un concetto, né una parola; ciò non mi rimaneva difficile perché ero bravo in questa materia. Terminato il comizio, misi in tasca il blocco notes contenente il tutto e con l'auto, messa a disposizione dal Partito e guidata dal cavaliere Marino Amatrudo, rientrai a casa dove mi misi subito a tradurre quanto avevo stenografato, usando la macchina da scrivere portatile, che presi in Sezione. Riempii vari fogli che, verso le ore 23,30, portai a casa dell'onorevole, in via Zara n.70, il quale rimase letteralmente stupito dell'ottimo lavoro fatto, dandomi tanta soddisfazione Ritornando sul "pensiero": "se qualcuno leggerà questo scritto", mi corre l'obbligo precisare che nella mia testa c'è una grande confusione che scrivendo e rievocando il passato dei miei sessantanove anni i fatti mi appaiono come li ho raccontati. Probabilmente ci saranno accavallamenti di ricordi, ma ciò dovrebbe essere ininfluente perché importante è che quanto ho scritto sia vero e, credete, tutto è vero, sia nel bene che nel male. Nel 1961 andai a Gubbio dove ebbi modo di trascorrere vari giorni di "paradiso" tra l'affetto di nonna Assunta e di zio Emilio, oltre agli zii: Dante, Giuseppe, Giuseppa, Letizia ed Ubaldo, logicamente con le loro mogli o mariti, rispettivamente: Ida, Luciana, Daniele, Lina. Furono momenti, quelli trascorsi a Gubbio, che hanno lasciato un segno nella mia vita, sia per l'amore verso la "terra dei miei avi" che per avermi dato la possibilità di apprezzare di nuovo le qualità degli Eugubini, che sono affettuosi e ospitali, doti che già notai quando, nel 1943, andai come "sfollato" e che continuo ad apprezzare ancora oggi. Non sempre si può parlare di cose belle perché, quando meno ce lo aspettiamo, come è detto nel Vangelo, arriva la morte.
Il 10 luglio 1962, tra l'affetto dei miei cari, stavo festeggiando il mio ventiseiesimo compleanno, quando giunse la notizia che zia Pina, di anni trentadue, stava malissimo; il giorno successivo rese l'anima a Dio, lasciando tutti nel dolore. La vita politica dava sempre maggiori soddisfazioni perché con la posizione che ricoprivo potevo aiutare qualche persona che non se la passava troppo bene. Oggi posso dire, con tanta soddisfazione, che ho aiutato molte persone in vari settori e varie richieste, senza mai chiedere nulla. A ragion del vero debbo riconoscere che molti, moltissimi elettori, venivano da me per chiedere se avevo qualche candidato da segnalare e, di questi non mancavano mai. Certo è che mai ho condizionato un favore ad un voto o ad una contropartita perché sono partito, sempre, dal presupposto di aiutare chi aveva bisogno; cosa che mi sarei tanto augurato avessero fatto ai miei genitori, quando ebbero bisogno di aiuto e non gli fu dato. Ero arrivato ad un punto che provavo piacere e serenità d'animo ogni qualvolta potevo aiutare una persona. Un anno ricordo decidemmo di fare la "befana" ai figli degli iscritti. Organizzai il tutto con l'acquisto di giocattoli e viveri dalla ditta "FULSEN" di Fulli e Sensi che aveva il negozio in via della Pace, davanti alla caserma dei Carabinieri. Da Roma mi inviarono vari quintali di pasta che, grazie alla ospitalità dai Padri Agostiniani della Trinità depositai, per vari giorni, in un locale che misero a mia disposizione. Gli iscritti gradirono molto l'iniziativa, che poi ripetemmo anche negli anni successivi.
Pur di stare, il più possibile, a contatto con gli iscritti residenti a Monterazzano, tutti i sabati proiettavo un film nei locali del borgo. Andavo là, alla sera, con la moto "M.V." del Partito, portando un proiettore e la pellicola che, prendevo a noleggio a Roma, tramite le suore Paoline. Erano momenti in cui ho dato il meglio di me alla D.C. e a tutti gli iscritti che, una volta eletto Segretario di Sezione, mi hanno riconfermato la loro fiducia rieleggendomi, nella carica, per oltre trent'anni. Il 22 agosto 1962, in via Matteotti, davanti al negozio dei fratelli Rossini, conobbi mia moglie; a tale proposito intendo ricordare, con piacere, tutto quanto possa riguardare i miei figli che sono stati, sono e saranno, al centro dei miei affetti con i loro figli. Ricordo che, quando si facevano programmi per un futuro a due, io proposi di chiamare nostro figlio Giuseppe, come il nonno, mio padre; mentre per la femmina fu scelto il nome Patrizia.
Dopo pochi giorni, alla mia fidanzata, che scelse il nome per la femmina, regalai una bellissima bambola con scritto sul coperchio della scatola Patrizia, con la speranza di poterla avere in carne ed ossa. Trascorsi altri pochi giorni le regalai un bel bambolotto con scritto sulla scatola Giuseppe. Tutto il resto fu posto, nelle mani di Dio e del destino; come ieri, oggi e sempre, è stato, è, e così sarà. Nella vita si fanno tanti programmi; sarebbe un guaio se non fosse così! L'essere umano deve pensare, programmare, fare, senza stancarsi di pregare, non solo per chiedere ma, soprattutto, per ringraziare Iddio; cosa che io faccio oggi e farò nel futuro per ringraziarlo, per avermi dato due perle di figli: Patrizia e Giuseppe. Nel corso dell'anno 1962 acquistai la mia prima autovettura, si trattò dell'Alfa Romeo 1300 cc. Giulietta targata VT 31874, di colore celeste, con il cambio al volante. La macchina, acquistata dall'onorevole Attilio Jozzelli dal signor Guerrino De Santis, concessionario dell'Alfa, con negozio a Viterbo in via Saffi, fu poi venduta, per motivi che non sto qui a spiegare, all'autista Giuseppe Cecere, di Montefiascone, dal quale la acquistai al prezzo di lire 600.000. L'atto di passaggio dell'auto fu stipulato il 20 Giugno 1963 perché sull'auto stessa era una ipoteca di lire 640.000, che fu cancellata il 15 giugno.
Mi sentii veramente soddisfatto, era un traguardo che da tempo sognavo raggiungere; è facile immaginare che a me parve di aver toccato il cielo con le mani. La prima cosa che volli fare fu quella di prendere, in locazione, dai signori Pallucca - Petri, un garage in via Cesare Pinzi. In quell'occasione, Bruna e Vinicio mi regalarono un bel paio di guanti, un thermos ed un cagnolino, che muoveva la testa, da mettere nella parte posteriore dell'auto. I miei genitori mi regalarono un bellissimo plaid verde a quadri, i tappetini rossi e neri e il copri-volante in pelle. Il babbo ci volle aggiungere un pieno di benzina, che gradii, come gradii tutti i regali. Il primo viaggio lo feci, andando con i miei genitori, a Zepponami (Montefiascone) per prendere contatti con lo zio Tommaso ed il figlio Luigi (Gigino) per andare a Perugia, più precisamente, a Pietralunga, paese natale del babbo, per una battuta di caccia. Dopo pochi giorni partimmo, destinazione Pietralunga; sulla macchina, oltre ai miei genitori, era Gigino e il padre. La strada non era come quella di oggi, si trattava di una consolare con molte curve; di rettilinei ce n'erano uno o due; io volli approfittare per lanciare la mia Giulietta e vedere a quale velocità arrivava. Per un certo, dovuto, rispetto anticipai, a mio padre ed agli altri ospiti, la mia volontà di lanciare l'auto, al massimo della velocità. Nessuno fece in tempo a dire qualcosa che io affondai il pedale dell'acceleratore e lanciai la mia Giulietta a 130 chilometri e oltre per tutto il tratto davanti a Deruta. Il babbo mi disse che vedeva, alla sua destra, tutti i tronchi degli alberi attaccati l'uno all'altro, per la eccessiva velocità, poi aggiunse: "che sia la prima e l'ultima volta che vai così forte... la gente ci guardava come se fossimo dei pazzi". Il viaggio continuò con una andatura moderata anche perché c'erano da vedere i luoghi dove i miei genitori vissero. Tra il vedere nuove zone, delle quali avevo solo sentito parlare, e ascoltare il rombo della mia Giulietta, per la sua brillante prestazione, l'entusiasmo era al massimo.
Giungemmo in località Carpine, vicino a Pietralunga, dove dormimmo. Al mattino, ci mettemmo in movimento, non tanto per cercare la selvaggina, quanto per giungere nelle immediate vicinanze della casa di "Moraola", località che dette il soprannome ai membri della famiglia Matteacci. Quando il babbo e lo zio Tommaso incominciarono a ricordare momenti ed episodi della loro infanzia, ci fu un momento di commozione. In quell'occasione il babbo mi ricordò l'episodio del pepe facendomi vedere l'orto, dove lo buttò. Ci fermammo un poco, poi ci incamminammo verso altri luoghi che ricordavano, qualcosa al babbo o allo zio. Sul tardi andammo al cimitero di Montone, dove è sepolta la nonna Rosa Cecchini, moglie del nonno Luigi Matteacci, deceduta nel 1913, quando il babbo aveva appena sei anni, dove ci soffermammo a pregare. Mi fece molto male veder lacrimare gli occhi di mio padre, ebbi la conferma che a qualsiasi età si può piangere per i genitori! Dopo essersi fermati, un poco più a lungo, nei paraggi del cimitero, il babbo volle farmi vedere, la località Ronzano, che si trovava dalla parte opposta; dove lui vide, per la prima volta, la luce il 3 marzo 1906.
E' superfluo dire cosa provai in quel momento, l'amore che nutrivo per i miei genitori era tanto che ogni loro ricordo veniva, da me, recepito e scolpito nella mente e nel cuore, certo che, ricordando di loro il più possibile, era per me rivivere i momenti di gioia e di dolore che hanno segnato la loro vita. Il ritorno a Viterbo fu un viaggio silenzioso; si sentiva solo il rumore, piacevole, del motore della mia macchina e, qualche sospiro. Col trascorrere del tempo volli cambiare i fanalini posteriori della Giulietta, con altri più grandi; con l'occasione la feci verniciare tutta, cambiandole il colore, dall'originale celestino a verde bottiglia.
Tanti altri viaggi ho fatto con la mia macchina fra i quali il viaggio di nozze a Parigi e Barcellona; Giulietta che mi ha tenuto compagnia fino all'estate del 1970 quando, a Grosseto, dette i primi cenni di stanchezza, senza mai abbandonarmi, tanto che anche quella volta ci riportò a Viterbo, dove finì la sua storia, rimanendo, oltre che nelle immagini fotografiche e cinematografiche, nel mio cuore, come il primo amore, che non si scorda mai. Dopo aver acquistato l'Alfa Romeo Giulietta acquistai, nel 1970, una Volkswagen Maggiolino, di colore bianco, 6 volt, targata VT 86914, alla quale fece seguito una bellissima Volkswagen di colore giallo, Maggiolone, targata VT 98786; che fu sostituita con una Volkswagen K 70 di colore celeste targata VT 98000 a benzina e gas. Dopo, fece seguito il possesso di una Mercedes 2000, a benzina e gas di colore bianco, targata VT 90655 che fu sostituita, nel 1993, da una Mercedes 2000, a gasolio di colore avorio, targata VT 148690 alla quale ha fatto seguito l'Alfa Romeo 155 T.D. di 2000 cc, di colore testa di moro, targata VT 408379, che acquistai, nel 1993, alla SOVICAR di Viterbo. Di ogni autovettura ho qualcosa da dire; perché tutte hanno avuto una parte molto interessante nella mia vita, quindi ritornerò sull'argomento quando si presenterà l'occasione o qualche avvenimento ad esse collegato.
Con decorrenza 10 settembre 1962, con deliberazione della G.M. n.994 , con altri 24 colleghi, sono stato assunto al Comune di Viterbo, come impiegato straordinario per l'anagrafe tributaria, con un compenso forfetario di lire 40.000 al mese. Da questa data ha avuto inizio la mia professione di impiegato comunale, che ha avuto fine il 31 dicembre 1995, con la mia collocazione in pensione, su domanda. L'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, all'epoca, era ubicato in via Cavour, 77 ed era diretto dal ragioniere Mario Falcioni, con la qualifica di Capo Sezione. Gli impiegati erano: ragioniere Mario Clementi (28/4/1911-27/11/1993), Enzio Cherchi (1916-1996), Umberto Felici, Giuseppe Gatti.
Vigili tributari erano: Armando Alessi e Tommaso Paoletti, usciere era Socrate Stella. Per esigenze d'ufficio sovente si chiedeva la collaborazione di altri due vigili urbani, nelle persone di Vinicio Galeotti, mio cognato, ed Ezio Vivarelli. Ricordo che, qualche giorno prima della mia assunzione, in via Giacomo Matteotti, incontrai il signor Enzio Cherchi il quale, molto carinamente, mi consigliò di andare a lavorare all'Ufficio Tributi, dove prestava servizio anche lui. Mi disse che era un posto di lavoro tranquillo perché era "come stare in una famiglia" e avrebbe avuto piacere avermi come collega. Il suo consiglio fu da me recepito e, sempre, molto apprezzato. Il giorno che entrai, per la prima volta, in Ufficio, capii che il mio nome era stato già oggetto di qualche discorso nell'ambiente dell'Ufficio Tributi perché, dal capo ufficio, fui subito scelto per rimanere nella stanza dove si riceveva il pubblico, mentre tutti gli altri, che mi sembra fossero una decina, furono mandati in una stanza che si trovava nella parte posteriore dell'Ufficio, con l'incarico di fare lavori interni. Mi fu assegnata una scrivania a fianco ad Enzio Cherchi, che stava nel salone. Cherchi è colui che, nel 1937, ebbe modo di agevolare mio padre nell'attimo della concessione della tessera annonaria per ottenere generi alimentari. La gioia di avere un lavoro fu veramente grande, praticamente vedevo realizzato un altro sogno della mia vita. Dopo poco tempo, che lavoravo all'Ufficio Tributi, acquistai una certa dimestichezza sul come comportarmi con i contribuenti; notai, infatti, che sia i colleghi, che i vari contribuenti vedevano di buon occhio il mio modo di fare. C'erano da applicare le norme del Testo Unico della Finanza Locale n.1175 del 14 settembre 1931, e la Legge Comunale e Provinciale.
Testi che io avevo studiato, attentamente, perché non intendevo fare brutte figure davanti alla Commissione giudicatrice del concorso, che io vinsi, arrivando primo. Ogni giorno c'era qualcosa da imparare; io stavo sempre con le orecchie tese allo scopo di apprendere il più possibile perché avevo sete di sapere. Il ragioniere Mario Clementi, che aveva il grado di applicato principale ed era addetto oltre che ai tributi, anche al servizio licenze commerciali, un giorno disse ai suoi colleghi, che da anni lavoravano insieme: "Questo giovane ci farà le scarpe a tutti noi anziani; dimostra di voler apprendere tutti i lavori; certo non sarò io a boicottarlo... largo ai giovani, se lo merita e questo mi pare che abbia le carte in regola per aspirare al meglio".
Caro ragioniere, queste furono le sue parole che ancora sono vive nel mio cuore, grazie caro Mario per quanto mi avete insegnato. La nostra amicizia, caro Mario, continua, suo figlio Raffaele ed io siamo buoni amici, ma la cosa ancor più bella è che suo nipote Angelo è amico di mio figlio Giuseppe. Come pure devo sempre molta gratitudine ed affetto ad Enzio Cherchi che è stato veramente il mio maestro giornaliero di lavoro e di vita, con il quale ho condiviso tanti anni di lavoro, fino al suo collocamento in pensione, rimanendo suo fedele amico, fino a che il Signore lo ha chiamato.
Grazie Enzare' ti ho sempre nel mio cuore! Non da meno posso dire del capo ufficio ragioniere Mario Falcioni, uomo preparato ed onesto, amante del lavoro e della campagna, in particolare dei suoi terreni al Quartuccio e a Bigini. Una volta stavo facendo, al capo ufficio, delle valutazioni sulla capacità contributiva di un contribuente, prendendo in esame i vari cespiti, mi pronunciai così: "... inoltre è proprietario di una vecchia casa...". A questo punto il ragioniere Falcioni mi disse: "E no, voi dovete distinguere una casa "vecchia" da quella che è una casa "antica"; in questo caso dovete attribuire, allo stabile, un reddito maggiore, perché questo signore ha una casa antica e di valore". Penso che quella sia stata una delle poche volte che, il ragioniere Mario Falcioni, mi abbia suggerito il da fare, perché quello che facevo gli andava tutto bene e me lo dimostrò un giorno quando mi disse: "Lei farà carriera". Il tempo trascorreva velocemente, giunse anche il primo stipendio che volli utilizzare, con una integrazione, per acquistare un bracciale d'oro per mamma ed un anello d'oro, con un piccolo ferro di cavallo, da regalare al babbo. Con il passare degli anni mamma cedette, ai fratelli Biaggi, noti orefici viterbesi, il bracciale e, con una aggiunta di danaro, acquistò un bellissimo orologio d'oro, che mi regalò; mentre, purtroppo, l'anello che donai al babbo ritornò a me dopo il 25 agosto 1976, data in cui il babbo fu chiamato nella Casa del Signore.
In politica, verso la seconda metà del 1961, presi totale possesso della Sezione della Democrazia Cristiana, con la qualifica di Segretario; ero io che facevo e disponevo anche se, per rispetto, tante cose prima le discutevo con il dottor Costantino Kuzminsky, che ha sempre condiviso ogni mia azione, con la stessa lealtà che io avevo nei suoi confronti.
Fra i vari consiglieri e collaboratori, che nei vari anni mi sono stati vicino, sostenendomi politicamente e che si sono succeduti nel tempo, voglio ricordare e ringraziare ancora: Antonio Angelosanto, Primo Antonini, Nicodemo Attanasio, Giulio Bugiotti, Renzo Cappelli, Antonio Cappuccini, Alfio Caruso, Mario Ciotti, Santino Clementi, Giuseppina Cuccodoro, Onio Della Porta, Pellegrino Fallea, Mario Fanti, Gianfranco Faperdue, Maria Teresa Fiordigigli, Mauro Galeotti, Vinicio Galeotti, Michele Guagliardo, Costantino Kuzminsky, Nicola Malerba, Marcuccio Marcucci, Renato Mattioli detto Peppino, Giulio Mazza, Raniero Niccoli, Filelfo Paccosi, Manlio Pace, Orlando Pace, Franco Paoletti, Primo Paolucci, Benvenuto Pasquali, Stelio Petroni, Vincenzo Petroselli, Silvano Pierangeli, Aldo Pistoni, Angelo Prosperini, Carlo Quintarelli, Ida Smafora Sensi, Pietro Taurchini, Pierluigi Trecci.
Tanti, tanti altri amici dovrei elencare per la loro amicizia e lealtà politica; mi sono limitato ad elencare solo quegli amici che facevano parte del Consiglio di Sezione o che erano stretti collaboratori e che, senza di loro non avrei potuto fare quanto è stato fatto nell'interesse della Democrazia Cristiana, guadagnando il primato degli elettori nella nostra giurisdizione che era comunista al 90%; divenimmo il primo partito della zona.
Nel 1962 cambiammo sede della Sezione, da via San Faustino n.19 al piano terra, ci trasferimmo in via Giovanni Amendola n. 17 al primo piano; finalmente avevamo una sede, degna della Democrazia Cristiana, composta da un ufficio, un salone, un bagno ed una stanza per il Movimento Giovanile dove mettemmo un calcio balilla, attrazione di molti giovani.
Tante assemblee altrettante votazioni furono fatte e da tutte uscivo sempre vittorioso; questo era il premio alla mia coerenza politica e all'amicizia con Andreotti.
Mai mi sono avvalso della maggioranza, che avevo, per governare il Partito, perché ho sempre, democraticamente, discusso tutti i problemi con le opposizioni, che erano guidate dall'amico, sempre stimato, Primo Antonini, Segretario Generale della C.I.S.L. provinciale di Viterbo, coadiuvato dal dottor Mario Ciotti e dall'amico Benvenuto Pasquali.
Nel periodo delle elezioni, per il Consiglio Comunale, la Sezione "L. Sturzo" sosteneva la candidatura dell'odontotecnico Santino Clementi e del professore Filelfo Paccosi, insegnante d'inglese, anche se le preferenze che si potevano votare erano quattro. Noi della sezione "L. Sturzo" aderivamo alla politica di "centro" che faceva capo a Giulio Andreotti.
Con il tempo le situazioni cambiarono, ma io rimasi sempre fedele ai miei principi di una politica di "centro" perché avevo una ripulsione alla politica di centro sinistra. Al pre-congresso sezionale, in vista dell'8° Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, che si svolse a Napoli, la mia sezione votò, a larga maggioranza, per una politica di "centro" ed io fui uno dei delegati al Congresso.
Prendemmo i dovuti contatti con l'onorevole Attilio Jozzelli, il quale mi chiese di fare "delegazione" con lui e che ci avrebbe atteso, il giorno dell'inizio del Congresso, a Napoli. Decidemmo di andare con la Fiat 1100, di Pellegrino (Rino) Fallea.
Non vorrei sbagliare, ma a me pare che nella macchina eravamo sei persone, però ne ricordo solo quattro. Nel chiedere scusa ai due, elenco gli altri, in ordine alfabetico: Santino Clementi, Pellegrino Fallea, Bruno Matteacci e Silvano Pierangeli.
Partimmo all'alba, a causa di una foratura della gomma anteriore dell'auto facemmo la prima tappa all'inizio della "fettuccia di Terracina".
Ci fermammo, dopo aver cambiato la gomma, facemmo colazione e, senza ruota di scorta, riprendemmo il nostro andare. Fatti pochi chilometri bucammo nuovamente.
A questo punto avevamo due gomme bucate, dovemmo fermarci.
Con l'ausilio di un automobilista, che andava verso Roma, uno di noi portò la ruota a riparare; intanto, poiché un'autovettura rallentò nel punto in cui eravamo fermi, chiedemmo se poteva prendere l'altra ruota bucata e portarla al successivo distributore, in direzione Napoli; la risposta fu affermativa.
Nell'attesa che ritornasse colui che era andato verso Roma, ci mettemmo a giocare a "batti muro". Dopo un poco di tempo avemmo la prima gomma perché giunse il nostro amico, che era andato verso Roma. Ci mettemmo in cammino e giungemmo così al distributore dove avevano, per nostro conto, lasciato la seconda gomma bucata. Sembrava che tutto fosse finito, ci mettemmo in viaggio dandoci il cambio alla guida.
Premetto che, fino a qualche giorno prima, avevo dato lezioni di guida, a Santino Clementi, con risultati poco brillanti; per un fatto accaduto in via del Gallo, quando un pomeriggio rientrando, per poco faceva una strage di donne che stavano, sedute fuori dell'uscio, a prendere il fresco.
Dopo vari cambi, Santino chiese di poter guidare; nessuno obiettò, ma nessuno parlò più, c'era una tale tensione che Santino, comprendendo lo stato d'animo dei presenti, rinunciò, dopo aver percorso pochi chilometri. Tutti demmo un gran sospiro di sollievo. Ad un certo punto ci dovemmo fermare per cambiare l'olio del motore allo scopo di non fondere il motore stesso.
Finalmente giungemmo a Napoli dove, in prossimità del teatro San Carlo, trovammo Vincenzo Bologna, Onio della Porta, Gastone Filippi e Attilio Jozzelli con i quali completammo la delegazione di Viterbo. Si capì subito che il Congresso sarebbe terminato con l'apertura a sinistra con il P.S.I..
L'orientamento della nuova politica era già stato deciso da Aldo Moro e Amintore Fanfani. Facemmo la nostra brava figura con la partecipazione a qualche incontro di "corrente", pranzammo, votammo e, alcuni di noi comprammo liquori e sigarette. Ricordo che colui che ci propose l'acquisto di liquori ci fece entrare in un salone dove erano centinaia di bottiglie, di vario genere, stappò alcune bottiglie, di diversa qualità, ce le fece assaggiare, le gustammo e ognuno ne acquistò una certa quantità.
Analoga procedura fu seguita per l'acquisto di sigarette; aprirono dei pacchetti di Marlboro, ne accendemmo qualcuna, la gustammo, tutto era perfetto.
Terminato il Congresso ci mettemmo in marcia per fare ritorno a Viterbo.
Nei pressi di Terracina dovemmo fermarci in un distributore perché non eravamo in grado di andare avanti perché la batteria era totalmente scarica e il dinamo non la caricava. Riuscimmo a trovare un elettrauto che, molto "caramente", perché si fece ben pagare l'avvolgibile del magnete, ci permise di giungere a Roma, dove trovammo difficoltà a riprendere la strada Cassia perché, più giravamo e più ci trovavamo nello stesso punto. Grazie a Dio stanchi, ma forti di una nuova esperienza giungemmo, contenti a casa, tra l'affetto di coloro che ci attendevano.
L'indomani il commendator Vincenzo Bologna pensò di far gustare, alla famiglia, le specialità acquistate a Napoli; fece aprire una bottiglia, ma con sommo stupore si accorse che la bottiglia non conteneva il liquore indicato sulla targhetta; stappò altre bottiglie, ma purtroppo dovette costatare che il contenuto era solo acqua putrida.
Vincenzo chiamò al telefono l'avvocato Gastone Filippi, al quale chiese di vedere cosa contenessero le bottiglie, che aveva acquistato a Napoli; la risposta fu: "sembra urina di cavallo, questa è la sensazione che ho sentendo il cattivo odore che la bottiglia emana".
In poco tempo la notizia, della fregatura presa a Napoli, fece il giro di tutte le abitazioni di coloro che erano stati al congresso. La fregatura fu presa pure da chi, come me, acquistò le sigarette; nei pacchetti trovammo la segatura.
Certo Napoli ci lasciò con la bocca amara, sia per la fregatura che ci dettero con la vendita di "urina di cavallo" e "segatura" al posto dei liquori e delle sigarette, che con il risultato politico dell'apertura a sinistra; che per alcuni di noi fu veramente una "doppia fregatura".
In quel periodo, nella mia famiglia di "svolta" ce ne fu un'altra molto importante!
Giunse il momento tanto atteso da tutti; la cessazione della attività lavorativa della mamma mediante la vendita, al signor Giovanni Serio, della licenza per il commercio di frutta e verdura e di quanto esisteva nel negozio in via San Bonaventura n.8.
Fu una svolta, della vita di mamma, gradita a tutti; molto importante per la sua salute e tanto voluta pure da mio padre che, da tempo, si augurava che ciò avvenisse.
Per i primi tempi la mamma definì, il suo meritato riposo, "ozio" sebbene tutti noi le
dicevamo che era ora che si gustasse, con il babbo, la pensione.
Con il trascorrere del tempo anche mia madre incominciò ad assaporare il piacere di stare qualche minuto in più a letto. Per il lavoro che svolgeva mamma e le usanze locali, per ben gestire l'attività commerciale, era necessario andare ai Magazzini generali al mattino, molto presto.
Non ho rimorsi di coscienza, fino a che mamma ha gestito tale attività commerciale, le sono stato sempre molto vicino andando a fare gli acquisti con lei, oppure aprendo il negozio, verso le prime ore del mattino, con lo scopo di poter soddisfare le esigenze delle massaie che si recavano a fare la spesa di buonora.
Devo riconoscere il fatto che se mamma lavorava, ciò serviva soprattutto per soddisfare le mie esigenze; infatti, appena mi sono reso autosufficiente, giustamente, mamma ha cessato di lavorare, anche se la gestione di una famiglia è sicuramente un lavoro da non minimizzare.
Mamma normalmente, dopo aver pranzato, faceva un riposino a letto, con il babbo e successivamente, insieme, andavano a bottega.
Mi sembra ancora di vederli sulla Lambretta che il babbo guidava magistralmente, in attesa di acquistare un'autovettura che potesse soddisfare le sue ambizioni.
Data la mia posizione di lavoro e di politica avevo modo di ottenere, da amici, permessi di accesso nelle riserve di caccia, cosa molto ambita e gradita da mio padre.
Fino a questo momento ho raccontato episodi brutti, meno brutti, belli e meno belli; certo è che tutto quello che potevo fare e dare al babbo e alla mamma, era per me una grande soddisfazione; sarebbe come dire che la loro gioia era per me vita.
La prima volta che portai il babbo in una riserva di caccia, avvenne sulla tenuta agricola dell'amico dottor Silvio Ascenzi, gestita dall'altrettanto amico geometra Silvio Lazzari.
Potevamo uccidere sei fagiani; eravamo accompagnati dal guardia caccia Fiocchetti che ci portò in una zona dove era molta selvaggina. Il babbo mi disse: "Questo giorno non lo dimenticherò mai, grazie a te ho provato una gioia immensa, ringrazio il Signore che ci accompagna e sii tu a ringraziare chi di dovere".
Mentre il babbo mi diceva queste parole gli brillavano gli occhi, mentre il signor Fiocchetti, che sentì il nostro discorso, si commosse, fece un colpo di tosse e si accese un sigaro. Dopo poco tempo avevamo nel tascapane tre fagiani, due femmine ed un maschio, di bellissimi colori.
Facemmo colazione a base di sfilatino con carne alla pizzaiola che ci aveva preparato mamma, poi riprendemmo la battuta di caccia avvicinandoci verso il casale della Vaccareccia, luogo di partenza, dove avevamo lasciato la Lambretta.
Lungo il tratto di strada avemmo modo di prendere altri tre fagiani, tutti maschi. L'anno successivo ebbi il permesso di accedere nella caccia riserva, lungo la Strada Tuscanese, di proprietà dei signori Balestra di San Marino.
In quell'occasione avevamo portato Roky che era un cane segugio nero con bordature marroni. Era per noi come un componente la famiglia, gli volevamo tanto bene.
Quel giorno, nella riserva, io entrai in un carraccio con Roky allo scopo di stanare i fagiani, mentre il babbo aspettava sulla sommità del carraccio, pronto a fare fuoco sul volatile.
A battuta terminata, io, fanatico, misi i sei fagiani sul cofano della macchina e facemmo ritorno a casa, dopo aver fatto tappa al bar che normalmente frequentava il babbo, al mattino, prima di andare al lavoro.
Anch'io, caro babbo, ogni tanto ripenso a quei bei momenti, non per la selvaggina che prendevate, ma per la gioia che provavo nello stare in vostra compagnia, in particolare, quando eravamo in viaggio sulla Lambretta e voi mi stringevate per la vita, non tanto per sorreggervi, ma quanto per trasmettermi il vostro affetto, il vostro amore, il vostro calore. Babbo, mi mancate da morire...!
Il 23 ottobre 1965 i miei genitori acquistarono, dal signor Ugo Agostini, l'autovettura Volkswagen tipo 11 mod. 113, 1200 cc. 6 volt, meglio conosciuta con il nome di "Maggiolino", di colore verde bottiglia, targata VT 39830, immatricolata nel 1964.
Il babbo era orgoglioso della sua macchina, non aveva più il problema pioggia a causa della cappottina, come lo ebbe con il Topolino.
Essendo l'auto a 6 volt aveva necessità di una batteria con lo stesso voltaggio; per renderla più pronta nel momento della accensione gli procurai una batteria, da trattore, che aveva una potenza superiore a quelle di normale uso.
Il babbo accantonò, per un poco di tempo, la Lambretta perché andava a lavorare con l'auto.
A proposito voglio ricordare una giornata trascorsa con mio zio Emilio Ceccarelli, fratello di mamma, più grande di me di nove anni.
Insieme giravamo la provincia in Lambretta; ricordo che un giorno, che dovevo andare, per ragioni di partito, verso Civita Castellana decidemmo di mangiare senza andare al ristorante Acquistammo a Vitorchiano un chilo di ottima porchetta e la mangiammo, senza pane, lungo il tratto di strada, stando appoggiati su una pietra miliare.
Nel periodo pasquale, zio Emilio trascorse a Viterbo, a casa nostra, un po' di giorni insieme alla nonna Assunta. In quel periodo in rappresentanza dell'onorevole Jozzelli, dovetti andare con lo zio in giro per la Provincia per partecipare a qualche processione.
Ricordo quella di Castel Sant'Elia, dove sindaco, era una gentile signora la quale ci accolse con tanta simpatia e volle che ella procedesse in processione stando tra mio zio e me. Sempre in quel periodo partecipammo ad altre processioni, ed ad incontri con segretari di Sezione di vari paesi. Quando nonna e zio venivano a Viterbo era veramente una festa, come del resto lo era quando io, o altri componenti la famiglia, andavano a Gubbio, ospiti di nonna e di zio Emilio. Purtroppo tutto ha fine, ma con zio Emilio, la parola fine non l'abbiamo mai conosciuta, perché l'affetto è rimasto immutato ed il desiderio di stare insieme è sempre vivo.
Questo magnifico rapporto era esteso pure allo zio Ubaldo che, a Gubbio, svolgeva una attività commerciale di vendita di frutta, unitamente a zio Emilio in piazza dei Quaranta Martiri, sotto "le logge". Spesso detta attività la svolgevano con un camion, girando la provincia di Perugia vendendo, in forma ambulante, i loro prodotti.
Ciò non deve far pensare che con gli altri zii ci fosse stato un affetto minore, questo no, però era pur vero che c'era un rapporto più distaccato; anche se l'affetto era tanto, ambo le parti.
A proposito di mio padre, ho omesso di parlare della sua eleganza nel vestire e del suo essere ordinato. Non capitava che il babbo, quando andava a passeggio, si mettesse seduto senza controllare la pulizia della panchina, spesso, prima di sedersi, usava un fazzoletto che stendeva sul sedile.
La mamma ci teneva moltissimo a che il babbo fosse sempre elegante, gli preparava, giornalmente, sulla poltroncina della camera, la camicia bianca da indossare con la cravatta ed il vestito intero. I miei genitori non concepivano che si indossasse un abito "spezzato", cioè la giacca di un colore e i pantaloni di un altro, dicevano che era un vestirsi "rimediato".
Il babbo, quando stava nel suo laboratorio indossava, sopra il suo elegante vestito, un grembiule nero allo scopo di presentarsi ai clienti un artigiano assestato e, a tale proposito, lui si radeva tutte le mattine, prima con il classico storico rasoio, usato dai vecchi barbieri, poi con il rasoio a lametta ed infine, ebbi il piacere di regalargli un rasoio elettrico "Remington".
A proposito del rasoio da barbiere ricordo un bruttissimo incidente accaduto al babbo, nel 1945, come di consueto il babbo si radeva tutte le mattine, alla sua destra, sul lavabo con la specchiera, stendeva un foglio di carta sul quale strisciava, poi, il rasoio allo scopo di togliere, dallo stesso, il sapone; nel fare questa operazione, forse troppo sicuro di sé nel maneggiare il rasoio, si tagliò sotto la gola.
Fu un momento veramente tremendo, il babbo aveva un taglio che mi inorridisce oggi, al solo pensiero; fu portato in ospedale e ci volle a far capire che fu un incidente e non un gesto volontario. Roba da pazzi.
Da quel giorno il rasoio divenne un solo ricordo e fu sostituito dalla famosa lametta di sicurezza la "Tre teste".
Con il tempo, in Comune, acquistavo sempre più prestigio; un poco per il mio modo di fare, cordiale ed affabile con tutti, ed un poco perché mi mettevo, sempre, al servizio del cittadino per aiutarlo.
Dicevo che con il mio comportamento si faceva l'interesse del Comune e, nel contempo, quello del cittadino, che era il più debole e a volte pure bistrattato perché disorientato e poco educato al senso civico tributario.
In ogni contribuente, vedevo un cittadino meritevole della maggior comprensione a cui doveva andare la cortesia del personale comunale, che percepiva lo stipendio, grazie anche, alle tasse che il contribuente pagava.
Era l'epoca in cui si applicava l'Imposta di famiglia, che derivava dal famoso "focatico", cioè era un'imposta che si applicava alla famiglia, intesa come convivenza intorno al focolare, sulla base del reddito, derivante dall'unione dei vari cespiti individuali dei vari componenti il nucleo familiare.
Questo era il tributo che dava il maggior gettito, c'era poi l'imposta sul "valore locativo" che si applicava a quei cittadini che tenevano a propria disposizione un appartamento, mobiliato, nel comune e che lo occupavano per un periodo inferiore ai sei mesi, perché residenti altrove.
Poi c'erano le "tasse", sì perché le prime erano "imposte" e cioè la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani (TARSU), che tuttora si applica; la tassa sulle insegne; la tassa sui biliardi; la tassa sulle macchine per il caffè; la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); l'imposta sui cani; la vendita del contrassegno metallico per cani che erano classificati in quattro categorie e cioè 1ª, 2ª, 3ª, esente; i passi carrabili; l'imposta di patente; i diritti sui pesi e misure; l'imposta di licenza.
Avverso l'applicazione dei tributi, soggetti ad accertamenti da parte dell'ufficio, al contribuente, era possibile "ricorrere" alla Commissione Comunale di 1ª Istanza, che era composta da quaranta componenti di cui: dieci designati dalla Prefettura e trenta designati dal Consiglio Comunale. Detta commissione si suddivideva poi in sottocommissioni che eleggevano ognuna il proprio presidente. Il maggior numero dei ricorsi che arrivavano erano avverso l'accertamento della imposta di famiglia.
Era un lavoro che a me piaceva moltissimo e che, grazie alla mia intraprendenza, mi faceva pure guadagnare benino perché potevo fare anche gli straordinari ed ottenere qualche "premio in deroga".
La data del 27 giugno 1965 intendo citarla, ricordarla e mai dimenticarla perché, quel giorno, Armando Marini, nato a Viterbo il 3 giugno 1940, fu ordinato sacerdote e, il giorno successivo, nella Chiesa di Sant'Angelo, celebrò la Prima Messa.
Io, a questa data, non avevo il piacere di conoscerlo perché lo conobbi, di sfuggita, successivamente per il suo modo di fare, che ebbe una tale eco, che entrò subito nel cuore dei Viterbesi.
Nel 1966, qualche giorno prima della Santa Pasqua, come ogni buon cristiano, anch'io intesi giungerci "libero" da ogni peccato e, la soluzione per essere "liberi" era, è e sempre sarà, "confessarsi".
In un attimo di debolezza umana, pensai di andare, a Vetralla, nella chiesa di Sant'Angelino. Si vede che avevo la coscienza sporca e puntavo di andare dove non ero conosciuto, ignorando che Lui, il nostro Salvatore, è ovunque e che già sapeva quello che avrei dovuto confessare; comunque decisi di partire.
Mentre, con la mia auto, attraversavo piazza del Plebiscito in direzione di via Cavour vidi, sul sacrato della chiesa di Sant'Angelo, don Armando che stava a braccia conserte scrutando, in lontananza, la piazza. Fu tutt'uno: visto, fatto un breve esame di coscienza, decisi che il mio confessore sarebbe stato quel sacerdote che aveva già fatto breccia nel mio cuore.
Parcheggiai l'auto e mi diressi verso di lui; gli chiesi se poteva confessarmi al che lui mi appoggiò una mano sulla spalla e con un sorriso pieno d'amore entrammo in chiesa, facemmo la dovuta genuflessione ed entrammo in sagrestia.
Ricordo che durante la confessione piansi, forse per la gioia o la serenità che don Marini mi infondeva; certo è che, alle mie lacrime, fecero seguito quelle di don Armando che suggellammo con un abbraccio.
Feci una confessione che mi dette un senso di libertà, di pace e di vera serenità; mi sentii leggero, molto leggero.
Grazie caro "fratello", era così che ci siamo poi chiamati, per oltre trent'anni, grazie per avermi consentito di starti vicino; grazie per quanto hai fatto per la mia famiglia, grazie per quanto mi hai insegnato, grazie per avermi sopportato.
Ora ti chiedo di volgere lo sguardo sui miei figli e sui miei nipoti e, se puoi, trovami e riservami un posticino vicino a te. Ciao ti voglio bene!
Chiedo scusa per questa divagazione.
Poiché il 23 gennaio 1966 era scaduta la Commissione Amministrativa del Conservatorio della Presentazione, della quale ero deputato; il Consiglio Comunale di Viterbo prese in esame la questione, procedendo al rinnovo della stessa.
Nel mese di maggio il Consiglio Comunale nominò, per primo, il presidente nella persona dell'amico cavaliere Goffredo Marini, che riportò 17 voti contro i 12 di Crescia; poi passò all'elezione dei deputati. Votarono 31 consiglieri e riportarono voti: Bruno Matteacci 17, Raffaele Beretta 14, Giuseppe Boccolini 17, Angelo Bracaloni 15, Luigi Crescia 12.
Il sindaco proclamò eletti Bruno Matteacci e Giuseppe Boccolini.
A questo punto il consigliere Achille Poleggi, del P.S.I.U.P., dichiarò: "Che l'elezione di Bruno Matteacci non aveva la validità giuridica perché il Matteacci era dipendente comunale e quindi incompatibile".
Alle parole del consigliere Poleggi si associò subito il capo gruppo del P.C.I. Luigi Petroselli che chiese al capo gruppo della D.C., Giuseppe Benigni, il suo parere in merito.
Benigni rispose che, non avendo approfondito la questione, non era in grado di esprimere il proprio parere.
Petroselli replicò dicendo che la risposta di Benigni: "sta a dire che è evidente la incompatibilità".
Fece seguito l'intervento del sindaco Salvatore Arena che disse: "non si può affermare che è evidente l'incompatibilità, tuttavia se c'è incompatibilità questa si vedrà in seguito". Altri consiglieri intervennero sull'argomento.
Consapevole della esistente incompatibilità, perché il Comune erogava dei contributi al Conservatorio, avevo la possibilità di optare per l'impiego o per l'incarico.
Ovviamente, nei termini di legge, entro pochi giorni dovevo prendere una decisione;
intanto la stampa parlava di me ed era questo che volevo.
Nei termini, scrissi una lettera al sindaco ringraziando il Consiglio per la mia elezione e optai, logicamente, per l'impiego.
In previsione del matrimonio, mi misi alla ricerca di un appartamento che trovai in via Pieve di Cadore n.8, 2° piano, interno 3, di proprietà del Conservatorio della Presentazione. Il predetto appartamento veniva messo a disposizione di colui che avrebbe fatto maggiori lavori di ripristino dello stesso perché c'erano altre richieste.
Dopo averlo veduto proposi di effettuare, a mie spese, i seguenti lavori: sostituzione pavimenti: nella cucina, ingresso e nel bagno, carta parati, maiolicatura cucina e bagno, maniglie, stucchi, tinteggiatura porte e finestre, servizi sanitari.
L'appartamento si componeva: di ingresso, corridoio di circa sedici metri, studio, tinello-soggiorno, cucina con veranda, sala, salotto, camera, bagno, scantinato e garage; al prezzo di lire 24.000 al mese, di cui 17.000 per l'appartamento e la differenza per il garage, che ebbi in locazione successivamente.
Il 2 ottobre 1966, nella Cappella del Collegio Ragonesi in viale IV Novembre, mi sono sposato con Antonietta Egidi, i testimoni di nozze furono: l'onorevole Attilio Jozzelli, il sindaco di Viterbo, professore. Salvatore Arena e la signora Evita, l'assessore, insegnante, Nazzareno Capoccioni e l'assessore, odontotecnico, Santino Clementi.
Facemmo il viaggio di nozze con l'Alfa Romeo Giulietta seguendo questo itinerario: Roma, Grosseto, La Spezia, Chieri-Torino, Modane, Lyone, Parigi, Andorra, Barcellona, Marsiglia, Montecarlo, Cannes, Cap d'Antibes, San Remo, Firenze, Gubbio, Viterbo, andando ad abitare nel predetto appartamento, che era diventato, veramente bello.
In quel periodo fui nominato membro del Comitato Provinciale Assistenza Ospedaliera (C.P.A.O.), organo di controllo degli Ospedali della Provincia di Viterbo.
Essendo ragioniere ebbi l'onere e l'onore di relazionare tutte le pratiche che riguardavano: spese (stipendi, acquisto macchinari, medicinali) ed entrate (rette, entrate provenienti dalle mutue, proventi derivanti dall'azienda agricola).
Questo fu un incarico che mi dette molte soddisfazioni; altri membri del Comitato erano: il Medico provinciale dottor Domenico Corda, quale presidente, il Vice Prefetto dottor Salvatore Santo, il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro dottor Sergio Coletta, il dottor Francesco Izzi ed altri due componenti, dei quali non ricordo il nome, segretario era il dottor Ricci.
Altro incarico lo ebbi insieme all'amico Berti; fui nominato, per vari esercizi finanziari, revisore dei conti dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo; incarico piacevole che durò un certo tempo, ma non fu tanto gradito agli Amministratori provinciali perché Berti ed io eravamo molto scrupolosi perché, se vedevamo un qualcosa che non andava troppo bene, o che non era molto chiaro, facevamo delle "osservazioni" dirette alla Presidenza, per avere delle delucidazioni in merito.
A seguito del mancato servilismo, da parte nostra, e della scrupolosità con cui lavoravamo, le alte sfere della Provincia, entrarono nell'ottica di nominare revisori dei conti i Consiglieri Provinciali, cosa che a me parve anomala perché c'era un accavallamento di poteri, tra il controllore ed il controllato.
Nel mondo della politica continuavo ad avere soddisfazioni a non finire, nella Sezione fui riconfermato segretario politico e nelle elezioni comunali riportai un netto successo nel quartiere Pilastro dove battemmo i comunisti rimanendo il primo partito del 1° Collegio elettorale.
Tutte le mattine, prima di andare in ufficio, passavo in via della Pace, dove al numero 81 era il laboratorio di calzolaio di mio padre. Il motivo per il quale andavo da lui era per me vitale, avere il suo saluto ed il suo bacio era per me come una droga, mi dava la carica per tutto il giorno.
Mi sembra di vederlo; arrivavo e appena mi affacciavo sulla porta dicevo: "ciao ba'"; lui mi accoglieva con un sorriso smagliante ed un abbraccio, che faceva da cornice al bacio che ci scambiavamo.
Quando andavo via, a volte, gli chiedevo una sigaretta, tanto per dargli l'impressione che io non acquistavo le sigarette. Poi, mentre scendevo lungo via dell'Orologio Vecchio, mi voltavo per salutarlo e lui aspettava che io oltrepassassi il punto in cui non ci vedevamo più; lì era l'ultimo saluto con un gesto della mano.
Il babbo lo rivedevo da lontano, quando alle ore 12 andava, con il suo mezzo di trasporto, a casa per il pranzo. Passava lungo via Cavour ed io, sapendo del suo passaggio, mi affacciavo alla finestra del mio ufficio e lo salutavo con un gesto del braccio cosa che lui, senza distogliersi dalla guida, con la mano sinistra mi salutava. Dopo pochi minuti telefonavo a casa per sapere se era arrivato e, con l'occasione,
parlavo, per l'ennesima volta, con mia madre. C'è stato un periodo che l'Ufficio Tributi si trasferì in via della Verità, a pochi metri del laboratorio del babbo, quindi i nostri incontri erano più frequenti.
Verso la fine del mese di gennaio del 1967 sapemmo che stava per arrivare il mio grande amore, mia figlia Patrizia; da quel giorno ho vissuto momenti di attesa veramente felici. Tutto procedeva per il verso giusto, non mi sembrava vero che diventassi babbo.
Nel giugno del 1967, a Gubbio, si ammalò la nonna Assunta e la mamma, giustamente, manifestò il desiderio di andarla a trovare e, stante la grave malattia, trascorrere qualche giorno insieme. Mamma partì con Mauro e suo fratello Carlo, che davano una certa sicurezza alla sua permanenza a Gubbio. Mamma scrisse una lettera, che giunse al babbo il 4 luglio, nella quale veniva rappresentata: la salute della nonna, di mamma, Carlo e Mauro e ciò che, avrebbe voluto fare a Gubbio.
Il babbo, lo stesso giorno, rispose con la seguente lettera; che custodisco molto gelosamente tra i miei ricordi: "Cara moglie, ho ricevuto la tua molto gradita, sono le ore 10 e appena letta rispondo.
Mi dispiace sapere della cattiva nottata che hai passato; mi auguro che tutte le altre tu le possa passare bene. Grazie a te Mauro che la segui.
Mi dici di andare alla Mocaiana; io ti rispondo dicendo "no" perché tu hai avuto l'insolazione e quel lungo tratto di strada scoperta, senza alberi, con questo forte sole potrebbe nuocerti. La macchina è stata messa a posto e non ho pagato nulla; sono andato a provarla, con Bruno e il meccanico lungo la strada della montagna.
Mentre sto scrivendo è arrivato Bruno che mi ha portato la pizza, ma io non la mangio, se non un assaggino, perché mi potrebbe nuocere.
Domenica da Bruno siamo stati benissimo, ci ha fatto un buon pranzo, ha fatto tutto lei, ha imparato bene. Io all'infuori delle scale faccio sempre i soliti passi; ho da lavorare e mi sento molto bene, il tutto non mi affatica.
La Bruna mi ha accoppiato i due lettini dove ci dormo meglio. Per me tutti e due nutrono i massimi riguardi, cosa che io apprezzo molto, pure Vinicio non è da meno.
Ora senza fare punto che di Bruno ci sono queste righe e di Bruna no, perché lei non è presente, io la imposto subito. Per quanto rimanere, fai tu come vuoi, sappi comunque che a Bruno i denti non gli fanno male. Tutto bene. Saluti a baci da tutti e a tutti voi, specie a Carlo, Tuo Giuseppe Matteacci".
"Cara mamma, mi trovo di passaggio dal babbo, colgo l'occasione per dire che tutti, dico tutti e cinque, stiamo bene; cosa che mi auguro di voi, figli e parenti tutti. Oggi vi scriverò da casa; baci a voi, figli, nonna e zii tutti vostro figlio Bruno".
Tutto andò per il verso migliore; la nonna Assunta si guarì, mamma con i nipoti ritornò a Viterbo, mentre lo stato di gravidanza di mia moglie andava sempre per il meglio.
Stavo per diventare babbo. Solo chi l'ha provato può capire e dare ragione per lo stato in cui ci si trova in queste circostanze.
E' magnifico, anche se spesso ci si sente soli davanti alla grandezza e l'importanza di una nascita.
L'attesa è straziante, il pensiero di quello che sta per arrivare è immenso, la fiducia e l'amore verso Dio lo riversi tutto per la creatura che deve arrivare; è a lui che ti rivolgi, è a lui che rimetti il tutto.
L'attesa della nascita della mia creatura era sentita moltissimo; mi scoppiava la testa; il pensiero era sempre rivolto al futuro; a quel grande evento e la domanda che mi proponevo era sempre la stessa: "spero che sia una bella femminuccia", ma era solo un sogno, perché non c'erano, ancora, i mezzi per avere notizie, in anticipo, come lo è oggi.
A proposito del desiderio di avere una bambina cosa, che da sempre, mi ha fatto sognare di essere padre, ricordo che mia sorella Bruna, trovandosi a Gubbio con Vinicio, il 26 settembre 1967, ci inviò una cartolina illustrata con l'immagine di una bellissima bambina, con un fiocchetto rosso in testa, alla quale stavano facendo il bagnetto dentro ad una vasca di plastica.
Quella cartolina, che ancora custodisco gelosamente, fu un presagio ed un augurio, di mia sorella e mio cognato, per l'arrivo della mia amata figlia per la quale da tempo avevamo già deciso di chiamarla Patrizia.
Comunque, alla fine dei conti, dicevo a me stesso: "importante che nasca bene, sana o sano, importante che stia bene la madre e la creatura; sarò comunque un padre felice".
Il 10 ottobre 1967, alle ore 15,05 venne al mondo, la bambina più bella del mondo, mia figlia Patrizia, di chilogrammi 3,300 che da tempo occupava, felicemente, i miei sogni i miei pensieri e i miei programmi.
Ricordo che, quando la presi in braccio per la prima volta, la strinsi a me; piangendo di gioia; mi misi a fare su e giù per il corridoio dell'ospedale, come un pazzo, non riuscivo a contenermi, ad alta voce dicevo di essere padre di una bellissima bambina.
Grazie Signore, ancora grazie, non finirò mai di dirti grazie!
Della nascita del mio "grande amore" ne detti notizia su tutti i giornali della città; provvidi, subito, alla registrazione al Comune di Viterbo dove fu iscritta nel registro di Stato Civile dell'anno 1967 al numero 1059 Parte 1ª Serie A.
In data 13 ottobre1067, a firma del professore Francesco Pallucca, Ufficiale dello Stato Civile, mi fu rilasciato, con il numero di protocollo 13846, il primo certificato, a nome di Patrizia Matteacci, che custodisco gelosamente.
Patrizia fu battezzata, il 15 ottobre 1967 nella cappella dell'ospedale, da Padre Scipioni; come madrina ebbe l'ostetrica Maria Arriga e come padrino il dottor Germano Bianchi, ginecologo dell'ospedale; l'atto di battesimo fu registrato nella Chiesa di Santa Maria della Verità, la nostra parrocchia, nel 1967.
La vita di coppia è bella, ma l'amore per la propria figlia, non ha nessun paragone che regga. Il bel visetto di Patrizia era sempre presente nel mio cuore e, davanti ai miei occhi, avevo, ho e mi auguro di avere, sempre, la sua immagine, bella e sorridente.
Non ci sono parole per dire quanta le si vuole bene.
La fotografai, per la prima volta, dopo diciassette giorni di vita; era bella, è stata sempre bella, perché è nata bella; alla terza settimana era cresciuta di 500 grammi; cresceva bene, ad un anno pesava Kg.10,600 ed era alta cm. 78
Patrizia la misi sotto la protezione di Santa Rosa presso la quale la segnai come "Bocciolo" di Santa Rosa.
Il 25 aprile 1968 le spuntò il primo dentino, mentre i primi passi li ha effettuati il 10 settembre 1968 e il suo primo "scarabocchio" lo ha fatto il 3 novembre 1968.
La prima volta che le facemmo una torta, per festeggiare la ricorrenza dell'ottavo mese dalla nascita, fu il 10 giugno 1968; Patrizia, come si può vedere dal filmetto che le faci, dette una ditata al dolce, prendendone una piccola quantità, che se lo portò in bocca.
In quella occasione, con una goccia di spumante, bagnammo le labbra della nostra amata figlia che, chiudendo gli occhi, dette una "stremolita".
Il tempo trascorreva sereno; l'unico scopo della vita era Patrizia, sempre più bella e amata da tutti.
Ricordo, piacevolmente, la felicità di mia sorella Bruna, la quale letteralmente impazziva per questo gioiello che il Signore ci aveva dato.
Non da meno fu l'affetto dei nonni, delle nonne e delle zie tutte.
Patrizia ebbe un piccolo problema di alimentazione con il latte artificiale "Prodieton" e "Miralat", ma la bravura del pediatra, dottor Ercole Nisini, fu tale e tanta che tutto si risolse per il senso giusto; Patrizia cresceva sana, robusta, bella ed amorevole verso i genitori e parenti.
Presto capii che aveva una predisposizione verso il babbo, non dico che volesse più bene a me che alla madre, ma forse, per il fatto che io uscivo la mattina per andare in ufficio e ritornavo all'ora di pranzo, le faceva un certo effetto vedere il babbo, non sempre vicino, come le poteva stare la madre.
Ai primi passi, fatti in maniera autonoma nel mese di ottobre, ricordo, che mi veniva incontro, nel lunghissimo corridoio, con le braccine aperte e, quando fu in grado di dire le prime parole, mi diceva: "gasi gasi do baso io" (quasi, quasi, ti do un bacio io). Quando parlava, al telefono, con mio padre gli diceva: "co' sto sole e co' sto buio non posso veni giù" (con questo sole e con questo buio non posso venire giù).
Ero veramente felice, di una felicità indescrivibile, avevo desiderato questa figlia per oltre nove anni ed oggi, 3 novembre 2005, alle ore 21,02, momento in cui sto scrivendo, posso confermare che l'amore per mia figlia non ha mai avuto limiti anzi, con il suo modo di fare è stata per me, un gran dono di Dio. Lei è in me, come io so di essere in lei. Patrizia cocca del babbo, ti ho amato e ti amo da morire!
Ogni ricorrenza, del compleanno o dell'onomastico, è stata sempre festeggiata con auguri, attraverso la stampa locale, e l'affetto di noi tutti e delle sue amiche.
Dal 10 giugno 1968, prima festa in onore di Patrizia ad oggi, ad ogni ricorrenza, di qualsiasi componente della famiglia, ho il tappo della bottiglia di spumante che si è stappata e si è brindato per l'occasione, con l'indicazione del nome della persona festeggiata e la data.
Era tutto bello, Patrizia era il più bel dono che Dio poteva farci; cresceva bene, bella e ubbidiente. Un suo sorriso era tutto per me. Quando si andava a spasso mi piaceva prenderla in braccio; lei appoggiava il suo visetto alla mia guancia dandomi una sensazione bellissima; la sentivo sempre più mia.
Ricordo quando andavamo a Bolsena, al campeggio "Mario", mi sembra di vederla dentro il canottino azzurro, con il costume e la vestaglia di spugna bianca, con la lettera "P" nella tasca, che le fece mia sorella Bruna.
La mia "cocca", quando la riprendevo con la cinepresa, faceva la vanitosa, in poche parole "posava" ed io, di ciò ero felice.
Per rivivere quei momenti, ogni tanto, vedo qualche pellicola, non nascondo che mi commuovo e sono felicissimo di avere fatto tante riprese, tali da consentire, oggi, una visione di quello che è stato.
Non c'è da ricercare un giorno bello trascorso con mia figlia; tutti i giorni sono stati belli, da non dimenticare.
Posso ben dire che la casa era piena del suo amore e Patrizia non ce lo ha fatto mai mancare.
Se chiudo gli occhi, mi sembra di vederla rotolare sul prato verde dell'EUR in quella famosa domenica che andammo all'udienza del Santo Padre, in piazza San Pietro.
I giorni passavano veloci ed altrettanto veloci erano i mesi; Patrizia cresceva sempre più bella.
Tutto procedeva per il meglio, in me era ritornato l'amore per il gioco delle bocce. Verso la fine del mese di ottobre facemmo un torneo di bocce fra dipendenti comunali che io ho vinto, sia giocando a coppia che in forma singola.
Giungemmo all'estate del 1970; in quell'epoca ero Deputato del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Assistenza all'Infanzia per la Provincia di Viterbo, precedentemente chiamato "Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima", intestazione che cambiammo subito.
La deputazione era così composta: presidente il cavaliere ufficiale Ferruccio Gatta, con il quale ero legato d'amicizia politica ed amministrativa; consiglieri: Mario Amorosi, il dottor Ercole Laurenti, il geometra Giovanni Marinozzi, il ragioniere Bruno Matteacci, il dottor Antonio Ruffi, il professore Francesco Santella. Nella riunione del 10 luglio 1970, giorno del mio compleanno, ebbi una accesa discussione, con la Deputazione, circa la indennità di funzionamento reparto immaturi, che io proposi di non erogare più perché il reparto era da tempo inoperoso e quindi, a mio avviso, non era giusto corrispondere una indennità per un servizio non fatto. Fui messo in minoranza, l'indennità fu deliberata, con il mio voto contrario.
Minacciai che avrei fatto ricorso, a chi di dovere, con separata denuncia al Prefetto, qualora, sebbene in ferie, non mi fosse comunicato che la delibera veniva ritirata e quindi non pubblicata.
Avevamo già deciso che le vacanze dell'anno le avremmo trascorse a Marina di Grosseto; avevo prenotato, a Grosseto, la camera nell'albergo Leon d 'oro, sito in via San Martino n. 46, dove nel 1966, facemmo la seconda tappa del viaggio di nozze.
Al mattino dell'11 luglio 1970, dopo aver fatto mangiare Patrizia, preso quanto necessario ed utile, a bordo della mia auto, partimmo per trascorrere un periodo di meritato riposo per tutti.
Il viaggio fu magnifico, ma in me rodeva la rabbia di quanto accaduto il giorno prima e soprattutto il fatto che, con Ferruccio, mi ero lasciato con un poco d'astio.
Giunti a Grosseto, prendemmo possesso della camera e sul tardi facemmo la prima esplorazione a Marina di Grosseto, dove siamo stati magnificamente per vari giorni.
Anche l'attesa decisione, relativa al ritiro della deliberazione di cui sopra, mi giunse a mezzo lettera, con un'annotazione, amichevole di Ferruccio, che gradii tanto.
Mentre scorrazzavamo da una spiaggia all'altra, direzione "Principina", venni a conoscenza che attendevamo l'arrivo di una creatura.
La gioia fu immensa, toccai il cielo con le dita, con mia moglie ci fu un abbraccio spontaneo, mentre tenevo tra le mani la medaglia di Giovanni XIII che, nell'apprendere la notizia, baciai con tanta devozione, felice di ridiventare padre.
Dopo qualche giorno, verso le ore 18,30, momento solito del rientro in albergo, mi accorsi che avevo perduto la chiave con la quale aprivo e mettevo in moto l'auto.
Vane furono tutte le ricerche, la sera si avvicinava ed io, molto preoccupato, trovai una chiavetta con la quale si aprono le scatolette di carne, riuscii ad aprire lo sportello dell'auto. Successivamente, con un poco d'inventiva, staccai i fili sotto il cruscotto riuscendo a mettere in moto l'auto.
Giungemmo in albergo, lasciai le donne ed andai a cercare un artigiano che mi facesse la chiave, senza ottenere il risultato sperato.
Mancava la copia della chiave quindi non fu possibile inventare una chiave; così mi disse l'artigiano grossetano che mi fece rimpiangere le capacità di Orfeo Mancone, abile artigiano di Viterbo.
Comunque non mi scoraggiai, alla sera mangiammo normalmente, Patrizia era sempre più affettuosa, mentre lei mangiava io già mi raffiguravo la felicità che avrei provato, fra nove mesi, con l'arrivo di una creatura che, logicamente, mi auguravo maschio al quale avevamo già scelto il nome di Giuseppe.
La nottata fu insonne, sapevo di aver perduto la chiave dell'auto, ma ero fiducioso.
Al mattino andammo sulla spiaggia e, con sommo stupore, vidi un signore che teneva una canna in mano con sull'estremità la chiave della mia auto.
Non ci sono parole per dire la gioia che provammo.
Ma la gioia durò poco; i giorni, quando si è in ferie, sembra che trascorrono più veloci del normale; eravamo giunti al giorno che saremmo dovuti rientrare a casa, quando ci accorgemmo che il carburatore della Giulietta perdeva benzina; tentammo vari espedienti, ma tutti furono dei semplici pagliativi.
Poiché il giorno successivo dovevamo partire, alla sera telefonai ai miei genitori, che pregai di venire a Grosseto, per farmi da scorta con la loro auto e ospitare, nella loro Volkswagen mia moglie e Patrizia, allo scopo di evitare eventuali pericoli.
Al mattino, di buon'ora, i miei genitori giunsero in albergo con Vinicio, Bruna, Mauro e Carlo, che vennero con la loro Simca.
Partimmo per Viterbo, lungo il viaggio tutto andò bene, in località "sughereta", che dista pochi chilometri da Viterbo, facemmo tappa dove mangiammo quanto mamma e Bruna avevano cucinato nella notte. In quell'occasione informammo i miei famigliari del futuro arrivo di una creatura in casa Matteacci.
Fu indescrivibile la gioia dei miei genitori nell'apprendere la notizia; non da meno fu la gioia della famiglia Galeotti.
Il rientro a Viterbo fu nel primo pomeriggio; ricordo che appena arrivato telefonai al mio amico Bruno Purchiaroni, che aveva una rivendita di auto, al quale chiesi se aveva una Volkswagen da vendere, la risposta fu affermativa; fissai l'appuntamento per il giorno successivo.
La prima cosa che feci fu quella di disfarmi, dell'Alfa Romeo, che è stata mia amica per molti anni; la cedetti, gratuitamente, a Rosi che aveva l'officina in via Santa Maria di Gradi, poi andammo da Bruno per vedere la macchina che volevo acquistare.
Nel salone, vicino alla porta d'ingresso, era una Volkswagen "maggiolino", di colore bianco, targata VT 86914.
Dopo essermi consultato con mia moglie, decisi di acquistarla.
A ragion del vero devo riconoscere che la Volskwagen è una grande automobile, anche se lo spazio interno è ridotto, ma come motore, veramente, non c'è nulla da dire.
Questa macchina l'ho tenuta fino a quando una mattina mi affacciai dalla finestra di casa e vidi, esposta in vetrina nel locale della ditta Garbini, in via Vicenza n. 36, una bellissima Volkswagen "Maggiolone", di colore giallo, targata VT 98786, che colpì la mia attenzione. Era la macchina che da tempo sognavo.
Subito scesi da casa e mi recai nel salone dove trovai il ragioniere Rosario Scipio al quale chiesi: il prezzo della autovettura e se prendeva in dietro la mia auto.
Il ragioniere, ottimo amico, mi rispose dicendo che non c'erano problemi, prendeva la mia auto in cambio del "Maggiolone" con una piccola differenza in danaro, che avrei dovuto versare.
La proposta fu allettante; in pochi minuti decisi di acquistarla, fu veramente un affare del quale ringraziai Scipio!
Le giornate sembravano non passare mai, con tanta trepidazione ed altrettanto amore attendevo l'arrivo della creatura, che sarebbe dovuta nascere verso la fine di febbraio del 1971.
La scienza non aveva fatto ancora i passi da gigante, che ha fatto poi, che consentivano di conoscere, in anticipo, il sesso del nascituro; comunque ogni tanto adagiavo l'orecchio sull'addome di mia moglie per sentire i movimenti della creatura.
Era una magnifica sensazione che faceva accapponare la pelle.
Le mie attività procedevano nel senso migliore delle aspettative; intanto era stato bandito il concorso per direttore dell'Ufficio tributi del Comune di Viterbo.
C'è da premettere che io, nel passato avevo preso parte ad altri concorsi, come quello per applicato di prima classe che vinsi, con tanta soddisfazione.
Successivamente partecipai al concorso, per direttore dell'Ufficio tributi del Comune di Viterbo che fu vinto dal signor Giuseppe Gatti perché aveva tanti titoli più di me; io mi classificai al secondo posto.
Quando andai a dare gli esami orali, ricordo che il presidente della commissione, dottor Francesco Pascarella, mi disse: "lei, ragioniere, combatte ad armi impari, c'è chi combatte con l'atomica, mentre lei combatte con il moschetto 91/38".
Io capii che non avrei realizzato il sogno sperato perché concorreva il signor Giuseppe Gatti, applicato principale, che aveva molti titoli, essendo un vecchio dipendente comunale, con un'anzianità di oltre trent'anni di servizio; gli altri concorrenti erano: Romeo Alessi che aveva anche lui oltre trent'anni di servizio, Marcuccio Marcucci, Alfredo Noto, Luigi Pascucci, Luigi Taddeucci ed altri che non ricordo, tutti comunque con la mia anzianità di servizio.
A quanto disse il presidente della commissione risposi. "Io non combatto per vincere la guerra, conosco la situazione, mi accontento di vincere una battaglia e di avere un riconoscimento sul campo".
L'entusiasmo di continuare il concorso fu al minimo perché la sera, prima degli esame orali, avemmo un grosso incidente in casa. Patrizia cadde a faccia in avanti, con tutto il seggiolone; la portammo in ospedale, le fecero una radiografia alla testa con esito buono; grazie a Dio ci dissero che la bambina stava bene.
Alla sera, verso le ore 22, dal reparto radiologico dell'ospedale, pervenne una telefonata con la quale ci allarmarono dicendo che avevano veduto, in una lastra fatta a Patrizia, un qualcosa, che non dava bene a sperare e che, intanto, avremmo dovuto mettere del ghiaccio sul punto in cui la piccola aveva battuto la testa.
Corremmo di nuovo all'ospedale dove trovammo il primario di radiologia, professore Luigi Ciarpaglini, che ci tranquillizzò dicendo che era stata una svista di un collaboratore nel giudicare una normale sutura ossea, in una sospetta frattura.
La notte fu trascorsa stando al capezzale della "cocca di casa" e, al mattino, sfinito, non volevo andare a sostenere gli esami.
La insistenza e l'incitamento dell'amico Nazzareno Capoccioni, assessore al Comune di Viterbo, fu tale che mi presentai a sostenere l'ultima prova d'esame, ero stanco, ma tanto contento perché mia figlia stava bene.
Il risultato fu quello che prevedevo, il signor Giuseppe Gatti vinse il concorso, mentre io arrivai secondo, con la idoneità a direttore.
La vita nell'ufficio non era tanto serena, io lavoravo con un certo entusiasmo senza dimenticare che certe responsabilità non mi competevano perché c'era chi le avrebbe dovuto avere.
Non passò molto tempo che il signor Gatti chiese il trasferimento all'Ufficio Economato del Comune di Viterbo. L'Amministrazione accolse la sua domanda e lo trasferì unitamente all'amico Luigi Pascucci, che manifestò il piacere di continuare a lavorare con il signor Gatti.
Nell'Ufficio tributi rimanemmo, come impiegati; Antonio Augusto Calbi, Enzio Cherchi, Gianfranco Chiusaroli, Carlo Collettini, Roberto Fasone, Umberto Felici, Giuseppe Rita e Giuseppe Todini. I vigili tributari, in organico, erano Armando Alessi e Tommaso Paoletti. Il geometra Marcuccio Marcucci, già dipendente dell'Ufficio Tributi fu, a suo tempo, trasferito all'Ufficio Tecnico del Comune con tutte le pratiche relative all'incremento di valore sulle aree fabbricabili (IVAF). Io, più alto in grado, perché rivestivo la qualifica di applicato di prima classe, mi sentii in dovere di prendere le redini dell'ufficio onde evitare che lo stesso andasse alla deriva.
Ragioniere Capo del Comune era un bravissimo ragioniere che si chiamava Umberto Natalini, aveva l'ufficio in fondo allo stabile; lui, tutte le mattine, per arrivare al posto di lavoro doveva passare davanti al mio ufficio ed io ero il primo a dargli il buon giorno, che lui, con tanta simpatia, contraccambiava.
Nella politica fu il periodo che affrontammo le elezioni amministrative per il Comune di Viterbo. Noi, della sezione "Luigi Sturzo", sostenevamo: l'insegnante Nazzareno Capoccioni, il cavalier Santino Clementi, il professore Filelfo Paccosi e il ragioniere Orlando Pace. Ricordo che, in sede di Comitato Comunale stabilimmo che sarebbe stato nominato sindaco del Comune di Viterbo il candidato che avrebbe riportato il maggior numero di voti.
In quelle elezioni concorse pure Rodolfo Gigli, già presidente del consiglio di amministrazione dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo che, pur avendo preso meno voti di Clementi, fu eletto sindaco di Viterbo.
In quell'occasione, per manifestare il mio dissenso contro l'operato di coloro che non vollero rispettare l'accordo, precedentemente preso, mi dimisi dalla carica di Segretario politico della Sezione D.C. "Luigi Sturzo".
La stampa dette vasta eco al fatto, con questo articolo: "Clamoroso gesto del ragioniere Bruno Matteacci". A ragion del vero io non avevo nulla contro Gigli, ma gli accordi, secondo me, dovevano essere rispettati.
Comunque ricordo la sera che Gigli, in Consiglio Comunale, fu eletto sindaco di Viterbo, lo stesso mi contattò per sapere cosa intendevo fare a livello politico.
Io, che conoscevo bene Rodolfo, perché abitava in via San Bonaventura n.12 e mia madre aveva il negozio al n. 8, fui contento di potergli rinnovare la mia simpatia affermando che sarei stato ben lieto mantenere solida la nostra amicizia che derivava pure dalla frequenza dello stesso bar e della stessa sala da gioco, "la kasbah".
Rodolfo Gigli è stato, per me, uno dei migliori sindaci, dal dopo guerra a oggi; anche se raffronti con altri sindaci sono antipatici. Comunque nessuno da solo può fare tutto, Gigli fu un buon sindaco grazie anche a ottimi assessori che operavano in settori importanti come potevano essere i LL.PP., l'Urbanistica e le Finanze; assessorati che il ragionier Mario Paternesi, magistralmente, ha retto per lunghi periodi.
Tanti sono stati gli avvenimenti dell'epoca, fra i quali voglio ricordare l'incontro che ebbi con Gino Bartali che portai in Comune presentandolo alla Giunta Comunale e, per essa, il ragionier Domenico Mancinelli, molto caramente, come assessore, volle donare al grande campione della bicicletta, una targa ricordo di Viterbo.
Con la fattiva collaborazione dell'amico Togo Taccari, fondai il sindacato inquilini che si chiamava A.P.A.I.,(Associazione Provinciale Assegnatari Inquilini) che aveva l'indirizzo di tutelare gli interessi degli assegnatari di alloggi dell'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari).
Appena la stampa dette notizia dell'avvenuta costituzione dello stesso con la pubblicazione del mio nome, quale Presidente provinciale del sindacato, fui contattato telefonicamente, dall'organizzazione sindacale nazionale A.D.A.CA.P., (Associazione Democratica Assegnatari Case Popolari), la quale mi offrì la Presidenza provinciale dell'Associazione stessa con la mia inclusione nella Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari della Provincia di Viterbo presso l'I.A.C.P.
Organizzai una assemblea di assegnatari delle Case popolari, già iscritti all'A.P.A.I. che, con il loro consenso, manifestato con legittima votazione segreta, passammo tutti all'A.D.A.CA.P. assumendo io la presidenza.
Successivamente dall'Amministrazione Provinciale prima e dalla Regione poi fui nominato membro della Commissione Provinciale Assegnazione alloggi presso l'Istituto Autonomo Case Popolari che aveva sede in piazza Sant'Agostino ed era presieduta da un magistrato.
Nella predetta Commissione faceva parte di diritto il sindaco del paese nel quale erano gli alloggi da assegnare, o persona da lui delegata, il direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o suo delegato i Presidenti o loro delegati dei Sindacati inquilini A.D.A.CA.P, S.I.C.E.T e S.U.N.I.A. I rappresentanti delle forze politiche, il rappresentante dell'I.A.C.P. e il rappresentante della CC.DD.
Questa era una commissione che lavorava quasi tutti i giorni della settimana, per oltre un'ora a seduta. Era una commissione molto operativa e seguita dalla cittadinanza.
Nel corso degli anni si sono succeduti vari magistrati, con l'incarico di presidente della Commissione fra i quali ricordo, con piacere, il dottor Vittorio Palmisano, il dottor Ernesto Raffaele Caliento ed il dottor Italo Ernesto Centaro.
Poter dare la casa a chi, veramente, aveva diritto era una grande soddisfazione; soddisfazione e piacere che poteva provare solo chi aveva avuto, nel passato, questo problema e questa necessità.
All'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, intanto, c'era tanto da lavorare, ricordo che, quale più elevato nel grado, come già scritto, presi le redini per la conduzione dell'ufficio.
Con grande stupore trovai, negli schedari gestiti dal capo ufficio, oltre dodicimila ricorsi presentati, dai contribuenti, avverso gli accertamenti del Comune; ciò mi spaventò, pur sapendo che c'era un certo arretrato di lavori, non avrei mai immaginato di trovare quello che ho trovato.
Mi rimboccai le maniche, mi misi a leggere i ricorsi, uno per uno, allo scopo di rendermi conto della situazione creditoria del Comune, prendendo appunti allo scopo di avere chiara la situazione e di essere in grado di richiedere ai vigili tributari dettagliate informazioni. Passarono vari giorni di assestamento mentre la fiducia dei miei collaboratori era tanta e rinnovata ogni giorno, con l'amicizia dimostratami.
Trascorsi alcuni mesi, il sindaco Gigli domandò chi era il direttore dell'Ufficio Tributi; alla risposta datagli, che l'ufficio era diretto da Bruno Matteacci, pur non avendo il grado, perché si doveva bandire il concorso per tale posto, lo stesso, sentito il ragioniere capo, Umberto Natalini, che lo rassicurò sulle mie capacità; mi conferì, con atto deliberativo, l'incarico di Capo Sezione, facente funzioni, dell'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo.
Con deliberazione n° 420 del 16 novembre 1970 venne bandito il concorso per la copertura di un posto di Capo Sezione amministrativo; da quel momento iniziò per me un periodo massacrante di studio poiché, faceva ancora eco il risultato dei precedenti concorsi da me sostenuti e vinti; quindi per me era fatto obbligo prepararmi in maniera tale da non smentire quanto si diceva di me circa la mia preparazione.
A proposito, riferendomi al concorso di applicato di prima classe, voglio, con orgoglio, raccontare un fatto che mi dette molta gioia.
Da pochi giorni avevamo sostenuto gli esami per detto concorso, nulla si sapeva dei risultati, mentre il lavoro procedeva normalmente.
All'Ufficio Tributi era giornalmente un gran affluire di pubblico perché avevamo pubblicato i nuovi ruoli della imposta di famiglia, quindi i contribuenti erano molto interessati a vedere la propria posizione tributaria.
Mentre stavo al bancone intento a servire il pubblico, dopo aver parlato con vari contribuenti, si avvicinò un signore il quale, mi presentò la notifica dell'accertamento, chiedendomi chiarimenti circa la composizione del reddito imponibile attribuitogli.
Il nome del contribuente era a me sconosciuto, lo lessi sull'avviso di accertamento e seppi dove lavorava, nel momento in cui aprii il fascicolo.
Dopo aver dato le dovute delucidazioni, visto che mi veniva richiesta la possibilità di effettuare un concordato; procedura autorizzata dall'Amministrazione Comunale, gli proposi la definizione della pratica in un certo senso, che fu accettato.
Nel momento conclusivo dell'operazione era mio dovere apporre, in calce della pratica, la firma allo scopo di garantire, alla Giunta Comunale, che si era proceduto nel senso giusto. A questo punto quel signore esclamò: "ah... è lei Matteacci?". La domanda mi solleticò la curiosità, in considerazione al fatto che quel signore lavorava in Prefettura, con un grado professionale elevato, gli domandai: "scusi dottore, che per caso conosce l'esito del mio concorso?". La mia domanda, chiaramente, non ebbe alcuna risposta, ma il sorriso, benevolo, di quel contribuente mi lasciò ben sperare.
La speranza non fu delusa, dopo pochi giorni seppi che avevo vinto, brillantemente, il concorso di applicato di prima classe.
Come pure ebbi grande soddisfazione sentir dire che, la quasi totalità dei candidati al concorso di Capo Sezione, dove giunsi al secondo posto, alla domanda del Presidente di commissione di "scegliere un argomento a piacere", parlarono tutti degli "Organi del Comune". A tale invito del Presidente della Commissione risposi che intendevo parlare degli "atti amministrativi, validità, annullabilità e loro efficacia". Ricordo che ci fu un attimo di stupore in tutta la Commissione perché erano stati abituati a sentire, sempre, la stessa nenia relativa agli Organi del Comune.
Allora, come ripeto, per l'esame che avrei dovuto sostenere, era fatto obbligo a Bruno Matteacci prepararsi in modo adeguato, da non deludere le aspettative personali, della famiglia e dei collaboratori.
Gli avvenimenti di questo periodo furono importanti, ma quello che maggiormente contava, era in arrivo!
Attendevo, per la fine del mese di febbraio 1971, la nascita della mia creatura.
I giorni passavano, non vedevo l'ora che giungesse la fine di febbraio, quella era la data prevista per la nascita di "lui" o di "lei".
Non voglio essere ipocrita io aspettavo "lui", come, avevamo programmato nel 1962, quando conobbi mia moglie. Veramente furono fatte varie ipotesi sulla data di nascita, una che ci si augurava era quella che avvenisse il 3 marzo, data di nascita del nonno Giuseppe.
Giungemmo al tre marzo, senza alcun cenno; consultammo il medico che seguiva mia moglie il quale ci rassicurò dicendo che la creatura stava bene.
Con il cuore in mano ed il pensiero, sempre rivolto al grande evento, aspettavamo l'arrivo di chi tanto si attendeva.
La sera del 18 marzo 1971, verso le ore 21 eravamo in casa, in via Pieve di Cadore n.8; mia moglie stava cuocendo le frittelle di San Giuseppe, quando ebbe il primo segno; la creatura tanto attesa bussava alla porta del mondo.
Dopo aver avvisato i famigliari, prendemmo quanto di necessario e ci avviammo all'Ospedale Grande degli Infermi, dove mia moglie fu ricoverata e sul tardi, verso le ore 23 fu condotta in sala travaglio.
Solo chi lo ha provato e solo chi ama i proprio cari, può capire lo stato d'animo di chi attende, perché le preoccupazioni aumentano con l'avvicinarsi del momento più bello, per una coppia di genitori. In quei momenti non si pensa più a tutto quello che si è pensato e ci si è augurato, una sola cosa viene spontanea augurarsi che la creatura e la madre stiano bene.
Stare nel corridoio impotenti e all'oscuro di ciò che avviene al di là della porta della sala travaglio, significa, per attimi, morire. Non era norma che il padre assistesse alla nascita della propria creatura, forse anche per una forma di una stupida ingenua pudicizia delle donne che, all'epoca, rifiutavano la presenza del marito in sala parto. Quello, invece, era il momento più bello da dover condividere fra i due coniugi che hanno voluto, atteso, sognato e desiderato una creatura che non conoscevano e quindi dovevano essere loro i primi, a vedere, toccare e baciare questo frutto dell'amore voluto e benedetto da Dio, invece che lasciare fuori da questo grande evento l'attore, terziario, della nascita, ma attore principale del concepimento; si perché della nascita l'attore principale è la creatura che deve nascere e l'attrice secondaria è la mamma che, per nove mesi, ha gelosamente gestito la gravidanza, tra le trepidazioni del padre.
Alle ore una e cinque minuti del 19/03/1971 è nato Giuseppe Matteacci, il mio tanto amato figlio che attendevo da tanti, tanti anni e, il buon Dio, mi ha voluto premiare facendolo nascere proprio il giorno di San Giuseppe a dispetto di chi, malignamente, non voleva che chiamassimo nostro figlio: Giuseppe.
Quello fu un segno di Dio, così io l'ho interpretato.
Non ci sono parole per dire la gioia che provai, ero l'uomo più felice del mondo, avevo due bei figli, una femminuccia, Patrizia ed un maschietto, Giuseppe; proprio come avevamo programmato, con la mia fidanzata, nel settembre 1962, durante una passeggiata ai giardini pubblici.
Analoga gioia fu di mia moglie e dei nonni, in particolare di mio padre che si sentì onorato e inorgoglito del fatto che io chiamassi mio figlio con il suo stesso nome.
Il giorno successivo, 20 marzo 1971, mi recai al Comune di Viterbo, per procedere alla registrazione di mio figlio nei registri dello stato Civile, dove fu iscritto al n° 293 Parte I Serie "A".
Nella stessa data mi feci rilasciare il primo certificato di nascita di Giuseppe Matteacci. Ricordo la gioia che provò Patrizia nel vedere, per la prima volta, il fratellino; fu veramente un incontro commovente e pieno d'amore!
Giuseppe è stato battezzato nella Chiesa di Santa Maria della Verità; padrino fu mio cognato Marcello Palano, al quale suggerimmo di dare, come secondo, nome quello di mio suocero Enrico, mentre madrina fu mia sorella Bruna, la quale dette, come terzo nome Bruno. Ero felice, avevo tutto quello che desideravo!
L'onorevole Giulio Andreotti, il 2/4/1971, mi inviò per Giuseppe una medaglia recante l'immagine della '"Lupa" con la seguente scritta: “Oni hil maius urbe Roma” accompagnata dalla seguente lettera: "Caro Matteacci, mi rallegro con i genitori ed esprimo auguri affettuosi al piccolo Giuseppe".
In Comune intanto le cose andavano avanti, la Giunta Comunale, con deliberazione n.131 del 2 aprile 1971 nominò la commissione giudicatrice del concorso per Capo Sezione, al Comune di Viterbo.
Nel mese di maggio 1971 iniziarono gli esami relativi al concorso di Capo Sezione.
Io, per quanto riguardava materie non inerenti il mio ufficio, studiai molte ore di giorno e di notte, consapevole che avevo a che fare con dei colleghi molto preparati ed agguerriti.
Per quanto riguardava la conoscenza della materia relative alla Finanza Locale ed alla Ragioneria, non temevo nessun concorrente, ma era da non sottovalutare la complessità della Legge Comunale e Provinciale a causa delle nuove normative che erano in fase applicazione; per la prima volta, ci fu la soppressione di certi tributi e la istituzione di nuovi.
Con deliberazione n° 818, della Giunta Comunale del 24 giugno 1971, fui proclamato vincitore del concorso con punti 44,73 su 100; al secondo posto si classificò il ragioniere Alfredo Noto con punti 43,20 ed al terzo posto il geometra Marcuccio Marcucci con punti 42,49. La nomina, al posto di Capo Sezione Amministrativo in organico del Comune di Viterbo, ebbe decorrenza dal 1° luglio 1971.
All'inizio della mia responsabilità di Direttore dell'Ufficio Tributi, non intesi occupare subito la stanza, a me riservata; mi sembrava di volermi distaccare da coloro che mi avevano insegnato a lavorare, come Enzio Cherchi; rimasi a lavorare nel salone, nel mio solito tavolo di lavoro.
Dopo qualche giorno, dal ragioniere capo Umberto Natalini, fui sollecitato ad occupare la stanza, che fu del mio predecessore.
Volli cambiare tutti i mobili, perché quelli esistenti erano in metallo e di uno stile ormai sorpassato; io gradivo avere uno studio con mobili di legno, con poltrone ed armadi degni di un ufficio importante, come quello dei Tributi e che da quel momento dirigevo.
L'Amministrazione Comunale intese soddisfare il mio desiderio, fece arredate l'ufficio in una maniera veramente ottimale. Addirittura sulla porta, fece mettere, in uso, il campanello a tre fasi, con le scritte: "occupato, attenda, avanti".
Una delle prime cose che feci, nell'assumere la direzione dell'Ufficio Tributi, fu far lavorare, nel vero senso della parola, la Commissione Comunale di Prima Istanza.
Riuscii a far eleggere, presidente della stessa, l'avvocato Alessandro Paris che, oltre ad essere una persona molto preparata, nel settore tributario, era un mio amico sotto ogni punto di vista quindi, nell'interesse superiore del Comune, avevo senza dubbio un grande collaboratore o meglio lui ed io facevamo una bella pariglia, che lavorava nell'interesse del Comune e nel rispetto del contribuente.
Sandro Paris è stato pure un caro amico di partito, sempre pronto a dare consigli disinteressati, mai si è fatto indietro, anche se, qualche volta, avrebbe avuto validi motivi per dissentire da certi operati e da certi concetti espressi da persone che ruotavano intorno alla Democrazia Cristiana.
Con Paris presi i primi contatti allo scopo di iniziare l'esame della grande quantità di ricorsi che giacevano da anni nei cassetti dell'ufficio. Si era in vista della riforma tributaria; si ebbe sentore che, negli anni dopo il 1972, lo Stato avrebbe dato una somma di danaro, ad integrazione dei tributi soppressi, pari a quanto accertato nel 1972.
Dall'esame degli atti parlamentari venni a conoscenza che lo Stato avrebbe dato si una integrazione, ma non sulla base di quanto accertato dai Comuni, ma sulla base di quanto riscosso dagli stessi.
La differenza era evidente e logica la sua applicazione. Sarebbe stato facile gonfiare il totale degli accertamenti, allo scopo di avere dei finanziamenti maggiori; mentre era più logico operare sull'effettiva entrata tributaria.
Mi orientai verso questa soluzione, ci mettemmo a fare concordati a più non posso consentendo al Comune, di avere grosse entrate tributarie.
Nello stesso periodo scoppiò la questione I.V.A.F..
Dopo una serie di dibattiti, in sede di Consiglio Comunale, sulla questione dell'I.V.A.F. (Incremento di Valore delle Aree Fabbricabili), la Giunta Comunale entrò nell'ottica di ritrasferire, alla mia Sezione, tutte le pratiche che erano, in una stanza dell'ufficio Tecnico, dove lavorava il geometra Marcuccio Marcucci, già responsabile della gestione del tributo.
Iniziai a fare un esame della situazione I.V.A.F; dopo aver lavorato giorni e intere notti mi accorsi che, a Viterbo, c'erano molte costruzioni per le quali non era stata pagata l'imposta. Si mise in moto l'accertamento con l'applicazione delle sovrimposta e la effettuazione di verbali di contravvenzione, contestati dai nostri vigili tributari.
Nell'applicazione dell'I.V.A.F., fui molto agevolato dalla fattiva ed esperta e leale collaborazione del geometra Carlo Collettini, che mi è stato molto vicino e, quello che conta di più, mi è rimasto amico, che stimo e ringrazio. Il geometra Collettini fu nominato segretario della Commissione Comunale di 1ª Istanza ed anche in questa circostanza dimostrò di essere un ottimo impiegato che, purtroppo, l'Amministrazione Comunale non seppe valorizzare.
Io nella Commissione facevo la parte del Pubblico Ministero cioè, come diceva qualcuno, ero "l'avvocato del diavolo", perché operavo nell'interesse della Amministrazione Comunale, senza ignorare che, se il contribuente aveva ragione, si aveva il piacere di recepire quanto egli diceva; riducendo il tributo nella maniera più equa possibile.
Non nascondo che per due o tre volte ho dovuto chiedere l'aumento di quanto era stato accertato a carico del cittadino perché, a seguito di accertamenti ero venuto a conoscenza che la situazione patrimoniale del soggetto era migliore di quella valutata e considerata in fase di tassazione .
Logicamente tale azione mi rendeva poco simpatico agli occhi del contribuente, ma partivo dal concetto che le tasse le dovevano pagare tutti, sulla base della propria effettiva capacità contributiva e che se tutti pagavano il giusto, tutti avrebbero pagato di meno.
Appena divenni direttore dell'Ufficio Tributi di Viterbo la prima cosa che feci fu quella di prendere in esame la pratica tributaria di mio padre al quale applicai: l'imposta di patente, la tassa sulle insegne, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e gli aumentai la imposta di famiglia, ponendolo al primo posto della classifica dei calzolai di Viterbo.
Ricordo che quando al babbo, arrivarono le notifiche degli accertamenti, con molta discrezione, mi chiese notizie in merito. Io, scherzosamente, gli dissi che doveva venire in ufficio per avere delucidazioni, poi lo ragguagliai su ogni particolare, al che il babbo disse: "Ma allora le hai messe proprio tu queste tasse? Ringrazio Iddio che ho il figlio direttore; è giusto quello che hai fatto e sono contento perché qualche soldo delle mie tasse rientreranno nel tuo stipendio".
Il babbo e la mamma erano veramente orgogliosi della mia carriera, sono sicuro che, senza i loro sacrifici, non avrei mai potuto, conseguire un titolo di studio.
Quindi, ancora una volta, cari genitori, vi sono grato e mai cesserò di ringraziarvi per quanto avete fatto per me e, di conseguenza, anche per i miei successori, perché se la prima pietra la si mette nel modo giusto ed in piano, è facile costruirci sopra.
I miei genitori la prima pietra l'hanno messa facendo studiare Bruno e le conseguenze sono state logiche e facili.
Le giornate erano una più bella dell'altra ci si avvicinava alla fine dell'anno e i miei figli, grazie a Dio, crescevano bene; avevo una famiglia della quale ero orgoglioso.
Bruna e Vinicio acquistarono un ettaro di terreno, in località Valle Cerasola, a La Quercia, dove era una bella grotta, che fu adibita a cucina e a forno e nella parte superiore costruirono una rotonda in legno, con basamento di cemento, che veniva utilizzata come ricovero dalle intemperie e dove spesso ci pranzavamo.
Successivamente, su progetto dell'architetto Giulio Mazza, chiesero la licenza edilizia per la costruzione di una villa che fu fatta, materialmente, da mio cognato Vinicio, da Mauro, che operavano come muratori e da tutti gli altri componenti la famiglia, me compreso, con varie mansioni. L'entusiasmo di vedere realizzata una villa, grazie al nostro lavoro manuale, era al massimo.
Politicamente, dovevamo affrontare le elezioni Provinciali; incominciarono le riunioni del caso.
Quando giungemmo ad esaminare le eventuali candidature per i collegi di Viterbo, nel prendere in esame il collegio numero uno, per intenderci, quello del Pilastro, l'onorevole Attilio Jozzelli, consapevole che quel collegio, per la Democrazia Cristiana, era difficile vincerlo, pensò che sarebbe stato il caso che il candidato fosse Santino Clementi o Bruno Matteacci perché, nella zona avevano, entrambi, un forte ascendente politico.
Quando si dovette stringere la discussione, con una decisone e la relativa sottoscrizione della candidatura, Santino Clementi disse che non gradiva concorrere perché quello era un collegio difficile e lui non se la sentiva di correre il rischio di non essere eletto.
Con uno sguardo, tra l'onorevole Jozzelli e me, ci dicemmo tutto, silenziosamente.
Io, un poco incavolato, dissi che il partito si serve in tanti modi, anche con un risultato finale negativo e non sempre con le "presidenze" pagate, perché se la persona, che deve concorrere, prendesse solo un voto di più, tutto, sarebbe a vantaggio della Democrazia Cristiana.
"La peggiore cosa è parlare con chi non vuole sentire", questo è quanto mi disse l'amico Attilio Jozzelli.
Accettai di concorrere nel primo collegio, certo anche che, come elettori, avrei avuto pure i cittadini residenti a Villanova dove avevo gettato le basi, grazie all'amicizia con don Armando.
Sia ben chiaro, don Armando Marini non ha mai fatto politica, lui era al di sopra delle parti e mai, dico mai, ha detto ad una persona di votare in un certo modo; quando dico avevo "gettato le basi" intendo dire che avevo iniziato a conoscere gli abitanti della zona solo perché mi avvicinai a don Armando, come sacerdote.
A tale proposito voglio raccontare come avvenne il mio ingresso sul territorio di Villanova.
Don Armando Marini iniziò a celebrare la Santa Messa nella cappella della Villa del signor Filippo Cecchetti, successivamente prese in affitto un locale, a piano terra, in via Villanova n.4, dove oggi è la pizzeria Villanova.
L'incontro fu richiesto e concordato, fuori il cimitero di San Lazzaro, al termine della santa Messa.
Come stabilito, la successiva domenica mattina andai, all'ora stabilita, per ascoltare la Messa, celebrata da don Armando. Al termine della Messa, don Armando disse ai presenti di non andar via perché, quella mattina, era presente una persona che avrebbe potuto aiutare la comunità della nuova parrocchia.
Quella mattina eravamo, con don Armando, in quattordici; alla fine della Messa ci mettemmo a parlare tra noi e la prima cosa che io promisi fu quella di garantire tutti i miei sforzi per ottenere la concessione, anche provvisoria, del terreno, a fianco della calcestruzzi del commendatore Vicenzo Bologna, da utilizzare come campo sportivo.
Il terreno fu concesso, anzi Vincenzo provvide pure a far dare una spianata e a fare le porte per il gioco di calcio.
Il giorno della inaugurazione del campo si fece una partita tra scapoli e ammogliati e il primo calcio, al pallone, lo feci dare dal professore Gilberto Pietrella che, nell'ultima revisione delle liste elettorali, gli concessero anche la zona di Villanova, come se fosse del IV collegio, dove lui concorreva. L'operazione politica amministrativa danneggiò il sottoscritto perché tolsero dalla mia potenzialità elettorale un congruo numero di elettori.
Quando si vuole favorire qualcuno tutti i mezzi, per alcuni, sono buoni.
C'è da dire che parte degli elettori di Villanova, normalmente, votavano nel seggio 53, ubicato al Pilastro ed addirittura alcuni andavano al seggio 35 di Monte Jugo e altri al seggio 51, che era ubicato nella Scuola Orioli in via Emilio Bianchi.
In poche parole erano tutti elettori del 1° collegio dove concorrevo io.
Poiché volevano assicurare al professor Gilberto Pietrella la elezione, dirottarono tutti gli elettori che avrebbero dovuto votare nei seggi 35, 51 e 53, nei seggi della Scuola "Pantanese" dando come giustificazione che la scuola era vicina a Villanova.
La vigliaccata fu quella di calcolare la distanza tra il seggio del "Pantanese" e Villanova attraversando la ferrovia dello Stato, dove era un passaggio a livello con un certo numero di lucchetti che consentivano l'attraversamento solo ai possessori delle chiavi; infatti, ogni utente, del passaggio, aveva un lucchetto che veniva chiuso con altri lucchetti, collegati tra loro.
Nei successivi incontri con il caro don Armando gli promisi il mio incondizionato aiuto per la soluzioni dei tanti, tantissimi problemi che aveva in vista della esecuzione delle opere che lui aveva in programma.
A tale proposito mi dette un congruo numero di fogli di carta intestata, con apposta la sua firma, ora al termine del foglio, ora in alto a mezza pagina, allo scopo di consentirmi di scrivere quello che volevo, nell'interesse della Parrocchia.
Non si può parlare di don Armando senza tirare fuori dal cuore quello che lui ha messo in noi quando abbiamo avuto la fortuna e la grazia di stargli vicino per ascoltare le sue parole, i suoi suggerimenti, i suoi sermoni ed anche i suoi, accettati, rimproveri atti a riportarci sulla strada giusta e poter avere il piacere di sentirsi sereni, felici, liberati dal male.
Con don Armando ho provato la sensazione che ebbi quando feci la prima Comunione. Ricordo che quando, nel 1947, mi avvicinai per la prima volta al Sacramento della Comunione, provai una gioia immensa, mi sembrava di esser più leggero, di non stare con i piedi in terra.
Ebbene, quando don Armando mi toccava una spalla o mi metteva, come era suo solito fare, una mano sulla testa, io provavo la stessa sensazione, cosa che non ho più provato, nel tempo, dopo quel tremendo 21 febbraio 1996, giorno in cui in Paradiso il mio fraterno amico Armando Marini fu chiamato lasciando tante, tantissime persone sole e abbandonate.
Fra questi ero io che in don Armando vedevo il punto luminoso presso il quale in ogni circostanza potevo rivolgermi e chiedere una parola di conforto, un consiglio, una parola che, ottenuta, era come ricevere un bicchiere d'acqua, dopo aver attraversato un deserto, senza bere, sotto il sole infuocato.
Don Armando era, è, e sarà, sempre una "fonte d'amore" che ci disseterà!
Di lui, ancora, ho tanto, tanto da dire perché ho avuto la fortuna di essergli stato, fisicamente, vicino per molti anni, come lui è stato vicino a me, alla mia famiglia in varie, tristi circostanze.
La campagna elettorale, per il rinnovo del Consiglio della Amministrazione Provinciale di Viterbo, ebbe inizio con un certo sottotono e amarezza negli animi di coloro che amavano il partito e che, per esso, hanno fatto tante battaglie.
Tutto fu dovuto al fatto che certe persone, per il solo motivo che erano dei "lecca culo", dal Partito hanno avuto tutto, anche se avevano, nel cervello, poca materia grigia, ma erano solo dei ruffiani che riuscivano a tirare l'acqua verso il proprio molino.
Per fortuna di queste persone, nella Democrazia Cristiana, c'erano poche, se ne potevano contare sulle dita di una mano.
Comunque, con i miei amici, ci mettemmo a fare la campagna elettorale e tutto quello che potevamo fare nell'interesse del Partito, sacrificando affetti, perché spesso, ci si allontanava dalla famiglia per intere giornate e, a volte affrontando, di tasca propria, spese nell'interesse del Partito.
Normalmente le affissioni dei manifesti venivano fatte durante le ore notturne perché, chi collaborava gratuitamente, non poteva distrarre tempo dal lavoro ed allora, tutti, ci si organizzava per dopo cena.
All'epoca era ancora consentito mettere, attraverso le vie, gli striscioni con i nomi del candidato che si voleva sostenere. A mie spese, ne ordinai tre al noto pittore viterbese Sergio Mattiacci, che mi praticò un prezzo d'amico.
Poiché alle elezioni provinciali i candidati erano un consistente numero, e considerato che le vie della città non erano tutte idonee per l'affissione di uno striscione trasversale, la questione venne sottoposta al giudizio di una apposita Commissione comunale che concedeva, ai vari richiedenti, specifiche autorizzazioni per la occupazione di area pubblica, comunque ognuno poteva affiggerli nel territorio del proprio collegio elettorale.
Io ebbi l'autorizzazione di occupare tre spazi e precisamente: al termine di via Cavour su piazza del Plebiscito; in via Ascenzi, al termine su piazza del Sacrario con facoltà di spostarlo in via Cairoli; in via della Palazzina, all'altezza di Prato Giardino.
Sui tre striscioni, bifacciali, azzurri con scritta bianca era, ai lati, lo stemma del Partito e su tutta la sua lunghezza era scritto: Democrazia Cristiana - per il collegio n°1 - Vota Bruno Matteacci.
Furono fatti stampare fax simili e molti manifesti, fra i quali numerosi con la foto; in quell'epoca avevo una folta barba.
Mia moglie scrisse alle elettrici del collegio sollecitando la mia elezione.
Fu un plebiscito di simpatia da parte di molte famiglie che, in quell'occasione, sebbene nel passato votassero per la Destra, non fecero mancare la loro stima a Matteacci
Non c'era da dimenticare il tiro mancino che mi fu fatto sottraendo, dal mio collegio, tutti gli elettori di Villanova, ma io non mi accorai del fatto, sapevo che dovevo servire il Partito e non fare come qualche altro che puntava solo ad avere remunerate contropartite, a quel poco che il suo cervello poteva dare.
Una notte, mentre stavamo mettendo uno striscione in via Raniero Capocci, all'altezza dei locali dell'ex cronicario, nello spiazzo di in un distributore di benzina, vidi una roulotte con affisso il cartello "vendesi" e l'indirizzo del commerciante.
Notai che la porta di accesso era aperta, la curiosità mi spinse a guardare l'interno; varcai la porticina e un colpo ferì il mio cuore; ebbi una impressione che mai dimenticherò.
Rimasi talmente colpito che l'indomani, in compagnia di mia moglie, andammo a vedere la roulotte; era piccola, ma nella sua piccolezza era di un'immensa bellezza.
Non ci pensammo due volte, decidemmo di acquistarla; prendemmo i dovuti contatti col il Cavaliere del Lavoro, amico Socrate Sensi, che era il concessionario della "Sprite Major", fabbrica inglese della roulotte.
Ne vedemmo varie, ma decidemmo di acquistare la più grande; era lunga sei metri ed aveva tutti i servizi: due camere per sette persone un lettino a castello per l'ottavo posto, frigorifero a gas, batteria e ad energia elettrica, cucina a gas a tre fornelli, bagno ed ampie finestre in tutti i lati; fu targata VT1346 e la pagammo L. 1.820.000.
Con l'occasione acquistammo pure la veranda, il cucinino ed una ampia stuoia.
Avevamo fatto, veramente, una bella spesa, ora mancava solo di trovare un nome da dare alla roulotte.
Ci volle poco per trovarlo, bastò guardarsi intorno e fare un esame dei nostri nomi.
La chiamai "Pagiuba" dai nomi: Patrizia, Giuseppe, Bruno, Antonietta, che, dall'amico Sergio Mattiacci, lo facemmo scrivere sul lato posteriore della roulotte.
Per qualche settimana la roulotte è stata parcheggiata nel giardino dell'Okay, dove vennero a vederla i miei genitori e mio nipote Franco Palano, sempre carino e gradito.
Appena entrato in possesso della roulotte ed ottenuti i documenti idonei per la circolazione, l'agganciai al mio "Maggiolone" e mi misi in viaggio verso Montefiascone, dove incontrai i miei genitori che stavano parlando con gli zii; ricordo la smorfia che fece zio Eugenio nel vedere la roulotte, capii che, nella sua semplicità, non si rese conto che avevamo acquistato un mezzo, e che mezzo, per andare in villeggiatura.
Il giorno successivo andammo a Civitavecchia dove pernottammo ai margini di un giardino pubblico, fu una esperienza da non dimenticare, comunque eravamo contenti, la più entusiasta era, senza dubbio, Patrizia, considerato che Giuseppe era piccolino.
Il sabato successivo andammo a Montalto di Castro, in riva al mare, dove ci fermammo, con lo scarico della roulotte, sopra ad un tombino allo scopo di avere la certezza che le acque bianche, prodotte, andassero in fogna e non per il piazzale, a cielo scoperto.
Pernottammo felicemente con la speranza di poter andare in villeggiatura quanto prima. Il motivo ispiratore di queste escursioni, sul territorio viterbese, aveva lo scopo di prendere una certa dimestichezza con la guida ed il traino della roulotte.
L'accortezza, che si doveva avere, era: fare un carico bilanciato, cosa che, per la prima volta, stante la paura che la roulotte mi si sganciasse, lo avevo fatto gravitare sul timone; questo fu un errore perché le ruote della vettura si surriscaldavano.
Nell'estate del 1973, durante il viaggio, per Viareggio, all'altezza di Albinia, sull'Aurelia, notai che la parte anteriore della Volkswagen aveva poca aderenza al suolo e le gomme posteriori dell'auto "fumavano", per fortuna c'era una pioggerella; le gomme si erano surriscaldate perché non erano state sufficientemente gonfiate.
Dopo aver aumentato di pressione le gomme, mi fermai in prossimità di un cumulo di brecciolino, che era ai margini della strada, ne raccolsi una certa quantità e lo misi nella parte anteriore dell'auto, nel punto in cui è la ruota di scorta, allo scopo da fare contro-peso e consentire, alle ruote anteriori, una maggiore aderenza al suolo.
Da quel momento, dopo aver messo in atto gli accorgimenti citati, tutto andò per il verso giusto; giungemmo a Viareggio e proseguimmo verso il Lido di Camaiore, dove ci fermammo, a pernottare, nel piazzale di un distributore della "FINA", che era chiuso.
Al mattino venne il gestore del distributore che, molto carinamente, ci offrì la possibilità di sostare per tutto il periodo della villeggiatura, cosa che ci fece molto piacere e che accettammo.
Ricordo che nell'area di servizio erano: i servizi igienici, una tettoia di canne dove potevo mettere l'auto ed un ampio spiazzo dove parcheggiare la roulotte.
C'era inoltre un praticello dove mettemmo delle sdraie. Il mare distava circa trenta metri dalla nostra postazione; era sufficiente attraversare la strada, l'arenile e il mare erano a nostra disposizione.
Era un posto da paradiso dove i miei figli, Patrizia e Giuseppe ci hanno allietato per tutto il periodo del nostro soggiorno al Lido di Camaiore.
Diventammo amici dei figli del gestore del distributore che avevano una grande stazione di servizio, della "FINA", a ridosso del noto locale "La Bussola", dove una sera, dopo aver mangiato nel magnifico ristorante "Lo squalo", portai la famiglia.
Il periodo trascorso in Toscana fu magnifico sia per i luoghi, che per la cortesia e l'affabilità della gente.
Al termine del soggiorno a Viareggio decidemmo di andare in Umbria e precisamente a Pietralunga dove era in attività un campeggio, e cosa più importante dove nacque mio padre, lì abitava un cugino Oliviero Matteacci, che conobbi poco tempo prima.
Giunti a Pietralunga, in località Boschetto ci attendevano i nostri cugini Oliviero e Umbertina, con il loro figlio Giuseppe, che ci accompagnarono a Candeleto, zona in cui era il campeggio.
L'accoglienza fu tanto affettuosa come del resto fu quella che ci riservò tutta la cittadinanza di Pietralunga.
Nel periodo trascorso a Pietralunga facemmo visita a nonna Assunta a Gubbio la quale, sempre affettuosa, ci accolse con tanto amore.
La vita da campeggiatore a me piaceva molto perché uno si sentiva libero da ogni pregiudizio e molto vicino alla natura.
Erano sufficienti un paio di pantaloncini e un paio di sandali per sentirsi liberi dalla malefica cravatta e dal vestito in tinta.
La roulotte, per la sua ampiezza, completa nei suoi servizi, era veramente un luogo dove si potevano trascorre tranquillamente il giorno e la notte.
Lo strumento più utilizzato per cucinare era la bistecchiera e la pentola per cucinare gli spaghetti. In quell'occasione conoscemmo dei simpaticissimi signori che erano amici di Oliviero, provenienti da Città di Castello, i quali avevano un bambino che giocava con i nostri figli.
Belli erano quegli incontri, fra amici, davanti a piatti fumanti di cibo cucinato con legna e carbone, tutto era appetitoso e buono, dalla semplice "bruschetta" al fungo porcino, cotto sulla brace. Poi che dire del dopo cena quando ci si riuniva per raccontare barzellette?
Bei tempi, che se ne sono andati; è terminata la gojardìa della gioventù, che non ritornerà mai più! Anche questo è giusto; ad ogni età deve corrispondere un certo tipo di svago; la facile gojardìa, con il tempo, l'abbiamo demandata ai nostri figli che, a suo tempo, passeranno il testimone ai loro figli e noi, felici, continueremo a vivere i nostri ricordi e la nostra gioventù, guardando i nostri, amati, nipoti.
Nell'anno 1973 fui iscritto, quale cicloamatore, categoria "E", al "Gruppo Ciclistico Viterbese" della Federazione Ciclistica Italiana CONI- Roma con tessera n.49181 perché appassionato corridore; facevo magnifiche gare con la mia bicicletta "Bartali", che ho tuttora.
Intanto, grazie a Dio, i figli crescevano bene e per Patrizia, giunse il momento di andare a scuola. La iscrivemmo nella scuola privata della "Beata Angelina" con sede unica in piazza dell'Orticara.
Accompagnare mia figlia a scuola fu una bella esperienza; ricordo il momento in cui ci salutammo con un forte abbraccio ed un bacio; io e mia moglie rimanemmo nel piazzale a guardare il suo ingresso nello stabile con uno stato d'animo addolorato perché, da quel momento, la nostra Patrizia stava, anche se per poche ore, lontana da noi.
Fare il genitore è difficile, quel distacco, anche se temporaneo, mi faceva soffrire, non vedevo l'ora di riabbracciarla, fino a quando, per esigenze d'ufficio, dovetti fare a meno di assicurare la mia presenza all'uscita di Patrizia dalla scuola.
La gioia di avere una figlia "grande" che andava a scuola mi rendeva orgoglioso; avevo una figlia ed un maschio che, riempivano la mia vita.
Nel mese di settembre 1973 ci cadde il mondo in testa venimmo a conoscenza di un certo disturbo che aveva il babbo, non perdemmo tempo. ll babbo fu visitato dal professore Dante Manfredi, di cui mi onoro essere amico, il quale diagnosticò che c'era un polipo da togliere, mediante intervento chirurgico da effettuare entro l'anno.
Visto che il professore operava, a Roma, nella clinica "Valle Giulia" ai Parioli, prenotammo una camera, per la degenza del babbo e per la permanenza di mamma, Bruna e mia perché intendemmo non abbandonare, nemmeno per un attimo, il babbo, che fu operato il giorno 11 dicembre ed il 13, giorno di Santa Lucia, facemmo ritorno a casa.
Di quanto aveva il babbo non fu fatta menzione né a lui né a mamma; noi ci tenemmo, nel cuore, tutto il dolore possibile e immaginabile.
Dell'argomento il babbo non voleva nemmeno sentirne parlare; mi diceva che durante l'intervento, che fece da sveglio, senza anestesia, aveva sofferto molto.
Si avvicinava il Natale 1973, tutto procedeva per il senso migliore, nel mondo della politica riscuotevo stima e piacere nel lavorare per aiutare il prossimo.
Durante un'assemblea di partito, ebbi modo di pronunciarmi su un argomento che all'epoca era sulla bocca di tutti: "il disarmo delle Forze dell'Ordine".
Ricordo che, durante il mio intervento, ebbi modo di dire: "se rispettare il pensiero politico e religioso degli altri è fascismo; se rispettare la proprietà altrui è fascismo; io non sono fascista, ma nazista; perché io rispetto il pensiero degli altri come voglio che sia rispettato il mio; poi, per quanto riguarda il ventilato desiderio, di certe forze politiche, di disarmare le Forze dell'Ordine... io sono d'accordo...".
A questo punto bevvi un goccio d'acqua, la deglutii mentre guardavo la reazione dell'uditorio che apparve molto, molto sorpreso; ... deposi il bicchiere sul tavolo e aggiunsi: "sì sono d'accordo per il disarmo delle Forze dell'Ordine, ma a condizione che sia dato agli agenti un lanciafiamme!”.
Ci fu un applauso totale dei presenti che manifestarono gioia e solidarietà per quanto avevo detto.
Al mattino successivo, in un incontro nel Bar Centrale, in piazza del Plebiscito, ebbi il piacere di ricevere un ringraziamento da parte del Prefetto e dei rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Trascorsi il Natale tra l'affetto dei miei cari, ma al mattino del 26 dicembre il mio animo fu turbato da un fatto, che fece vasta eco nella città.
Verso le ore sette mi svegliai a causa di un certo brusio che proveniva dalla strada, mi affacciai e, con sommo stupore, vidi che sulla mia bellissima Volkswagen gialla avevano fatto, con la vernice nera, delle svastiche; per la precisione una sul cofano, una sulla parte posteriore, una sul tetto ed una per ogni sportello.
Non sto qui a dire cosa provai in quel momento, pensai subito al pericolo che potevo correre aprendo lo sportello perché pensavo ad una eventuale bomba innescata nell'auto.
Chiamai la Polizia la quale, al comando del dottor La Porta, venne con due volanti.
Il gentilissimo dottor La Porta mi chiese le chiavi per aprire gli sportelli dell'auto al che io mi rifiutai, perché volli aprirli io, perché non potevo pensare che, a causa mia lo stesso, subisse un danno.
Tutto si risolse nel senso migliore; i vigliacchi avversari si erano limitati a fare le svastiche.
Non per niente sconfitto presi l'auto, vistosamente verniciata, e andai a piazza delle Erbe dove parcheggiai l'auto e, a piedi, andai in via della Sapienza dove normalmente questi figli di "benefattrici da strada" sostavano, mentre intorno all'auto si erano fermate molte persone che condannarono la vile azione.
Notai un certo atteggiamento che tradì un paio di persone, ma logicamente non avendo le prove della colpa, mi limitati a dire, ad alta voce: "auguro a chi è stato di camminare sempre su strade larghe e non su strade strette, dove passo io perché, se passando, mi struscia, quella sarà l'occasione per rompergli il muso".
Soddisfatto, ritornai in piazza delle Erbe dove, davanti al forno Anselmi, avevo parcheggiato la mia auto.
Avvicinatomi alla macchina notai che, nel sedile anteriore era depositato un pacchetto confezionato con carta paglia; un brivido passò per il mio corpo, con circospezione detti uno sguardo intorno, come per avere assicurazioni sul da fare e con prudenza presi quel pacchetto e adagio, adagio lo aprii.
Ad un sospiro di sollievo fece seguito un sorriso; il pacchetto conteneva uno zampone di maiale, accompagnato da un biglietto con scritto: "Non è una bomba, auguri.... Ferruccio Ernesti".
Per un attimo l'azione dell'amico Ferruccio mi fece dimenticare l'accaduto e fece tornare il sorriso sul mio volto.
Ritornai a casa dove con l'ausilio di un mio amico carrozziere, riuscii a far sparire totalmente le svastiche dalla macchina; subito ritornai in piazza delle Erbe, dove molti concittadini si rallegrarono con me, mentre notai dello stupore sul "vile" volto di un noto "figlio di benefattrice".
Era il periodo che io definii: "quello delle innovazioni fiscali", della rivoluzione dei lavori che si effettuavano nel mio ufficio ed in tutti gli altri uffici tributari comunali d'Italia.
Erano stati aboliti molti tributi fra i quali l'imposta di famiglia, che dava il maggior gettito di imposta, il valore locativo. ed altri tributi minori.
Lo Stato avrebbe dato delle integrazioni atte a far funzionare i Comuni.
Ci mettemmo a lavorare di gran lena allo scopo di poter, sollecitamente, incassare quelle imposte che da anni giacevano, nei cassetti a causa dei ricorsi presentati dai contribuenti.
Sia la Commissione che il personale della Sezione Tributi erano sotto pressione.
Un giornale locale, il Corriere, diretto da Pietro Morelli, a caratteri cubitali, così scrisse in merito al mio ufficio: "Bravo Bruno Matteacci - Mentre intanto vengono alla luce lacune amministrative paurose al Comune, pratiche sparite oppure, per l'I.V.A.F., andate in prescrizione i componenti della Commissione di accertamento si sono resi conto che almeno Matteacci, Direttore delle imposte, avrebbe fatto il tutto per non far perdere delle somme da capogiro alla comunità".
"Con pignoleria avrebbe, molte volte, segnalato ai suoi superiori molte stranezze e discrepanze, specialmente in merito all'imposta di incremento sul valore delle aree fabbricabili".
"Inoltre, dopo aver assunto la carica di Direttore delle imposte comunali ha cercato in tutti i modi di recuperare delle somme ingenti" ...omissis... "Matteacci ha fatto un buon lavoro! Ha cercato in tutti i modi di non far perdere delle somme ingenti al Comune quando è andato a ricoprire la carica di Direttore delle imposte dirette (sic)".
"Con pazienza certosina ha tempestivamente segnalato alcune macroscopiche mancanze ai suoi superiori, oppure ha messo nero su bianco in alcuni casi clamorosi"...omissis...”. Nel predetto articolo veniva citato più volte il compianto Achille Poleggi, consigliere in rappresentanza della Lista Civica il quale, per me e molti altri, è stato un paladino della verità e dell'onestà.
Ciao Achille, anche se eravamo su posizioni opposte, fra noi due c'è sempre stata lealtà, amicizia disinteressata, stima ed affetto, in particolare quando mi rimproveravi ogni qualvolta mi vedevi con la sigaretta accesa in bocca.
Grazie Achille, anche tu hai contribuito a farmi smettere di fumare, te ne sono grato!
A fine anno, se avessi dovuto fare un consuntivo sulla mia vita in famiglia, in politica e nell'ufficio amministrativo, che dirigevo, i risultati non sarebbero stati cattivi, anche se qualche avvenimento mi aveva turbato.
La gioia, che mi faceva affrontare tutti i problemi che si facevano avanti, scaturiva dall'amore che avevo verso i miei figli, i quali crescevano bene, educati, affettuosi e, grazie a Dio, in salute; la cosa più importante ed essenziale.
Si avvicinava la data del 24 aprile 1974, venticinquesimo anniversario delle nozze di Vinicio e Bruna. Era giunto il momento di festeggiare le loro nozze d'argento; festa che tutti noi, fortemente, volemmo.
Alle ore 9,30 Bruna e Vinicio ritornarono nella chiesa di Santa Rosa dove, nel 1949, coronarono il loro sogno d'amore, poi via per un bel viaggio di nozze con il seguente itinerario: Viterbo, Sicilia e ritorno fino a Milano ed altre città del nord, con varie fermate, nelle più importanti città.
Per il 1974, con la mia famiglia, decidemmo di tornare in villeggiatura a Viareggio, più precisamente al Lido di Camaiore, dove trascorremmo delle magnifiche giornate in compagnia di Bruna, Vinicio, Mauro e Carlo, che stavano in roulotte con noi.
Che cosa si poteva pretendere di più? Nulla anche perché sono stato abituato a guardare, serenamente, avanti senza però dimenticarsi di dare, ogni tanto, uno sguardo indietro.
Era il periodo che mio suocero, il caro signor Enrico Egidi, era malato; a lui ero molto affezionato, lo meritava per la sua bontà, laboriosità ed onestà; ci volevamo bene!
Noi telefonavamo tutti i giorni per avere notizie sul suo stato di salute, da mia suocera venivamo continuamente rassicurati per il meglio, fino a quando mia sorella, rientrata a Viterbo per una indisposizione di Vinicio, ci fece sapere che mio suocero era gravissimo.
Dopo una breve consultazione con mia moglie partimmo immediatamente per Viterbo.
Facemmo appena in tempo a vedere il caro "babbo" Enrico, che ci riconobbe.
Ricordo, con dolore, che sul suo volto sofferente scese una lacrima. pochi attimi dopo Enrico ritornò alla Casa del Padre; era il 10 luglio 1974.
Quello fu uno dei primi dolori che provai nella vita; il "sor Enrico" lo conoscevo sin dal dopo guerra quando veniva, quale Agente delle II.CC., a riscuotere la tassa sul plateatico occupato dal chiosco dove mamma svolgeva l'attività commerciale.
A Natale del 1974, ricordo che i miei figli scrissero la seguente "letterina" ai nonni Giuseppe e Maria: "Caro nonno, il nostro cuoricino è pieno di affetto per te e per la nonna Maria. Chiediamo a Gesù Bambino di darci la gioia di potervi volere bene per tantissimi anni. Auguri. Patrizia e Giuseppe".
Fu un Natale diverso dagli altri.
Sotto il profilo villeggiatura l'anno successivo, 1975, andammo a Minturno dove facemmo amicizia con due famiglie di Roma e due famiglie francesi con le quali facemmo delle escursioni a Napoli e Capri; in quel periodo inaugurai il canotto che aveva una capienza per quattro persone.
Per l'anno 1976, mio padre ci prospettò di trascorre, insieme, qualche giorno a Gubbio, Pietralunga e zone limitrofe allo scopo di farmi conoscere meglio la zona dove lui nacque e trascorse la gioventù.
I miei genitori partirono, prima del 15 agosto, per Gubbio dove avrebbero soggiornato; mentre noi, con la roulotte, partimmo il 17 agosto perché il 16 piovve in una maniera veramente impressionante che ci sconsigliò di viaggiare.
Giungemmo a Pietralunga verso le ore 11 dello stesso giorno; fummo accolti con tanto affetto dai genitori e parenti che ci intrattennero a pranzo.
La mamma, con una certa circospezione, mi riferì che il babbo aveva sentito un piccolo formicolio alla mano sinistra.
La cosa non la lasciai cadere nel nulla, le dissi che ne avremmo riparlato l'indomani e che comunque doveva stare all'erta su ogni disturbo che il babbo accusava.
Durante la notte, mio figlio ebbe dei disturbi intestinali; al mattino con la roulotte, andammo a Gubbio, passando davanti alla abitazione della nonna; avvisammo del fatto i miei genitori e portammo Giuseppe da un medico che ci consigliò di tenerlo a dieta e di dargli le medicine, che ci prescrisse.
Visto però che Giuseppe non stava bene, con mia moglie decidemmo di partire per Viterbo, andando prima ad avvisare i miei genitori e salutare i parenti.
Giunti in via Tifernate trovammo che stavano ad aspettarci per il pranzo, ci invitarono a fermarci, cosa che facemmo in vista della partenza.
I miei genitori, saputo che volevamo rientrare a Viterbo, decisero di partire con noi.
Alle ore 18,30 circa arrivammo a Viterbo nella villa di mia sorella, a "Valle Cerasola". Giuseppe stava già meglio, noi più tranquilli; mentre il babbo, sulla base di quanto mi disse mamma, non aveva seri problemi.
Accompagnai mia moglie e i figli a casa, parcheggiai la roulotte; mentre nella mia testa ronzava, ancora, quanto mamma mi aveva detto, circa il formicolio della mano del babbo e il suo comportamento dentro la Basilica della Madonna di Canoscio, a Trestina dove, per molto tempo, rimase inginocchiato all'angolo destro del primo banco della fila sinistra, davanti alla sacra immagine della miracolosa Madonna del transito. Quel Santuario e quel particolare posto, mi ricordava qualcosa!
Dopo essermi consigliato con mamma e Bruna, tutti d'accordo, decidemmo di sottoporre il babbo a visita cardiologia.
Andai a La Quercia per telefonare a mio cugino, il dottor Roberto Guerra, noto e bravo cardiologo viterbese, al quale chiesi un appuntamento per accertare lo stato di salute del babbo.
Roberto mi disse di andare da lui, appena attaccata la cornetta del telefono, fece questo, non per impressionarmi, ma per dimostrarmi la sua disponibilità.
Presi la Volkswagen del babbo e andai, con la mamma, allo studio del dottore che stava al Corso Italia, sopra il Caffè Schenardi.
Dopo un'accurata visita il dottor Guerra disse che il babbo non aveva problemi cardiaci; comunque consigliava di stare all'erta e di avvisarlo, telefonicamente, per eventuali problemi.
Io, ebbi un attimo di esitazione pensando che nella villa, sita a "Valle Cerasola", saremmo stati isolati, per il fatto che si era senza telefono.
Chiesi al dottor Guerra se poteva farci avere, in ospedale, una camera ove poter ricoverare, in osservazione, il babbo e poterlo assistere il più possibile; la risposta fu affermativa.
Partimmo per andare a casa a prendere quanto necessario per il ricovero ma, giunti in via Marconi, bucammo la gomma posteriore sinistra dell'auto, facemmo pochi metri e giungemmo in piazza Giuseppe Verdi dove era il distributore di benzina del mio amico Silvano Bernardini, presso il quale cambiammo la gomma.
Avvisammo il resto della famiglia, della decisione presa, assicurandoli che il ricovero era solo una cautela.
Sul far della sera, ci presentammo in ospedale, il babbo fu sottoposto a visita medica e collegato ad una strumentazione idonea per accertamenti cardiaci.
Decidemmo di non lasciare il babbo, ad assisterlo c'erano mamma, Bruna ed io.
I giorni passavano, le condizioni del babbo non preoccupavano, dopo qualche giorno i medici mi dissero che avevano notato dei problemi urologici ai quali non detti alcuna importanza perché già conoscevo la situazione, erano problemi che avremmo affrontato successivamente, sotto il controllo del professore Dante Manfredi.
Giungemmo al 25 agosto 1976, verso l'imbrunire, venne mia moglie a trovare il babbo portandogli dei supplì, che furono molto graditi.
Tutto era per il meglio, passò la visita del primario, dottor Nicola Serra, con tutto il suo seguito, che ci rassicurò sulle condizioni di salute del babbo.
A tale proposito chiesi se potevo accompagnare mio padre a caccia, poiché la domenica successiva si apriva la stagione venatoria ed io avevo già ottenuto la promessa di un capanno nella riserva di caccia, offerto dall'amico Silvio Lazzari; dai medici mi fu dato parere favorevole.
Con il babbo mi fermai a parlare, del più e del meno; stavamo programmando gli ultimi ritocchi per trascorrere, insieme, la tanto attesa domenica.
Pregustavo già la gioia che avrebbe provato il babbo la domenica successiva.
Mamma, che stava con Bruna lungo il corridoio, si avvicinò alla porta nella camera con l'intenzione di entrare; io, desideroso di fumare una sigaretta, uscii cedendole la poltrona, dove ella si sedette recependo la volontà del babbo che le dette l'anello, che si era tolto dall'anulare destro, raccomandandosi che non lo perdesse.
In quel momento stavo nel corridoio e accesi una sigaretta; sentii un grido lacerante di mamma, gettai la sigaretta ed entrai. Vidi il babbo senza vita, gridai, gridai, chiesi aiuto, detti uno scossone alla mamma e mi misi a scuotere il babbo.
Giunsero medici ed infermieri con un defibrillatore, dettero scariche elettriche sul torace del babbo, ma non ci fu nulla da fare.
Tutto era finito!
Erano le ore 23,15 del 25 agosto 1976, avevo perduto colui che mi dette la vita, mio padre; avevo perduto il mio più caro amico, avevo perduto il mio maestro di vita, avevo perduto il nonno dei miei figli; mi sembrò di essere rimasto solo, con l'unica futura consolazione del "dopo la vita".
Non mi sembrava vero; chiesi ed ottenni la possibilità di trascorrere, le notti del 25 e del 26, in camera mortuaria con il babbo; non intesi lasciarlo solo, nemmeno per un attimo; non volevo credere a quello che era accaduto.
Il funerale fu celebrato da don Armando Marini, nel Santuario di Santa Rosa, Santa che la mia famiglia ha sempre amata e venerata; dove, successivamente, fu dato l'ultimo saluto terreno alla mia amata sorella e a mamma e dove, mi auguro, saluteranno me.
Mio padre, previdente, con mamma, si fece costruire una tomba nel cimitero di San Lazzaro, nel riquadro "D", dove ora riposa con vicino mamma, Bruna e Vinicio; in attesa del mio arrivo, quando Dio vorrà.
Il dolore della perdita del babbo mai mi ha abbandonato, vado tutti i giorni a fare una visita al cimitero, anche brevissima, come del resto facevo quando potevo gustare un suo sorriso, un abbraccio ed un bacio che ci teneva legati per tutta la giornata; in attesa di rivederci, alla sera, e di sentirci per la buona notte.
E' stata una prova dura, per tutti, la perdita fu grande ed ancora più dura fu per mamma alla quale, appena il babbo volò in cielo, le comunicai che lui aveva un grosso problema alla vescica.
A mente serena per il grande amore che avevamo ed ho per il babbo, ringraziammo Iddio per avercelo dato; anche alla luce di quanto mi disse, quando volevo portarlo, nuovamente, a Roma per un successivo intervento chirurgico.
Ricordo che stavamo nel suo laboratorio artigiano, in via della Pace 81; alla mia richiesta di andare a Roma, rimase un attimo silenzioso, poi iniziò a sudare; la fronte era imperlata di goccioline di sudore, si passò una mano sulla fronte e disse: "cocco... non mi parlare più di andare a Roma, solo a pensarci mi sento male e sudo, guarda”, mi mostrò la mano bagnata continuando a dire: "ringrazio Dio per essere arrivato a 70 anni, ho visto i figli sposati, ho visto e amato i miei nipoti: Mauro, Carlo, Patrizia e Giuseppe, vogliatevi bene, come tu hai sempre voluto a tua madre a tua sorella e alla tua famiglia; vivete la vostra vita".
Quel discorso mi distrusse, ma la vita, come diceva il babbo, va vissuta. Sì la vita va vissuta nel perenne ricordo di chi ci ha preceduti e spianato la strada, certo che si muore quando si è dimenticati, quindi, io aggiungo: "miei cari voi vivrete sempre con me, perché mai, mai vi dimenticherò".
Erano appena trascorsi ventuno giorni dalla data del decesso di mio padre, noi, per isolarci dalle affettuose manifestazioni che ci venivano fatte da amici e conoscenti, ci appartammo nella villa di Vinicio e Bruna.
Verso le ore venti e trenta, del 16 settembre 1976, vidi lampeggiare, nelle vicinanze di casa, una luce azzurra verso la quale mi diressi; era una macchina del Comune di Viterbo con la scritta Polizia Municipale, dentro la quale erano due Vigili Urbani che domandarono se avevo un parente, con il nome Luigi Matteacci.
Alla mia risposta affermativa, fui invitato a salire in macchina, appena seduto sul sedile anteriore destro, via radio, sentii dire: "lo avete trovato il ragionier Matteacci? Se sì, lo avete informato?". Un brivido attraversò il mio corpo, pensai a qualche discussione che potrebbe aver avuto mio cugino, anche se sapevo essere una persona tranquilla e buona. Avvisai del fatto i miei familiari, partimmo per ignota destinazione con mamma e Bruna che ci seguivano con l'auto Simca.
Strada facendo venni a conoscenza che mi veniva richiesto il nulla-osta affinché la figlia di mio cugino, Rita Matteacci, fosse trattenuta a Viterbo nell'Ospedale civile per le dovute cure conseguenti ad un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti pure il padre e la figlia maggiore Donatella.
Giungemmo all'ospedale Grande degli Infermi di Viterbo dove erano già stati avvisati del mio arrivo, mentre non comprendevo il motivo per il quale dovevo essere io a dare il nulla-osta per un problema di mia nipote e dei suoi genitori.
Parlai con il professore Francesco Masini, primario di chirurgia ortopedica, il quale mi rassicurò che avrebbe seguito, il più possibile, mia nipote Rita in tutta la sua degenza a Viterbo. Io ignoravo quello che poi seppi quando giunsi all'ospedale di Montefiascone dove trovai molta confusione e i cadaveri di mio cugino Luigi (12/1/1938 -16/09/76) e della figlia Donatella (31/3/1969-16/09/1976) deceduti in seguito di un incidente stradale automobilistico avvenuto sulla Cassia, all'altezza della curva nei pressi del cimitero di Montefiascone.
Era accaduto che, mentre mio cugino, con le figlie, marciava a bordo della sua Fiat 500 in direzione Montefiascone, si scontrò con un camion "OM", con a bordo degli operai, della ditta Pavani di Vetralla che, dopo aver mangiato fave e bevuto vino a Bolsena, rientravano verso Viterbo e, poiché nell'abbordare una curva, non tennero rigorosamente la propria destra, investirono l'auto con i miei parenti. Questo grave incidente gettò, ulteriormente, nel profondo della disperazione tutti i famigliari, che già piangevano la dipartita del babbo.
Al nostro dolore si unì quello della cittadinanza di Montefiascone e di coloro che ci conoscevano.
Dopo le varie sventure accadute nell'anno 1976, la mia vita era stata rabbuiata e, grazie a Dio ed alla presenza, all'amore, all'affetto di don Armando Marini, nei miei confronti, la strada appariva meno ripida.
Dopo aver narrato brutti episodi voglio tentare di gettare, nel ricordo, un velo anche se trasparente, sul passato e guardare le cose belle che mi accaddero.
Nel mese di aprile del 76, dai miei genitori, ricevetti in dono l'appartamento che tuttora occupo e che volli iscriverlo al catasto a nome dei miei figli, certo di fare felici anche i donatari i quali apprezzarono il gesto e condivisero il fatto che per me mantenessi l'usufrutto del bene ricevuto.
Purtroppo il babbo fece appena in tempo a partecipare alla festa di inaugurazione e di accesso alla nuova casa di via Monte Nevoso n. 27 dove il 30 maggio 1976 facemmo il rinfresco in occasione della Prima Comunione di Patrizia.
Quella fu una giornata indimenticabile; Gesù, per la prima volta, entrò nel cuore di mia figlia; a tale proposito scegliemmo questa frase da scrivere sulla pergamena ricordo: "Oggi il Signore è sceso in me ed io l'ho pregato anche per voi".
Il pranzo lo facemmo a Bagnaia, nel ristorante "Biscetti", con il seguente menù: antipasto assortito, crostino /tortellini alla panna, fettuccine, agnolotti/vitella arrosto, funghi, piselli/ arrosto di: agnello-tacchina-arista/insalata mista/dolce-cortina /Vino bianco / spumanti secchi e dolci/fragole con gelato/caffè/liquori assorti.
Alla sera eravamo tutti più che contenti, fu una festa da non dimenticare e degna della bontà, della bellezza e della grazia di Patrizia, la mia adorata figlia.
Altro avvenimento dell'anno fu quello del 13 giugno relativo al "Concerto di danza", organizzato dall'Accademia di Danza Classica "Augusta Maywood", nel quale mia figlia partecipò, ballando nelle "Danse des guirlandes" di Gounod, nel teatro della Scuola Sottufficiali, sulla strada Cimina.
Lo spettacolo fu veramente da encomiare: bello nella sua presentazione, ottimo nei costumi, magnifico nella realizzazione. Vedere la mia creatura, Patrizia, che ballava magistralmente, fu per me un motivo d'orgoglio; la sua bellezza fisica, la sua bravura, la sua grazia nei movimenti, fecero di lei, l'attrazione del ballo in quella giornata.
Apparirà strano o eccessivo che un padre parli così della propria figlia?
A me non sembra né strano né eccessivo il "bello" è "bello" e riconoscerlo è doveroso.
Comunque la conclusione del mio dire è che ho due magnifici figli, che mi hanno dato quattro altrettanto magnifici, splendidi, nipoti: Federica, Daniela, Iacopo, con la speranza di poter avere, un giorno, una femminuccia che possa fare compagnia al fratellino.
Come avveniva da qualche anno, anche nel '76, in rappresentanza del Comune di Viterbo, andai a Viareggio al convegno dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italia).
Ricordo che ero molto depresso per la perdita del babbo e gli altri lutti, a tale proposito portai con me mio nipote Mauro, che fu un vero sostegno morale e materiale.
In quell'occasione erano anche gli assessori: Mario Paternesi, Domenico Mancinelli, Santo Di Gregorio. I consiglieri: Alessandro Bordoni, Giuseppe Capotondi, il segretario generale dottor Ardesino Micio, il ragioniere capo Silvio Trenta e altri rappresentanti di altre forze politiche.
La compagnia dei suddetti è stata sempre gradita, mai si parlò di politica; in dette occasioni, si era tutti per uno e uno per tutti. A me lasciavano l'organizzazione di tutto quanto era necessario per una buona riuscita della partecipazione del convegno.
Debbo riconoscere che erano tre giorni che trascorrevano veramente bene; non solo si apprendevano notizie utili, nell'interesse del Comune, ma si facevano conoscenze di personalità politiche ed amministrative, di disegni di legge, di giurisprudenza che erano utili, a titolo personale, per un migliore svolgimento del proprio lavoro.
Verso la metà del mese di ottobre ebbi il piacere e l'onore di conoscere l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro, Vice Presidente della Camera dei Deputati, poi Presidente della Repubblica, con il quale trascorsi una giornata, in occasione di un Triduo che organizzai nella Chiesa di Sant'Angelo, in onore della Beata Maria Droste zu Vischering, dell'ordine delle Suore del Buon Pastore.
Ricordo che in quell'occasione ordinai, al ristorante "Il Pollo d'oro", una cena fredda che consumammo, con le suore del convento, in un salone dell'Istituto Buon Pastore.
Con l'onorevole Scalfaro, nei vari ritagli della giornata parlai, del più e del meno; l'onorevole volle sapere il perché portavo il lutto all'asola del vestito.
Saputo che avevo perduto il babbo, mi parlò del suo, mai cessato, dolore, per la scomparsa dell'amata moglie.
In quell'occasione rinverdii i rapporti che ebbi con l'onorevole Scalfaro, quando faceva capo al gruppo politico, della Democrazia Cristiana, "Il Centro" ricordandogli che furono sottoscritti, anche per volontà dell'onorevole Attilio Jozzelli, numerosi abbonamenti al giornale "Il Centro", da lui diretto, sul quale scriveva anche il professore Lucifredi, che era stato autore di testi di scuola, sui quali avevo studiato diritto privato.
In data 28 ottobre 1976 il Presidente Scalfaro, su carta intestata della Camera dei Deputati, mi scrisse quanto segue: "Caro Matteacci, non ho dimenticato né la bella serata dalle Suore del Buon Pastore, né la sua cordialità così aperta, generosa, affettuosa e commovente. Voglio dirle ancora il grazie più vivo perché la sua capacità umana mi ha fatto bene all'anima; grazie di cuore. Le unisco la preghiera di Sant'Agostino, di cui le parlai e le auguro il conforto che la Madonna, che è Mamma, sa dare. Con affetto Scalfaro".
"Se mi ami non piangere!".
"Se conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo; se potessi vedere e sentire quello che io sento e vedo in questi orizzonti, senza fine e in questa luce, che tutto investe e penetra; non piangeresti se mi ami!
Sono ormai assorbita dall'incanto di Dio, dalle Sue espressioni di sconfinata bellezza, le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto!
Mi è rimasto l'affetto per te, una tenerezza che non hai mai conosciuto!
Ci siamo amati e conosciuti nel tempo: ma tutto era allora così fugace e limitato!
Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi, tu pensami così; nelle tue battaglie pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte e dove ci disseteremo, insieme, nel trasporto più duro e più intenso, alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore.
Non piangere più, se veramente mi ami!".
Questa preghiera, per la quale ringrazierò sempre il carissimo ed illustre amico onorevole Oscar Luigi Scalfaro, fece breccia nel mio cuore e mi fu veramente di conforto, come lo è stato per coloro che, nell'arco degli anni, mio tramite, hanno avuto copia della stessa.
Le parole dei miei cari, la preghiera inviatami, l'amore dei famigliari erano di gran conforto, ma la perdita di un congiunto, come il babbo, è difficile, se non impossibile ad essere messa in un cantoncino della memoria o in un angolino del cuore.
Il dolore è grande, la mancanza materiale è immensa; anche se delle volte viene la certezza che la persona che ci ha lasciato è vicina, sembra più vicina di quanto non lo sia stata durante la vita.
Questo aiuta a vivere e a rafforzare il concetto che "si muore quando si è dimenticati".
Ecco perché nel grande dolore di aver perduto: babbo, sorella e mamma, delle volte,
sento la loro presenza che mi rasserena e che, nelle miserie terrene, mi spinge ad andare, giornalmente, anche per un solo salutino ed una preghiera, a trovarli nell'ultima dimora terrena, al cimitero San Lazzaro di Viterbo.
Il conforto lo trovo nelle mie preghiere; il mio primo ed ultimo pensiero del giorno è per i miei cari. Mi sento a loro vicino; loro sono vivi in me sì; sono convinto che stanno vicino ai miei nipoti e ai miei figli, che occupano ogni spazio del mio cuore!
E' dura la vita, anche perché tanti valori sono scomparsi.
Quando mai avrei potuto affrontare la notte senza aver sentito la voce delle persone a me care, che vivevano non in famiglia, ma in altra abitazione?
Era una esigenza non solo mia, ma anche dei miei genitori e di mia sorella; sarà forse perché eravamo una famiglia molto legata, molto affiatata, eravamo uno per tutti e tutti per uno.
Non è retorica quanto scrivo, ma è un sentimento dell'animo, che ancora soffre per la grande perdita che, in questa valle di lacrime, mai sarà dimenticata anche se, grazie alla fede, è compresa, con lo sguardo fisso al domani, senza dubbio migliore.
Pochi giorni dopo il decesso di mio padre, nel chiamare mio figlio Giuseppe, provai un attimo di smarrimento e di gioia che mi dette la netta sensazione che mio padre era vivo.
Ringraziai e ringrazio tuttora il Signore per avermi ispirato, nel lontano 1962, di aver deciso, con la mia fidanzata Antonietta, divenuta poi mia moglie, di chiamare nostro figlio con il nome di mio padre perché, sono convinto, che egli continua a vivere: in me, in mio figlio e nei miei nipoti, come i miei avi hanno vissuto nel cuore del babbo e continuano a vivere in me.
I giorni trascorrevano normalmente, sia per quanto riguardava il lavoro, che per quanto riguardava la famiglia.
Patrizia aveva dieci anni, mentre Giuseppe ne aveva sei; entrambi avevano l'onere di frequentare la scuola e debbo dire la verità, erano tutti e due in gamba!
Patrizia frequentava la seconda classe dell'Istituto Tecnico "Paolo Savi" per ragionieri, mentre Giuseppe frequentava la seconda classe elementare perché, all'età di cinque anni, aveva frequentato, con profitto, la primina, nella Scuola della "Beata Angelina" in Piazza dell'Orticara.
Il 22 Aprile 1977, ricordo che nella pagina locale de "il Messaggero" apparve il seguente articolo: "Perché voleva rilevare dati sui redditi consigliere comunale minacciato da un funzionario”. "Un funzionario dell'Ufficio tasse avrebbe minacciato il consigliere comunale del P.C.I. Rino Grazini, il quale voleva vedere ed annotarsi dati relativi agli immobili denunciati ed accertati dal Comune per il 1973.
La grave denuncia è stata presentata dal Capogruppo consiliare del P.C.I., Oreste Massolo, in una lettera al Sindaco Rosati. Massolo chiede, a nome del Gruppo comunista, che siano resi noti gli estremi della norma giuridica che vieta la pubblicazione degli immobili denunciati ed accertati dal Comune per l'anno 1973 per l'imposta di famiglia".
Tale richiesta afferma Massolo, è motivata dal fatto che il 15 marzo un funzionario dell'Ufficio tasse faceva presente al consigliere Rino Grazini, che si era recato in tale ufficio per prendere visione ed appunti, che "nel caso in cui avesse diffuso notizie relative a gli elenchi, sarebbe incorso (addirittura!) in sanzioni penali".
Massolo continua: "Debbo anche segnalarle la pretesa, a mio parere illegittima, di richiedere al consigliere comunale una istanza in carta bollata per la visione di tali ruoli. Anche per questo episodio chiedo gli estremi delle norma giuridica che impone l'uso della carta bollata da parte di chi è membro dell'Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui dette norme non esistano richiamo la sua attenzione sulla necessità di impartire disposizioni al fine di evitare da parte dei funzionari affermazioni inesatte che generano dubbi ed incertezze e che non giovano al doveroso esercizio delle funzioni comunali. Il fatto, oltre che increscioso, ci sembra indubbiamente grave ed è per questo che sollecitiamo una risposta chiarificatrice del Sindaco Rosati, nella speranza che l'episodio possa essere ridimensionato".
Il funzionario in questione ero io,, solo che, come il solito, i fatti furono artatamente ingranditi e, probabilmente, volutamente resi d'opinione pubblica senza citare il mio nome. I fatti furono ben spiegati dal sottoscritto, per iscritto al Sindaco, il quale rese edotto Oreste Massolo e la questione ebbe fine.
Cosa accadde veramente? I ruoli dei tributi comunali sono atti pubblici, basta pensare che, una volta compilati, in ordine alfabetico ed in ordine decrescente d'imposta, gli stessi venivano pubblicati, per otto giorni, all'Albo Pretorio del Comune e, di ciò, se ne dava atto con pubblici manifesti, affissi nella città.
A norma del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n.1175, ciò che è pubblico per otto giorni, diventa "segreto" il giorno successivo e rimane tale fino alla nuova pubblicazione di ruoli suppletivi o di quelli generali dell'anno successivo. Cosa accadde veramente?
I termini per la presa visione dei ruoli, dei tributi comunali, erano già scaduti.
Si presentò, nel mio ufficio, il ragioniere Rino Grazini, mio amico, il quale chiese di prendere visione dei redditi, dichiarati da un cittadino, ai fini della imposta di famiglia.
La mia risposta fu negativa perché, come detto, i termini, per la pubblicazione dei ruoli dei tributi comunali, erano scaduti.
A questo punto il predetto consigliere comunale, manifestamente alterato, uscì dall'ufficio. Poco dopo mi telefonò il vice segretario del Comune, dottor Francesco Fioramanti, il quale mi chiese: "perché non ha consentito, a Rino Grazini, la visione dei ruoli della imposta di famiglia?".
La risposta fu: "Lei lo dovrebbe sapere che i termini, per la presa visione dei ruoli tributari, sono scaduti". A questo punto sentii che il dottor Fioramanti riferiva quanto dicevo; mentre il consigliere Grazini ribatteva dicendo: che lui non era un cittadino qualunque, ma un consigliere.
Il vice segretario manifestò la volontà di fare vedere i ruoli a Grazini, nella qualifica di amministratore; mi opposi dicendo che se così doveva essere volevo una domanda sottoscritta dall'interessato, che avrei acquisito agli atti.
Poco dopo venne il signor Grazini con un foglio in mano sul quale era scritto: "Il sottoscritto consigliere Rino Grazini chiede...". Appena letta la lettera, che, mi fu consegnata, replicai che non accettavo la richiesta se non completata con il termine "comunale". A tale proposito, al consigliere comunale Rino Grazini dissi : "Rino di quanto prendi atto puoi farne uso, citando il nome del contribuente e i cespiti che hanno determinato il reddito, solo in sede di Consiglio comunale e in seduta segreta.
Nel caso contrario, se si divulgasse, al di fuori di questa sede, quanto preso visione negli atti dell'Ufficio, potresti essere soggetto a procedimenti antipatici".
Siccome all'epoca "politica" si faceva a colazione, pranzo e cena, tutte le occasioni erano buone per tentare, da parte del P.C.I., di mettere in cattiva luce un funzionario democristiano in particolare, poi, se quel democristiano si chiamava Bruno Matteacci, che era una "forza traente nel Partito".
Comunque mai, mi sono fatto mettere i piedi sul corpo, ho sempre fatto il mio dovere, riconosciuto, soprattutto, da altre forze politiche di governo e dell'opposizione; in particolare dalla estrema sinistra rappresentata, magistralmente, ed onestamente dal consigliere Achille Poleggi; come quando disse che: "al Comune di Viterbo c'è la M buona dell'Ufficio tributi, con chiaro riferimento alla M, lettera iniziale di Matteacci.
Ricordo infatti che Poleggi diceva: "al Comune di Viterbo ci sono due M una buona e una cattiva.
Logicamente, almeno penso, che la bontà trovata in me dall'insegnante Achille Poleggi derivava, certamente, non dal mio operato politico, perché Achille, per valutare una persona, non guardava il partito di appartenenza o la tessera politica che aveva in testa; egli parlava nella sua qualifica di consigliere comunale; quindi, sicuramente, valutava la mia persona nella qualità di funzionario comunale.
Debbo dire che Achille Poleggi non aveva i peli sulla lingua, era una gran brava persona, che amava Viterbo e sempre si è battuto per il bene della città.
Comunque posso ben dire che, sia da destra, che da sinistra o partiti intermedi di centro, ho sempre avuto stima e manifestazioni di simpatia, ricambiata che, non lo nascondo, mi faceva molto piacere.
Maggiormente mi lusingavano gli apprezzamenti che potevano giungermi dal segretario generale che, nell'arco del mio servizio, ne ho veduti molti e con piacere li voglio ricordare, in ordine di periodo che sono stati al Comune di Viterbo: ragioniere Saveri, un signore sotto ogni punto di vista; dottor Calabro, preparato e giusto, dottor Cannavale, uomo di facile sorriso, benevolo, sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno; dottor Luigi Pacifici, persona buona, di poche parole, professionalmente preparatissimo, sempre disponibile a risolvere le problematiche esistenti; dottor Ardesino Micio, caro amico, ha sempre difeso il personale da eventuali giudizi azzardati di qualche appartenente a forze politiche che roteavano in Comune.
Preparatissimo, ad ogni domanda dava sempre una risposta, mai ti lasciava nell'incertezza per la soluzione di problemi che potevano sorgere in seno all'ufficio ed infine il dottor Angelo Calderone, il silenzio e d'oro!
Non da meno qualcosa voglio dire sui vice segretari che, per un verso o per l'altro, si sono succeduti o che hanno, operato in contemporanea: il dottor Francesco Fioramanti, mio conoscente da quando sua moglie, signora Biagi, mi fece scuola per un periodo molto limitato. Fioramanti era ed è come il pane nel senso di bontà!
Mentre per quanto riguarda l'altro vice segretario f.f., ai miei tempi, il dottor Mario Settembri, posso dire che mi è stato amico, anche perché ci conoscevamo da quando lavorava alle ACLI e all'Umberto I. Mario ha sempre cercato di salire il gradino vicino; saliva, si fermava, aspettava guardando al gradino superiore; con la certezza di giungere a quella mèta. In poche parole, giustamente ha pensato sempre di fare carriera, sempre più in alto.
Su tutti o quasi, ho detto qualcosa, mi auguro che non restino male nel leggere quanto ho scritto ma, se così fosse, dico a chi ha la fortuna di leggere, perché qualche illustre personaggio, da me citato, è in grazia di Dio: "Medita, medita, solo chi ha seminato buon seme, su buona terra, raccoglie buoni frutti"!
Nel 1977, grazie agli amici, onorevole Attilio Jozzelli e senatore Onio Della Porta, con il "Pendolino" delle Ferrovie dello Stato, ebbi modo di andare a Parigi con la mia famiglia e quella di mio nipote, Mauro Galeotti.
Fu una bella esperienza, vissuta con i nostri figli, che ci ricordò la precedente visita fatta, a Parigi nell'anno 1966, in occasione delle nozze.
A tale proposito ricordo che, alla stazione Termini, conobbi il signor Mario Grasso che ci lasciò in custodia una valigia, che seppi, poi, contenere tanto denaro dell'Ambasciata italiana a Parigi.
La sua conoscenza ci fece poi molto comodo perché dopo pochi giorni di permanenza a Parigi avemmo una difficoltà, che ci parve insormontabile, per il cambio di moneta perché, oltre ad un bella somma in franchi francesi avevamo solo moneta da cinquantamila e da venticinquemila che non ci vennero cambiati in franchi, ma, grazie a lui, tutto si risolse nel miglior modo possibile.
Ricordo che trascorremmo un paio di serate, a cena, in sua compagnia.
I bei momenti durano poco; importante, anche nella brevità, è viverli intensamente; ritornammo a casa con un bagaglio di esperienza vissuta a Parigi con le nostre famiglie. Sono stati momenti veramente indimenticabili.
Rientrato a Viterbo la mia passione ed amore per i cani fu offuscata da un avvenimento che mi addolorò molto.
Voglio raccontare l'episodio che aumentò, maggiormente, il mio attaccamento ai cani, facendomi riflettere sulla differenza tra la manifestazione d'affetto, ricevuta da un cane, e quella fatta da certe persone!
Venni a conoscenza che al mattatoio comunale di Viterbo venivano portati i cani randagi, accalappiati nella città perché privi di museruola.
Mi telefonarono in ufficio per dirmi che al mattatoio erano sei cani, in attesa di essere abbattuti perché da nessuno rivendicati. Era prassi che, dopo cinque giorni, se nessuno rivendicava la proprietà del cane, lo stesso venisse abbattuto con un colpo di pistola a chiodo alla testa, che lo stordiva, ma non lo uccideva e gettato, a volte ancora vivo, in una fossa, esistente dentro al mattatoio, per poi essere bruciato nell'inceneritore.
Questo fatto mi turbò molto, pensai di salvare queste povere bestiole; il solo mezzo per farlo era mettere le mani nel portafogli, pagare il loro riscatto, custodirli e trovare qualche amico che si accollasse l'onere del mantenimento, in cambio dell'affetto e dell'amore che un cane può dare e, credetemi, ne dà tanto!
Grazie all'amico Sergio Fiorentini e alla signora Angela Maria Bacchi, ebbi la disponibilità di un pezzo di terreno, in località Rinaldone, ove facemmo un box per ospitare, provvisoriamente, i cani.
Per il vitto non avevo problemi, con l'amichevole collaborazione di gestori di ristoranti o addirittura con gli avanzi della mensa della Scuola Allievi Sottufficiali, ero in grado di mantenere molti cani.
Il problema prioritario era che l'ufficio sanitario del Comune di Viterbo pretendeva la somma di lire 5.000, di riscatto, per ogni cane.
Spendere lire, sottraendole alla famiglia, era un impegno che scomodava le mie tasche.
Contestai la pretesa del Comune perché, le 5.000 lire, erano comprensive di lire 3.000 di contravvenzione per abbandono dell'animale e lire 2.000 per il vitto dato al cane, nei cinque giorni di "prigionia".
Sostenni, ed ebbi ragione, che la somma di lire 3.000 non doveva far carico a me, che riscattavo l'animale, non mio; ma la somma la doveva pagare il proprietario nel momento che rientrava in possesso del cane, che non aveva ben custodito.
Altro problema, che sollevai, fu quello relativo al pagamento di lire 2.000, pretese per il mantenimento dell'animale il quale, nel periodo che stava al mattatoio, veniva invece alimentato con carne di risulta dalla mattazione di animali, causando agli stessi delle gravi forme di dissenteria; quindi ritenni non dover pagare nemmeno tale somma.
Pretesi ed ottenni di pagare solo lire 2.000 per ogni cane, con obbligo per il Comune che li alimentasse con appositi prodotti per cani, acquistati al pubblico commercio.
Un giorno riscattai sei cani fra i quali: un pastore tedesco, un cane bianco da pastore, che chiamai il "cane che ride", che regalai al dottor Francesco Fioramanti; un boxer, un segugio e due meticci, di cui una femmina in calore.
Ricordo che li caricai sul mio Volkswagen giallo ma, mentre li portavo al Rinaldone, stante l'agitazione che c'era a causa della presenza della femmina in calore, il cane boxer, ricevette un morso all'orecchio e mi sfuggì, lasciando il collare attaccato alla corda con la quale lo avevo assicurato nel sedile posteriore dell'auto.
Il boxer fu successivamente veduto, girare per Viterbo, dal dottor Giancarlo Pistoletti, ufficiale sanitario del Comune di Viterbo, il quale mi chiamò al telefono, per dirmi che non era corretto che io riscattassi un cane per poi riabbandonarlo.
Dopo aver dato le dovute spiegazioni di come si erano svolti i fatti, venni a conoscenza che il cane aveva il collare; quindi voleva dire che la bestia era ritornata a casa e che il proprietario gli aveva messo un nuovo collare, perché l'altro era rimasto attaccato nella mia macchina.
Quello di salvare i cani, da sicura morte, fu per me un'azione che rasserenò il mio tanto provato animo e ciò mi dava una certa serenità.
Il giorno che la stampa italiana diffuse la notizia di un cane pastore napoletano che sbranò un demolitore d'auto, io passeggiavo con mia moglie e i bambini quando, scendendo da via Cavour, vidi un cane boxer attraversare piazza del Plebiscito.
Riconosciuto, con certezza, che quello era il cane che io avevo salvato da sicura morte, accelerai il cammino e, appena giunto davanti all'ottico De Santis, gridai il solito richiamo per cani: "bello tie', tie', vieni qui".
Fu un solo attimo, il cane, sentito il richiamò si girò, mi riconobbe e, facendomi le feste, preso lo slancio e si gettò verso di me, battendo il suo freddo naso contro il mio occhio destro.
Ciò creò un attimo di terrore in quelle persone che assistettero alla scena influenzati, sicuramente, dalla notizia apparsa sui quotidiani.
Nell'ottobre del 1977 mia sorella aveva un mal di denti ed un persistente dolore alla testa, la facemmo visitare dal dottor Vittorio Cristi, noto medico chirurgo odontoiatra di Viterbo, il quale chiese una ortopantografia, che fu fatta dal professore Luigi Ciarpaglini il quale, nel momento che guardò la lastra, riproducente il cranio e dopo aver veduto una osteoporosi nella parte destra del cranio, mi mise un dubbio, un atroce dubbio.
Fu un momento tremendo della mia vita, non sto qui a raccontare quanto ci volevamo bene con Bruna posso, con un sola parola, dire che Bruna era in me come io ero in lei.
Fra noi esisteva un amore passionale, non c'è stata cosa che io abbia mangiato senza che lo abbia fatto assaggiare anche a lei e viceversa; fra noi non esistevano segreti, lo stato di benessere di uno faceva felice l'altro, mai tra noi c'è stato un attimo di invidia o gelosia, si viveva con la gioia di vedere l'altro o l'altra migliorare sotto ogni aspetto.
Sebbene solo tre anni ci dividevano, lei aveva un carattere protettivo nei miei confronti come, del resto, lo avevo io verso di lei.
Questo nostro reciproco amore era per i nostri genitori un viatico che faceva loro affrontare la morte serenamente; pensando che, in loro assenza, Bruna avrebbe guardato Bruno e viceversa, confermando la speranza che li indusse a chiamarci Bruna e Bruno.
Purtroppo l'uomo fa i programmi, ma una forza ignota, che chiamiamo destino, fa i fatti e, nel nostro caso, tutto finì nello sfacelo e nella disperazione.
Quanto seppi dal professore Ciarpaglini lo tenni, temporaneamente, nascosto perché eravamo alla vigilia dell'incontro che avrebbe fatto Bruna e Vinicio con Stefania e i suoi genitori, che vennero appositamente da Milano per conoscere i genitori del fidanzato della figlia, Carlo.
Bruna, angelo mio, differì di qualche giorno la ventilata estrazione dell'incisivo perché, il giorno 4 novembre, si doveva incontrare con la famiglia Rossi Mel e poi, tutti insieme, saremmo andati a Roma, per fare una visita alla Basilica di San Pietro.
Quel giorno mentre, a bordo della mia auto, andavamo a Roma, a Porta Romana, vidi il cane boxer il quale, riconosciutomi, ci seguì fino alla caserma della S.A.S. sulla Cimina. Il suo comportamento mi indusse a ritornare a Viterbo perché avevo capito che il "fedele amico" mi avrebbe seguito, non so per quanto, ma comunque avrebbe fatto uno sforzo che non avrei tollerato.
Ritornai a Viterbo, il boxer mi seguì fino a piazza Fontana Grande; mentre esso, povera bestia, si fermò a bere nella fontana posta ai piedi della monumentale fontana del Sepale io, con una brusca accelerata, imboccai via delle Fabbriche, facendo perdere le mie tracce continuando il viaggio per Roma, con i miei cari e i signori Rossi Mel.
Giunti a Roma, con nel cuore quanto sapevo a carico di Bruna, tutto mi appariva triste, l'unico pensiero che mi aiutava ad andare avanti era la speranza che, quanto detto dal radiologo, fosse stato solo un errore.
Con l'animo affranto mi misi a pregare, chiedendo al Signore che mi tendesse la mano per aiutare mia sorella.
Successivamente facemmo una visita sulla cupola di San Pietro mentre mamma, addolorata più del solito, rimase in chiesa a pregare.
C'è da dire che io, da tempo, soffrivo di claustrofobia; disturbo che si manifestò, per la prima volta, in occasione di un lavaggio dell'auto del babbo, che feci, in compagnia di mio nipote Carlo, da Silvano Bernardini, in piazza Verdi, allorquando rimanemmo chiusi dentro l'auto.
Quel giorno del novembre 1977 mentre, a piedi, salivamo verso la cupola di San Pietro ebbi una manifestazione di claustrofobia che mi indusse ad allungare il passo allo scopo di avere più spazio tra me e chi mi seguiva, che erano i signori Rossi Mel.
Mi mancava l'aria, faticavo a respirare, avevo fame d' aria. Mi misi a correre con la speranza di giungere, quanto prima, al vertice della cupola e poter quindi respirare più aria possibile e sentire il vento sul volto; intanto mi preoccupavo per i miei figli. Correndo, gridai verso mia moglie: "Antonietta pensa ai figli, pensa ai figli!".
A quel punto la vicenda assunse un tono comico.
Correvo, i milanesi mi seguivano, gridavo loro di starmi lontano, invece erano sempre più vicini e l'aria mi mancava sempre di più, fino a quando, grazie a Dio, vidi la luce del sole; ero giunto sulla sommità della cupola, con i milanesi che, con la lingua di fuori, mi attorniarono.
Che cosa era successo? I milanesi, non sapendo del mio stato di salute e sentendo la mia invocazione relativa al controllo dei figli, pensarono che io avessi intenzione di farla finita, togliendomi la vita.
Tutto fu chiarito, la visita a San Pietro si concluse per tutti, in maniera brillante e felice, mentre avevo il cuore a pezzi, essendo l'unico che sapeva e che aveva dubbi sullo stato di salute di Bruna.
Appena passato l'entusiasmo dell'incontro con Stefania e famiglia, il tema più importante, per le nostre famiglie, fu quello di accertare le condizioni di salute di Bruna che ricoverammo all'Ospedale Grande di Viterbo, nel reparto chirurgia, diretto dall'amico professor Giuseppe Capotosti, il quale prese molto a cuore il caso.
Gli accertamenti furono effettuati con sollecitudine e, guardando il volto dell'amico Capotosti, capii che c'era qualcosa di brutto, che lui si preoccupava di non dire.
Sia ben chiaro: ogni mossa, ogni decisione, ogni provvedimento, riguardante Bruna venne preso di concerto con il marito Vinicio, i figli, mamma e me; tutti uniti nel dolore e nell'amore verso Bruna; come siamo, sempre, stati nella vita.
Dai discorsi del professore Capotosti apparve, con certezza, che c'era necessità di trasferire mia sorella, a Roma, all'Ospedale San Filippo Neri, dove erano i noti medici, di origine viterbese, professori Fausto Bruni e Vincenzo Catalano, marito quest'ultimo di una ex compagna di scuola di Bruna, la signora Rispoli.
Il primo problema che ci si presentò fu quello di non far capire a mia sorella la gravità della situazione.
A tale proposito escogitai, d'accordo con i miei famigliari ed il professore Capotosti, un espediente per superare la nostra preoccupazione.
In presenza di Bruna, chiesi all'amico Capotosti di farle delle radiografie, cosa che, appositamente, non sarebbero state fatte.
Intanto il problema apparve, doppiamente, drammatico; alla mia richiesta, telefonica, di ricovero, mi fu risposto che al San Filippo Neri non c'erano posti disponibili.
Il mondo mi crollò addosso, disperato telefonai al presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giulio Andreotti, lo informai della gravità della situazione, pregandolo di farmi trovare un letto per mia sorella.
Verso le ore 12 mia moglie ricevette una telefonata, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale veniva comunicato che alle ore 17,30 saremmo dovuti essere al San Filippo Neri dove era ad attenderci il dottor Ioni, che era stato interessato del problema.
Nel primo pomeriggio, dopo aver contattato, telefonicamente, il professore Capotosti e concordato il da fare, andai da Bruna, la trovai nei pressi della stanza.
Al professor Capotosti, in presenza di mia sorella, chiesi il risultato delle radiografie; egli mi rispose dicendo che si era dimenticato di dare le dovute disposizioni del caso.
Io, che già sapevo la risposta, perché era stato tutto concordato allo scopo di non far capire a mia sorella la gravità delle sue condizioni di salute, feci la sceneggiata con la quale chiesi di dimettere dall'Ospedale di Viterbo, mia sorella e portarla in un ospedale dove potevo avere maggiori garanzie.
A questo punto, con tono volutamente alterato, chiesi a Bruna il suo parere, che venne sollecitato, nel senso da noi voluto, da Vinicio e figli.
Alle 15,30 con l'ambulanza, dove presi posto io e la mamma, partimmo per Roma seguiti da Vinicio e figli; alle ore 17 circa, giungemmo al San Filippo Neri, dove era ad attenderci il dottor Ioni che, molto caramente, ci ricevette e ci introdusse nel reparto.
Il primo medico, che si presentò fu il professor Catalano, il quale presentò, al personale del reparto, Bruna come sua cugina.
Nel ricordare, analiticamente, tutti questi episodi, mi sento male anche se l'amore per mia sorella non è mai venuto meno e mai sarà dimenticata nelle mie preghiere.
Per far capire, a chi leggerà questo scritto, quanto mi ha voluto bene mia sorella, voglio trascrivere una mia poesia nella quale il motivo ispiratore della stessa, scaturì dalla frase, detta da Bruna, che è poi il titolo della poesia:
"TUTTO A ME, NIENTE A LUI"
Tu che leggi questo titolo penserai:
avida è la persona che lo pronunciò.
Avida non fu, se non per l'amore
che provò per Suo fratello.
Tu adorata Bruna
che per me eri terra, sole e luna,
qui con mamma mi hai lasciato,
nel dolore che mai sarà pacato!
Tutto a me, Ella disse:
riguardo ai mali;
niente a lui Ella disse,
riguardo ai mali.
Tu, mio primo ed ultimo bel pensiero,
con il Babbo sei andata.
io con Mamma e i cari miei,
qui resto, pensando che con Dio sei.
Nell'amore terreno, visse
invocando per gli altri il bene,
e, nel terrore dell'altrui male,
per sé invocò anche il cattivo male.
forse più di noi fortunata
perché la felicità eterna l'hai già trovata.
La degenza di mia sorella, al San Filippo Neri, fu breve perché fu accertata la gravità delle condizioni di salute; pertanto fu trasferita all'Ospedale Sant'Andrea, diretto dal professore Fìcari, originario di Montefiascone, molto amico di Andreotti, presso il quale il presidente stesso, sovente, si interessava per conoscere lo stato di salute di Bruna.
Mia sorella, che era una donna di notevole intelligenza, stava molto all'erta affinché noi, presi dal dolore, non ci fossimo fatti distrarre da "venditori di fumo" e da "promesse di guarigioni" a titolo oneroso.
Ricordo che il giorno che portammo Bruna all'Ospedale Sant'Andrea, sito sulla Cassia, prima di entrare, volle scendere per leggere quanto era scritto sulla targa posta all'ingresso dell'ospedale. Accertatasi che si trattava di una struttura sanitaria, facente parte degli Ospedali Riuniti di Roma, accettò di essere ricoverata.
Non voglio parlare di sacrifici o di altro, se non di manifestazioni d'amore, che tutti noi avemmo verso la nostra amata congiunta, perché tutto era meritato e dovuto.
Certo è che, colei che, in prima persona le è stata molto vicina fu la mamma, la quale si fermò a Roma, nell'abitazione degli zii Anna e Vittorio Burla i quali, unitamente agli zii Ida ed Adamo Cecchetti, residenti a Roma Montemario, stavano molto vicini a Bruna.
Tutti i giorni, da Viterbo, c'era qualcuno di noi che andava a trovare Bruna, il nostro grande amore, che un giorno mi chiese di poter parlare con il nostro padre spirituale, don Armando Marini.
Poiché dovevo portare dei donatori di sangue per mia sorella, fra i quali il geometra Bruno Bruni e altri, che non ricordo, approfittai, per accompagnare don Armando da mia sorella.
Prima di andare da Bruna, ci fermammo per donare il sangue, ricordo che, quando entrammo nel laboratorio trasfusionale, la prima domanda che mi fecero fu quella di conoscere il gruppo del sangue che avevo portato.
La risposta fu spontanea: "Vi ho portato tre donatori, che hanno il gruppo sanguigno A Rh+, che lascio alla banca del sangue, in cambio di quello che serve per mia sorella". A questo punto mi fu risposto che volevano il sangue appartenente al gruppo 0 Rh-, che era il gruppo sanguigno di Bruna, molto difficile a trovarsi.
Con noi era, come già scritto, don Armando il quale, nel sentir la richiesta fatta, in un batter di ciglio si sbottonò la lunga serie di bottoni della talare, porgendo il braccio per donare il sangue da donare a mia sorella.
Tentai, energicamente, di non consentire tale donazione, perché don Armando era stato poco bene e donare il sangue gli poteva essere fatale.
Chi ha conosciuto don Armando Marini può capire che l'altruismo, per quell'uomo, per quel prete, era pasto giornaliero; a nulla valsero le mie affettuose sollecitazioni, don Armando, il caro amato "fratello", volle donare il suo prezioso e raro sangue a mia sorella.
Dopo aver offerto una sostanziosa colazione, andammo da Bruna, che ci fece una cara accoglienza; rimanendo poi, per un poco di tempo, sola con don Armando.
Sul tardi rientrammo a Viterbo, certi di aver fatto felice Bruna che ci accompagnò con lo sguardo dalla finestra, fino all'uscita dal cancello della struttura ospedaliera.
I giorni trascorrevano nel dolore, eravamo impotenti di fronte a tale situazione, solo la fede e l'amore verso Dio ci aiutava a continuare il difficile ed incerto cammino.
Tanti, tantissimi piccoli e grandi ricordi affollano la mia mente, tutti mirati a far rivivere, in me, quegli attimi trascorsi con Bruna, ma ritengo doveroso e rispettoso, per il dolore dei figli, mio e delle persone che le hanno voluto bene, terminare qui, ricordando che mia sorella, il 29 marzo 1978, alla giovane età di 45 anni, dopo aver ricevuto, da don Armando i Sacramenti, è tornata alla Casa del Padre, mentre ci scambiavamo un bacio. L'ultimo bel bacio della mia amata sorella.
Grazie all'affetto ed all'interessamento della reverendissima, Suor Maria Primetta Cavalleri (02/04/1912-02/09/1986), superiora delle suore di Santa Rosa, le onoranze funebri furono fatte, nel Santuario di Santa Rosa, da don Armando Marini il quale nell'omelia disse tra l'altro: "Bruna in questa chiesa ha fatto la Santa Cresima; il 24 aprile 1949, qui si è unita in matrimonio con Vinicio; il 24 aprile 1974 qui, è tornata per festeggiare le Nozze d'Argento ed oggi, 31 marzo 1978, è qui con noi per darci il suo ultimo saluto terreno, certo che continuerà a guardarci dal cielo amandoci, come ci ha amato sulla terra. Bruna sapeva il male che aveva e, nel dirmelo, si raccomandò di tenerlo nascosto ai suoi familiari". Oggi Bruna riposa vicino al babbo, come ella desiderava; successivamente è stata sopraggiunta dalla mamma e da Vinicio.
Una cosa è certa, con la morte di mia sorella mi sono sentito solo; l'unico conforto fu la mia famiglia e mamma, solide basi per continuare a vivere!
Nel primo semestre del 1978 entrai nell'ottica di cambiare auto facendo una permuta, da Zelindo Ferrazzani, concessionario della Volkswagen, cedetti il mio "Maggiolone", al posto di un Volkswagen "K70" targato VT 98000. Il motivo che mi spronò a fare il cambio derivava dal fatto che il Volkswagen "K70" era un tre volumi, con il motore collocato davanti, quindi più idoneo a trainare la roulotte.
Quell'anno, in compagnia delle famiglie di Angelo Pitocco e Giorgio Ventre, di Roma, andammo in ferie a Minturno nel campeggio "Golden Garden".
Mamma aveva amiche di famiglia che giornalmente l'andavano a trovare ed io ero con lei, continuamente, in contatto telefonico.
Tutto il resto, in famiglia, procedeva nella normalità e nella gioia di avere due figli come i miei, erano veramente due gioielli che mi davano soddisfazioni su soddisfazioni.
L'anno successivo, con il Volkswagen "K70", sempre in compagnia dei romani, andammo in villeggiatura in Calabria, a Praia a Mare, dove ci fermammo nel campeggio "Internazionale". Della nostra permanenza in detto campeggio voglio ricordare un episodio che oggi farà senza dubbio sorridere, ma che in quel momento mi terrorizzò.
Premetto che non so nuotare, sebbene il mare mi piaccia moltissimo, ma un trauma, subìto negli anni dell'infanzia, mi ha lasciato il terrore dell'acqua. Tutto accadde quando stavo sul lago di Bolsena, in un canotto di gomma, con amici che si misero a dare delle spinte in modo che qualcuno, contro la propria volontà, cadesse in acqua; tra un movimento e l'altro il canotto si capovolse.
Per un attimo io sparii dallo sguardo degli amici che credettero fossi sotto il canotto, poco dopo si accorsero che non c'ero, allora si preoccuparono e mi trovarono, svenuto nel fondo del lago.
Da quel giorno non ho più avuto il piacere di nuotare, anche se sapevo stare appena a galla; però da padre ho sentito la necessità di far fare a miei figli, corsi di nuoto allo scopo di evitare, nella loro vita, paure ed incertezze nei momenti che, se Dio vorrà, potranno trascorrere sereni e felici.
Cosa accadde a Praia a Mare? Non c'è bisogno della mia testimonianza per riconoscere quanto è bello il mare in quella zona, anche se la spiaggia è priva di sabbia, come è possibile trovarla altrove, ma anche la ghiaia è bella, poi, quello che è nuovo è bello.
Giungemmo sulla spiaggia muniti di tutti i comfort necessari, canotto gigante, scarpette di gomma, occhiali, boccagli per la respirazione sott'acqua, racchette da ping pong, palette e secchielli, materassini, ombrellone e asciugamani di ogni tipo.
Mi sentivo veramente soddisfatto; i miei figli sapevano nuotare, quindi non correvano pericoli. Io, con il mio boccaglio, allungato di una quindicina di centimetri, mi misi in acqua ed iniziai a nuotare sott'acqua, si perché sotto l'acqua io sono capace di nuotare, ma appena tento di emergere mettendo la testa a filo d'acqua, per vedere l'orizzonte, vado a picco, come un mattone. Fatti pochi metri, mi accorsi di trovarmi in un punto in cui sotto di me c'era una grande quantità di acqua. Tranquillamente mi spostai, ma notai, vicino a me, delle gambe femminili, erano quelle di mia moglie e delle sue amiche romane. Allo scopo di evitare il contatto mi spostai senza rendermi conto della direzione presa.
Una bracciata dopo l'altra, mentre gettavo uno sguardo alla bellezza della profondità del mare, mi portò in un punto nel quale non sapevo più orientarmi per andare a riva.
Intanto il tempo trascorreva, erano già oltre venti minuti che ero sott'acqua; la paura si faceva sentire, ma la forza della sopravvivenza era in me, soprattutto aiutato dalla preghiera, si perché, mi misi a pregare.
Nuotavo, nuotavo senza sapere dove andavo, sapevo solo che se tiravo la testa al di fuori della superficie dell'acqua, sicuramente, sarei colato a picco. Dopo, molto tempo ebbi il piacere di vedere le gambe di un bambino dentro una ciambella di gomma; capii allora che ero in prossimità della terra ferma, due bracciate ancora, mentre il freddo si era impossessato del mio corpo, raggiunsi la spiaggia dove trovai mia moglie con le sua amiche che, da lontano, seguivano il segnale del mio boccaglio domandandosi il perché, per oltre quaranta minuti, io fossi stato sempre sott'acqua.
Fu difficile, in quel momento, spiegare ciò che mi era capitato, perché ero molto terrorizzato; passata la paura, tra una risata e l'altra, bevemmo dell'ottimo vino.
La seconda volta, che andammo in Calabria fu nel,1981; ero proprietario del Mercedes 200, bianco, targato VT 90655, solo che ci spostammo leggermente più a Sud, nel campeggio "La Mantinera", occupando il box n. 537; era un campeggio da sogno.
Da quei luoghi facemmo delle escursioni in tutte le zone limitrofe, tutti luoghi che sono rimasti nel mio cuore, sia per le bellezze naturali, che per i contatti presi con i campeggiatori.
Siamo stati a Serra San Bruno, il merito lo devo ai miei figli i quali, nel momento in cui transitavamo nella zona, videro i segnali turistici che indicavano la strada per recarsi al Santuario di San Bruno, insistettero tanto affinché andassi al Santuario, cosa che feci con piacere.
Dopo che mio figlio ed io entrammo nell'Abbazia, nella quale l'ingresso era riservato ai soli uomini, perché interdetto alle donne, volli avere il piacere di scrivere una cartolina al mio amico Nicola Biagio Malerba, consigliere di Sezione, nativo di Serra San Bruno.
Mentre stavo scrivendo la cartolina, stando appoggiato ad una mensola sita a fianco di un chiosco, una signorina, con un indiscreto sguardo, vide che scrivevo a Nicola, la stessa, meravigliata, mi disse: "Lei sta scrivendo ad un mio parente che abita a Viterbo". Era proprio così, il mondo è veramente piccolo!
Terminata la visita, ci avviammo verso Praia a Mare. Ancora oggi, ringrazio Patrizia e Giuseppe dicendo loro: "Avevate ragione, se non vi avessi dato ascolto, non avrei avuto più occasione di andare da quelle parti. Grazie figli miei!".
Di quella giornata, voglio raccontare un piccolo fatto che mi fece e mi fa sorridere ogni qualvolta che ci penso. Si era fatto buio, noi, con l'allegria nel cuore per aver trascorso bei momenti, ci avvicinavamo a Praia a Mare, dove avevamo la roulotte, quando giunti ad Amantea, proprio ad un incrocio di rilevante afflusso di auto, la mia macchina si fermò.
Provai più volte a metterla in moto senza alcun risultato, intanto dalle auto, ferme per mia colpa, giungevano sollecitazioni con colpi di clacson; preso dal nervosismo scesi dall'auto aprendo, istintivamente, il cofano non sapendo dove mettere le mani; in quel momento, mentre giravo la chiave dell'accensione, mi sfuggì una imprecazione e, con grande stupore sentii riavviarsi il motore.
Tutto si risolse per il verso giusto, ma io avevo nell'animo un dolore per la frase, poco edificante, che avevo detta. Mi sentii in colpa e non intesi andare a letto con l'animo da peccatore, allora decisi di andare alla ricerca di un sacerdote. Nella bella Grotta della Madonna trovai un simpaticissimo frate, con il quale mi confessai, spiegando pure la causa di quanto avevo detto, forse per attenuare la gravità del fatto.
Quel santo frate, nel darmi l'assoluzione, disse: "Vede quanto è grande Dio, Lui pensa a tutto, se lei non avesse detto quello che ha detto, forse la macchina non si sarebbe messa in moto inasprendo, maggiormente, l'animo degli altri conduttori di auto che si vedevano bloccato l'incrocio; vede, con una sola parolaccia, il Signore ne ha fatte risparmiare tante!". Quella fu una nottata ed una confessione che è rimasta nel mio cuore, provai un senso di liberazione, seguito da un senso di benessere.
La nostra permanenza nel villaggio turistico "La Mantinera" fu veramente meravigliosa; in esso era una bellissima piscina, vari negozi e punti di ritrovo veramente accoglienti.
La spiaggia, riservata ai frequentatori del campeggio, stava a circa trecento metri, era raggiungibile con un simpatico trenino che tutto il giorno faceva la spola tra campeggio e spiaggia.
Debbo riconoscere che in Calabria, ogni qualvolta facevamo escursioni, ho trascorso bei momenti; andammo a Maratea, dove ammirammo, stupiti, la bellissima statua del Cristo; a Palinuro che, vista di notte, è un sogno; a Tropea, dove dormimmo in un bellissimo albergo e dove consumammo un ottimo pasto, sebbene piccante, ma a me piacque moltissimo, tutto è bello in quella zona.
Ricordo, con piacere, la chiesa della Madonna della Grotta che, come è immaginabile si trova in una grandissima grotta, in cui viene celebrata la Santa Messa. La Madonna è la protettrice dei pescatori, infatti, si narra che la stessa fu implorata da certi marinai che stavano per inabissarsi con la nave e, dalla stessa, furono salvati.
Nel periodo che, doverosamente, andavo in ferie non è che abbandonavo la mamma, anzi era lei che mi incitava a stare sereno e non preoccuparmi; cosa che io non ho mai accettato perché ritenevo e ritengo che un genitore deve essere sempre presente nel cuore e nella mente di un figlio; come del resto i figli, devono essere il centro della vita dei genitori, unico scopo di vita che, con il tempo, sarà poi affiancato dall'amore verso i nipoti, i figli dei tuoi figli.
Ringrazio Iddio, perché ho due figli che hanno lasciato un segno nella mia vita; un segno che è amore, rispetto, gioia, felicità e, mi sia consentito aggiungere, rimpianto se qualcosa non l'ho potuto dare o fare, oltre a quello che ho dato, fatto e dimostrato.
Comunque oggi, come ieri e, mi auguro, anche per il futuro i miei figli Patrizia e Giuseppe sono stati, sono e saranno lo scopo della mia vita, che vedo proiettata nel futuro tramite i miei bellissimi nipoti: Federica, Daniela e Iacopo; rispettivamente la "Regina", la "Principessa" e il "Re" della casa di nonno Bruno Matteacci.
Sotto il profilo scolastico, dai miei figli, ho avuto tante soddisfazioni; erano studiosi, veramente bravi.
Mai mi sono sottratto di seguirli durante il periodo scolastico; sono stato per anni rappresentante d'Istituto sia con Patrizia, che con Giuseppe; come del resto è stata la madre, che li ha sempre seguiti. Noi non ci siamo mai sottratti nel dare degli apporti di sostegno alle nostre creature, con qualche ripetizione; ricordo con piacere le volte che li accompagnavo, mi sembrava di rivivere la mia infanzia.
E' vero che un genitore non lascia nulla di intentato a favore dei figli.
La storia si ripete, ieri i miei genitori fecero tutto per me, come oggi noi abbiamo fatto tutto per i figli. E' una scala, se si semina bene, si raccoglie un buon frutto.
Auguri nipotini miei, sono certo che avete anche voi dei genitori degni di questo dono di Dio, amateli e pregate per loro.
Nella Democrazia Cristiana c'erano molte "correnti" che spaccarono il partito rendendo sempre più difficile parlare per un domani migliore, come parlarono i nostri predecessori, che presero l'Italia a brandelli, abitata da un popolo scoraggiato e deluso dall'esperienza del Ventennio fascista, che ci portò alla miseria ed alla fame.
In qualche sezione della Democrazia Cristiana non regnava più lo spirito d'amicizia politica, pur continuando a sentire la necessità di un abbraccio, di una stretta di mano; per qualcuno c'era solo sete di potere e qualunque mezzo, per raggiungerlo, costasse quel che costasse, era buono.
In data 30 gennaio 1975, nella mia veste di segretario della Sezione "Luigi Sturzo" di Viterbo, sentii il dovere di lanciare ai Democratici cristiani viterbesi un grido, più che un appello con una lettera, da me sottoscritta, dal titolo:
"UNITI NELLA D.C., PER ESSERE LIBERI E FORTI NEL PAESE".
"Nel passato si affermava che la Democrazia Cristiana stava unita solo perché c'era il pericolo comunista, che sfruttava questo, per mantenere il potere; che era un coacervo di gruppi e di 'correnti', che la sua presenza era giustificata solo perché faceva argine al comunismo.
Uno sguardo a ciò che l'Italia era e a ciò che l'Italia è oggi, fa capire, ai meno superficiali, che la Democrazia Cristiana rappresenta qualcosa di più.
Sì, la D.C. ha salvato, col voto i milioni di Italiani, il Paese dal comunismo.
Questo è già un grande merito che divide con le altre forze democratiche.
La nostra opposizione al comunismo è netta ed irrevocabile.
Non c'è possibilità di compromesso o di tregua nei suoi i confronti e nei confronti del P.C.I. che rappresenta oggi, come ieri, il maggior ostacolo al suo ordinato progresso economico, sociale e civile.
La Democrazia Cristiana deve isolarsi dagli estremismi di destra e di sinistra per evitare ogni radicalizzazione della vita politica italiana.
De Gasperi ebbe chiara visione della grande minaccia rappresentata dal comunismo, che isolò nel 1947 all'opposizione, ma ebbe anche una vigile ed acuta sensibilità per i pericoli che una valorizzazione dell'estrema destra poteva e può avere in Italia.
Tali pericoli sono reviviscenza, da un lato, delle tentazioni di fare posto ad un blocco conservatore-reazionario; dall'altro, possibilità al Partito Comunista di tessere la sua cinica trama frontista richiamandosi, ipocritamente, ai valori della Resistenza e all'antifascismo.
La Democrazia Cristiana deve rivedere le proprie posizioni!!
Il centrismo non è una formula; è una politica che si basa sulla interpretazione esatta della natura della Democrazia Cristiana, che è antitotalitaria ed interclassista; che rifiuta l'estremismo ed afferma la propria capacità, non di mediare meccanicamente gli opposti interessi, ma di comporli in una precisa e complessa visione dello Stato e dei diritti inalienabili della persona umana, che è al centro delle preoccupazioni degli obiettivi di ogni politica cristianamente ispirata.
Da questa modesta Sezione, la "Luigi Sturzo", parte un appello diretto a tutti i Dirigenti politici del Partito, un accorato appello con il quale si invita a rivedere le proprie posizioni interne ed esterne.
Nell'interno del Partito registriamo prese di posizioni e dichiarazioni veramente offensive alle orecchie dei Democratici cristiani che da anni si battono in ogni ambiente per evitare la sopravvivenza delle correnti.
E' di questi giorni l'appello, fatto dal nostro Segretario Onorevole Fanfani, per una ripresa della D.C.
Noi diciamo che le correnti del Partito non devono essere raffinati strumenti organizzativi, e quindi partiti nel Partito, ma solo veicolo delle idee, sforzo costante di tutti, secondo la propria convinzione e le solidarietà e le intese che così vanno configurandosi, per la ricerca della via migliore, della linea politica più idonea per far assolvere alla D.C. il proprio compito nella comunità nazionale.
E' ora di finirla di leggere frasi come quella scritta su un quotidiano del 30 u.s. e cioè: 'Le sinistre d.c. si preparano a passare all'opposizione', è ora di finirla di sentire le dichiarazioni dei vari De Mita, Donat Cattin che sembrano essere passati all'ala estrema, apparendo assertori del compromesso storico.
All'esterno, la Democrazia Cristiana deve rivedere le proprie posizioni; alla vigilia delle elezioni politiche del maggio 1972 ci presentammo all'Elettorato con un programma politico ben chiaro.
Nel Paese trovammo una straordinaria solidarietà, l'Elettorato rispose positivamente.
Il senso del presente appello non si limita al solo meccanico scioglimento delle correnti, ma per una presa di coscienza che ridia dignità, forza e capacità operativa alla Democrazia Cristiana, che rimetta in moto la dialettica interna, ma su temi attuali, sui temi ai quali gioca e si giocherà l'avvenire del Paese.
Questo è il senso del nostro appello ed è l'espressione della nostra profonda convinzione che, per il rilancio e la ripresa del Partito, necessita lo smantellamento totale delle 'correnti organizzate'.
Solo così potremo seguire la nostra via ed essere forti per restare liberi".
Questo "grido" ebbe vasta eco, molti segretari della Democrazia Cristiana della provincia di Viterbo, lo recepirono dandomi assensi con lettere e telefonate, per non dire poi la solidarietà che mi fu dimostrata in occasione di un incontro fatto al Comitato provinciale.
Intanto il mio lavoro al Comune, come responsabile del settore tributi, procedeva normalmente anche grazie al fattivo lavoro dei miei collaboratori che, ritengo superfluo, rinominare singolarmente, ma che ho di loro un caro, affettuoso, ricordo che mai dimenticherò.
Fra tanti ricordi, più o meno belli, ve ne sono alcuni che tornano alla mia mente per il solo fatto che come oggi, 1° marzo 2006, mi sono trovato, per caso, a passare in via del Gesù.
A tale proposito, nel ribadire che ho trascorso molto tempo con mia madre, senza togliere tempo, affetti o quant'altro alla mia famiglia, che ha sempre avuto un posto di privilegio nella mia maniera di vivere, sento ancora il desiderio di rivivere, ogni tanto, quei momenti di gioie e dolori che, con mamma, ho diviso.
I momenti belli che trascorrevo con mamma spesso si limitavano nel farle mangiare un buon gelato o a volte una pizza napoletana o quant'altro capivo che le era gradito e soprattutto, che non le facesse male alla salute; in poche parole non c'è stato cibo, fuori del normale, che non lo abbia fatto assaggiare a mamma e viceversa.
Un paio di volte all'anno mi prendevo la libertà di farle mangiare una discreta quantità di porchetta, che acquistavo nella norcineria Topi, sita in via San Lorenzo, nota per la superiore genuinità e qualità dei prodotti che vendeva.
Ricordo le occasioni, che normalmente rispettavo, per una buona mangiata di porchetta, che limitavo a due o tre all'anno e più precisamente: il 25 marzo, in occasione della fiera dell'Annunziata; il 1° maggio, nota giornata di scampagnata e il 4 settembre in occasione della festa di Santa Rosa, giornate che a Viterbo si tiene la cosiddetta fiera.
Il 25 marzo del 1982, epoca in cui avevo la Mercedes 2000, targata VT 90655, poco prima delle ore 11,30, con la mamma al mio fianco, mi avviai verso la norcineria di cui sopra ma, giunto in via Chigi, trovai la strada interrotta al traffico in direzione via San Lorenzo; l'unica soluzione era fare marcia indietro o svoltare a destra ed immettersi su via del Gesù per poi giungere in piazza del Gesù, in prossimità della tanto attesa e gradita porchetta.
Fu un attimo, con un colpo di sterzo giunsi all'inizio della via, pronto a continuare per gli altri circa cento metri.
Subito mi fu fatto notare dalla mamma che non sarei potuto passare nell'ultimo tratto della via perché ristringeva perché aveva una serie di paracarri posti ai lati.
All'arguta ed intelligente osservazione della mamma risposi: "Mammì non vi preoccupate ci passeremo pelo pelo, ma ci passiamo".
Continuai, sebbene notai una certa espressione di mamma che voleva dire sarà, ma ci credo poco.
Feci alcuni metri giungendo quasi all'uscita della viuzza, però ci fu il però.
L'auto, sul lato destro, strusciò la ruota, trovò l'ostacolo del paracarro bloccando il passaggio.
Notai subito lo stato di agitazione di mamma che, poverina, soffriva di claustrofobia ereditata dalla guerra, la quale non poteva nemmeno scendere perché gli sportelli non si potevano aprire, per la ristrettezza del vicolo.
La mia fu una decisione repentina, sentendomi colpevole della situazione, provvidi a tranquillizzare mamma e, inserita la prima marcia, con una affondata d'acceleratore l'auto, contemporaneamente ad un stridio di metallo, fece un sobbalzo e oltrepassò la strettoia giungendo in piazza del Gesù, da dove vidi il negozio di Topi, con la fumante porchetta, esposta sulla porta d'accesso del locale.
La prima cosa che dissi fu: "Mamma vi prego non scendete, sarà mia cura portarvi lo sfilatino con la porchetta, che mangeremo stando dentro alla macchina", dove avevo già depositato una bottiglietta di buon vino.
La mamma capì che non volevo farle vedere la macchina che era ammaccata sul lato destro; fu così cara che mi disse: "Bruno dividiamo le spese in due; tu paghi la porchetta ed io il carrozziere". Un sorriso ed un abbraccio pose fine alla questione; non ci poteva essere altro da aggiungere, l'importante era, stare insieme!
Certamente fui io a provvedere al tutto, anche se mamma non ha mai lesinato di farmi delle regalie, cosa che io ho sempre ostacolato perché le dicevo che doveva pensare al suo domani perché dietro all'angolo non sappiamo cosa troveremo.
Ricordo che, nella programmazione del futuro della famiglia; dividevamo l'anno in queste ricorrenze: Natale, Capodanno; marzo, compleanno e onomastico di Giuseppe e Patrizia, Pasqua, ferie, compleanno di Patrizia.
Non ci sono state ricorrenze che non siano state festeggiate, anche se, alla fine, c'è sempre chi si lamenta.
Intanto, inesorabilmente, giunse anche l'estate dell'anno 1982 che trascorremmo, con la nostra roulotte, a Civitanova Marche, più precisamente a Porto San Giorgio, nel campeggio "Spinnaker", in compagnia dei cognati Elisa e Domenico Tartarella e figlie.
Di quel periodo ricordo, con piacere, i giorni trascorsi a fianco dei miei figli che in occasione dei giochi che si effettuarono in loco, fecero parte della squadra che poi vinse il primo premio.
Si trattava di una caccia al tesoro con la gara finale, a conclusione della giornata del ferragosto, di mangiare nel minor tempo possibile trecento grammi di spaghetti che si dovevano cucinare, condire con ragù, secondo i propri gusti.
La straordinarietà della gara consisteva nel fatto che gli spaghetti si dovevano mangiare, con le mani legate dietro alle spalle, da tutti i componenti la squadra che potevano azzannare il cibo contenuto nel piatto.
Lascio intendere a che cosa si andava incontro; in poche parole sul piatto ci sarebbe stato uno sbavo a causa delle risate che, naturalmente, si facevano., anche se io sapevo che avrei dovuto dividere il tempo di "azzannamento spaghetti" con i miei figli Patrizia, Giuseppe e le mie nipoti Ivia e Anna Maria delle quali, logicamente, non mi schifavo, ma... il meglio e sempre meglio.
L'impedimento primo era il fatto che la mia squadra era composta da quattro bambini, oltre me, mentre le altre squadre erano, per la maggioranza, composte da adulti.
Secondo il regolamento, furono cotti trecento grammi di spaghetti e conditi con un ottimo ragù, cucinato individualmente da ogni concorrente.
I piatti furono messi su dei tavoli al centro del piazzale del campeggio dove intorno erano tutti i campeggiatori che facevano tifo per le loro squadre.
Considerai che ero in difficoltà perché i figli e i nipoti erano piccoli e timidi; a tale proposito, vedendo gli altri tutti agguerriti, chiesi alla giuria se potevo mangiare gli spaghetti da solo. La commissione chiese il parere degli altri concorrenti i quali, sicuri di vincere, accettarono che da solo, mangiassi i trecento grammi di spaghetti; certi che il risultato sarebbe stato a loro favorevole sia per la quantità di pasta, che avrei dovuto mangiare da solo, che per la celerità della competizione.
Ci legarono le mani dietro alle spalle, mentre un membro della giuria stava con il cronometro in mano e degli appositi incaricati tenevano fermo il piatto sul tavolo.
Al via mi chinai sul piatto e con una forte aspirazione, tipo mulinello, mangiai tutta la pasta nel termine di 73 secondi.
Fu un'esplosione di applausi con tanta incredulità dei miei rivali della spaghettata che erano convinti che io arrivassi ultimo perché dovevo, da solo, fare quello che altri facevano in cinque.
Debbo riconoscere che quella sera feci una pazzia, anche se, normalmente, sono sollecito nel mangiare perché non rispetto la regola che la prima digestione avviene in bocca, quindi necessitava una buona masticazione; funzione che, quella sera, non rispettai.
Il periodo in cui ero a Porto San Giorgio avevo i figli già grandi che potevano essere, come infatti sono stati, punti di riferimento in ogni manifestazione, in poche parole erano, oltre che una bella compagnia, anche degli ottimi collaboratori nelle faccende del campeggiatore.
Nell'aria si sentiva una velata stanchezza di effettuare le ferie con la roulotte, sentivo dire che fare le ferie, in simile modo, sembrava essere come dei gitani, questo mi demoralizzò.
Per non fare le solite discussioni anche, e soprattutto, perché non venivano poste alternative o contributi per migliorare il modo di trascorrere le ferie, bloccai la roulotte lasciandola legata al tronco di una pianta, nel cortile dell'officina di elettrauto degli amici Mario e Sergio Bernini, in via Tuscia.
Per l'anno 1983, programmai le ferie a Riccione, nell'Hotel Adelphi, di Giacomina Marini e Gianfranco Pagani in via D'Annunzio, n.151, sperando che certi umori si sbollissero.
Arrivò il momento di partire per la tanto attesa villeggiatura, facemmo un ottimo viaggio; giungemmo a Riccione l'ultima settimana di luglio, mi sembra il 22; occupammo due camere comunicanti, veramente comode e belle.
La spiaggia stava a pochi metri, era sufficiente attraversare la strada per trovarsi in una spiaggia incantevole, dove era una sabbia finissima, ottimi servizi, e non dico altro per quanto riguarda la familiarità dimostratami dai proprietari dell'albergo.
I ventitré giorni di ferie trascorsero velocemente, il 16 agosto ripartimmo per Viterbo notando un sottofondo di scontentezza, perché sentii dire che: "Stare in albergo sembrava essere in un collegio, dove tutto è programmato, con l'orologio in mano".
Certamente questa affermazione mi dette fastidio, ma visto che nulla poteva accontentare chi si lamentava, quasi quasi giunsi alla determinazione di dire basta; le vacanze, da oggi in poi si faranno a casa.
Non fu così; anche per l'anno successivo, a suo tempo, prenotammo lo stesso albergo per lo stesso periodo, a decorrere dal 28 luglio 1983.
Purtroppo spesso si programma senza fare i conti con l'oste.
In questo caso “l'oste" fu un fatale destino che il 27 luglio 1984 ci appiedò, totalmente a casa perché le nostre due autovetture, la Mercedes e la A 112 Junior, furono distrutte da un incendio.
Cosa accadde? Qui di seguito riporto l'attestazione numero 1100/84/Mobile, rilasciata dalla Questura di Viterbo, in data 28 luglio 1984:
"A richiesta dell'interessato e, per gli usi consentiti dalla legge si dichiara che stamani Matteacci Bruno, nato a Gubbio (PG) il 15/7/1936, qui residente in via Monte Nevoso n.27 ha qui denunziato che, alle ore 18,30 di ieri, la moglie Egidi Antonietta, nata a Viterbo il 3/10/1947, ha parcheggiato, chiusa a chiave, la propria autovettura "A 112 Junior" targata VT/200218, intestata alla stessa, nel cortile dello stabile della abitazione.
Alle ore 21,30 successive il Matteacci ha parcheggiato la sua autovettura Mercedes targata VT/90665, chiusa a chiave, a fianco, alla predetta vettura A 112. Alle ore 23,30 successive ha constatato che l'autovettura A 112 targata VT/200218 era in fiamme e le stesse avevano coinvolto la fiancata sinistra dell'autovettura Mercedes targata VT/90655. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio della vettura Mercedes mentre la vettura A 112 era completamente distrutta. La Mercedes ha riportato danni alla fiancata sinistra, alle ruote sinistre, all'abitacolo, poltrona, sedili, volante e cruscotto. Il predetto Matteacci ha dichiarato che i Vigili del Fuoco, oralmente, gli hanno comunicato che l'incendio in questione è dovuto a corto circuito dell'accensione. F.to p. il dirigente la Squadra Mobile”.
La stampa locale dette vasta eco al fatto mettendo in dubbio il motivo che causò l'incendio; in poche parole ci hanno "ricamato", ponendosi la domanda: "fatto politico o amministrativo, quale direttore delle tasse?".
Non capirono nulla perché i tecnici dei VV.FF. conclusero che il tutto accadde a causa di un corto circuito del motorino di avviamento della A112.
Il danno, all'inizio, non volevano risarcirlo totalmente perché fu accertato che la mia Mercedes fu incendiata dall'auto di mia moglie, quindi da una congiunta, pertanto la Compagnia di Assicurazione entrò nell'ottica di risarcire soltanto la proprietaria della A 112. Poi, a seguito della mia presa di posizione contro la compagnia assicuratrice, ebbi il risarcimento del danno totale anche della Mercedes.
Di quel triste episodio ricordo la gravità ed il pericolo che corsi.
Poiché dovevamo andare in ferie, lo stesso giorno, feci il pieno di benzina ed il pieno di gas perché la Mercedes aveva la doppia alimentazione.
Quando il signor Marcello Pasquali, mio condomino, si accorse dell'incendio dell'A 112, corse a spostare la sua autovettura, che era parcheggiata vicino alla mia Mercedes, poi mi citofonò avvisandomi dell'accaduto.
Corsi, inconsciamente, con l'intento di aprire lo sportello destro e prendere l'estintore, che era nel vano passeggero, ma Dio ha voluto che appena aperto lo sportello tutti i vetri dell'auto andassero in frantumi.
A quel punto ebbi paura e, confortato dal sibilo delle sirene dei VV.FF., che stavano sopraggiungendo, mi allontanai dall'autovettura stessa avvisando i Vigili che nel portabagagli era il serbatoio pieno di GPL.
I Vigili del Fuoco gettarono subito un flusso di schiumogeno contro il serbatoio allo scopo di evitare l'esplosione dello stesso.
In quell'occasione ebbi tante manifestazioni di solidarietà e di amicizia, sino al punto che ci furono quattro o cinque amici che si dichiararono disponibili a cedermi, in prestito, la loro autovettura per andare in ferie.
Vista la precarietà della situazione, invece di rinunciare alle ferie, accettai l'offerta optando per una station vagon e, con l'animo disteso, il 31 luglio 1984, partimmo per Riccione, dove ci fermammo per 15 giorni, che trascorremmo sereni, senza parlare mai dell'accaduto.
Appena ritornati a Viterbo acquistammo subito, dalla ditta Alberto Graziotti, concessionario della Lancia, una nuova auto A 112 per mia moglie; mentre mi misi alla ricerca dei pezzi di ricambio per la mia Mercedes, che necessitava di tutti i sedili, della tappezzeria, di due cerchioni con i relativi copertoni, del volante, del cruscotto e della verniciatura totale.
In poche parole il mio caro amico, Ludovico Stefanoni, noto e bravissimo carrozziere viterbese, mi disse: "Poiché il motore è in ottime condizioni e per la facilità di trovare i pezzi di ricambio, a buon mercato, è il caso di provvedere alla riparazione della Mercedes, più che alla sua rottamazione".
A tali condizioni detti disposizione per la riparazione del danno, visto pure che con il danaro dell'assicurazione ci rientravo bene nella spesa.
Trovai i sedili di vari colori, ma non mi preoccupava la diversità delle tinte perché avrei provveduto a ricoprirli, con le fodere.
Terminati i lavori di riparazione dell'autovettura, l'amico Stefanoni mi telefonò in ufficio per dirmi che Marietto, demolitore d'auto sulla Tuscanese, aveva un Mercedes con i sedili nuovissimi che si potevano acquistare con lire 100.000.
Pregai Ludovico di acquistare, a mio nome, i sedili e di metterli subito nella mia auto.
Non mi sembrava vero, riavevo la mia Mercedes, più bella di prima, con i sedili in pelle marrone che davano risalto ed una lucentezza di colore crema che veramente mi inorgogliva.
Ben preso, il triste episodio, passò nel dimenticatoio dei miei ricordi.
Il tempo fu galantuomo, correva velocemente, tutto era bello perché vedevo la mia amata Patrizia che aveva già compiuto diciassette anni, mentre Giuseppe, l'uomo di casa, si avvicinava ai quattordici anni e già fremeva per avere il suo primo motorino.
Per quanto riguardava l'acquisto del motorino, bisognava attendere il quattordicesimo anno, cioè il 19 marzo 1985.
Importante era però convincere la madre a dare il parere positivo per l'acquisto dello scooter; io ero favorevole, perché più volte avevo veduto Giuseppe su qualche motorino che di efficienza aveva solo il ricordo!
Giunse il tanto atteso quattordicesimo anno di Giuseppe; il giorno successivo, il 20 marzo 1985, avuto un mezzo sì da parte della madre, andammo ad acquistare il motorino, telaio n. 21207, da Marcucci, concessionario del "Master Rizzato". Facemmo più che felice Giuseppe ed io gioii, con lui, dopo averlo stordito con le raccomandazioni fattegli.
Sebbene la vita trascorresse serena, tra l'affetto dei famigliari, una nube oscurò il nostro vivere; Patrizia dovette essere ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico all'appendicite.
Furono momenti tremendi, ma grazie a Dio tutto si risolse per il meglio; i medici ci consigliarono di portarla, successivamente, in una località di mare dove poteva respirare jodio in abbondanza e trascorrere un meritato riposo ed una sana convalescenza.
Dopo una ricerca, in varie località balneari, scegliemmo di andare a Bordighera dove prenotammo un soggiorno all'albergo "Alpino".
Giunse il momento di partire; i risultati scolastici dei figli furono ottimi, il resto procedeva nella normalità, in poche parole Patrizia e Giuseppe sono stati sempre due bravi figli; so che dire ciò è riduttivo perché più di quanto ho avuto dalle mie creature, era impossibile averlo e, di questo, li ringrazio invocando Iddio, che li guardi e li accompagni sempre!
Partimmo, di buon mattino, con la "Mercedes", carica di vestiti e di quant'altro necessario, fino all'impossibile. Dopo un ottimo viaggio giungemmo a destinazione: l'albergo era di gradimento, la spiaggia scogliosa era vicina, il cibo ottimo e Montecarlo era a pochi chilometri; quindi era facile fare delle escursioni.
Dopo aver soggiornato per una quindicina di giorni a Bordighera e aver fatto escursioni a Mentone e Ventimiglia, l'occhio "clinico" di Giuseppe accertò che le ruote posteriori della Mercedes convergevano al centro e, con insistenza, me lo fece notare.
Anche se io non avevo mai fatto caso come dovevano essere orientate le ruote posteriori, doverosamente ascoltai il suggerimento di mio figlio andando in una officina meccanica dell'ACI per far vedere la macchina.
Il meccanico mi disse che non c'erano problemi, che potevo e dovevo stare tranquillo.
Il giorno che decidemmo di rientrare a Viterbo, facemmo il seguente programma, “al mattino a Montecarlo per fare una ricca colazione e per spendere qualche franco, poi verso Viareggio, dove pranzeremo nel ristorante "Lo Squalo", che già conosciamo; intanto telefoniamo, per dire che verso l'ora di cena saremo a Viterbo".
Caricata la macchina, con tutti i bagagli; pagato il conto e calcolato che avevamo ancora una buona scorta di danaro per affrontare il ritorno, andammo a Montecarlo dove facemmo una ottima colazione che, pur essendoci costata una discreta somma, ci rese soddisfatti e felici.
Facemmo il solito giro per vedere: le vetrine, l'eleganza dei negozi, la bellezza dei giardini; poi partimmo percorrendo l'autostrada in direzione Ventimiglia, ma giunti proprio all'altezza dell'uscita per Ventimiglia sentii che la gomma posteriore destra aveva ceduto; mi fermai in un distributore di benzina per far dare una gonfiata alla gomma e poi via di corsa per giungere nell'officina meccanica dell'ACI a Bordighera, dove già conoscevo il titolare, al quale chiesi di cambiare la camera d'aria della ruota posteriore, che era bucata.
Ricordo che, in quell'occasione, guardando con attenzione le ruote posteriori, forte dell'intelligente osservazione di Giuseppe domandai nuovamente, al meccanico, se il tutto era in regola. La risposta fu lapidaria: “Vada e, stia tranquillo".
Pagai quindicimila lire per la camera d'aria sostituita e partimmo ma, fatti appena duecento metri, sentii un grosso rumore e la Mercedes si mise a "sedere".
Scesi dalla macchina, percorsi quei pochi metri che mi dividevano dall'officina e chiamai il meccanico per fargli vedere quanto era accaduto, alla luce del "vada e, stia tranquillo".
La macchina fu rimorchiata con il carro attrezzi e portata nell'officina dove il meccanico sentenziò la rottura della corona, del semiasse e chi più ne ha più ne metta.
Domandai quanto tempo ci voleva per avere la macchina riparata e quanto sarebbe costata la riparazione.
La risposta fu traumatica, necessitavano quattro o cinque giorni di lavoro, per una spesa di circa tre milioni e cinquecentomila lire.
Facemmo i nostri calcoli, oltre alla spesa viva per la riparazione dell'autovettura ci dovevamo aggiungere la spesa per il soggiorno, in albergo, di quattro persone; tanto valeva lasciare la macchina a Bordighera e farla rottamare.
Poiché stava per arrivare il treno, che ci avrebbe condotto verso casa, pregai il titolare dell'officina ACI di trattenere la macchina in attesa di mie comunicazioni.
Detto e fatto, con tutti i bagagli, salimmo sul treno, per ritornare a Viterbo; facemmo tappa a Firenze dove mangiammo qualcosa, senza lasciarsi prendere dallo sgomento o da altre manifestazioni di sconforto.
Le ferie le avevamo fatte, avevamo trascorso dei bei momenti, i figli erano sereni e chi se ne fregava del resto? Arrivammo a Viterbo verso la mezzanotte, intanto già avevamo avvisato, senza spiegare i motivi, che saremmo giunti molto tardi.
Il mattino successivo, mentre andavo in ufficio in via Vicenza n. 69, all'altezza dell'ingresso, incontrai il carissimo amico Ludovico Stefanoni che si accorse che avevo qualche problema, mi domandò: "Bruno che ti è successo, ti vedo stralunato".
Era più che normale il mio stato fisico, la stanchezza si era impadronita del mio robusto fisico; gli spiegai l'accaduto.
Ludovico superò ogni straordinaria ipotesi; mi disse: "Non ti preoccupare, prendiamo il carro-attrezzi e andiamo a Bordighera a prendere la Mercedes".
La mia domanda, credo, fu più che logica, gli chiesi quanto mi sarebbe costato il viaggio. Ludovico mi sbalordì, disse: "Pagherai il gasolio e il pranzo".
Ricordo che comprai sigarette e caramelle e partimmo per Bordighera, dove giungemmo all'ora del pranzo, che consumammo in maniera spartana, con un piatto di spaghetti ed un contorno annaffiato da ottimo vino e dalla affettuosa amicizia dimostratami da Ludovico, verso il quale serbo un caloroso affetto e stima oltre ad un senso di gratitudine, che mai verrà meno.
All'occhio esperto di Ludovico il danno dell'autovettura si rappresentò di gran lunga inferiore a quello diagnosticato a Bordighera; si era piegato il ponte e, di conseguenza, si era rotto un semiasse.
Il tutto si poteva accertare nel momento in cui mio figlio Giuseppe mi fece notare che le ruote non erano parallele a terra ma, purtroppo, la madre degli imbecilli è sempre incinta ed io, di tali soggetti, ne trovai uno a Bordighera.
Ritornai a Viterbo con un animo sereno e pieno di speranza, ma giunto sull'uscio di casa fui avvisato che Giuseppe era caduto dal motorino e si era rotto i pantaloni; ciò tanto per darmi un senso di responsabilità perché io avevo caldeggiato l'acquisto del motorino. Accertato che Giuseppe stava in ottima salute, non detti tanta importanza alla caduta, certo che sarebbe stata, per mio figlio, lezione di vita.
Per quanto riguardò la mia autovettura, trovai un ponte seminuovo, dall'amico Bernardino De Carli, titolare della rottamazione d'auto in località "Poggino", che Stefanoni, molto magistralmente, sostituì a quello rotto. Riavevo la mia Mercedes.
Poco tempo dopo, per esigenze d'Ufficio dovetti andare a Bari per un Convegno sulla Finanza Locale. Del gruppo facevano parte gli amministratori: il professore Alessandro Bordoni, il professore Corrado Buzzi, il ragioniere Santo Di Gregorio, il dottor Rifredo Grassi, il ragioniere Domenico Mancinelli, il geometra Marcuccio Marcucci, il ragioniere capo Silvio Trenta ed il sottoscritto. In quell'occasione, per andare a Bari, non utilizzai la mia autovettura perché non ero tanto tranquillo sullo stato della stessa, infatti, fui ospite di Marcucci.
Ricordo che, appena giunto a Bari, mi preoccupai di cercare un mio carissimo ex commilitone, nella persona di Benito Vitali, con il quale feci il militare ad Orvieto.
Lo trovai e trascorsi con lui attimi nei quali rimembrammo bei momenti dei nostri vent'anni; altrettanti bei momenti li ho trascorsi con gli amici amministratori, che sono sempre stati affabili e soddisfatti di quanto organizzavo, nell'interesse di tutti.
Dopo il mio rientro a Viterbo, era nei primi giorni di ottobre, quindi prossimi al 10, data importante, non solo per mia figlia Patrizia, che diventava maggiorenne, ma importante per tutta la famiglia.
A tale proposito decidemmo di fare un bel pranzo nel ristorante "I due L", in via Cairoli, dove ebbi il piacere di brindare con il vino che avevo acquistato e conservato in occasione della vendemmia del 1967, anno di nascita di mia figlia.
In quell'occasione scrissi la poesia che appresso riporto:
"PATRIZIA 18 ANNI"
Cara nostra Patrizia
che con tanta bontà, amore,
gioia, orgoglio e letizia
hai allietato il nostro cuore
In questo magnifico giorno,
che tu hai 18 anni,
Ti stiamo tutti intorno
per augurarti altri cento anni,
E' una meta tanto agognata
potersi dire "maggiorenne",
ma tu lo sei sempre stata
anzi, potremmo dire che sei ventenne!
Figlia amata, continua così
sarai la gioia, come sei stata!
Lo sarai anche un dì
quando felice sarai maritata
Figlia adorata, volgi lo sguardo
sul domani e sul tuo avvenire.
Questo è il primo traguardo
altri più felici dovranno venire!
Noi tutti, con affetto e con amore
intorno a te oggi stiamo,
perché tu sei il nostro cuore
e tutti in coro ti diciamo
AUGURI! AUGURI!! AUGURI!!!
PATRIZIA NOSTRA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Quell'invito di mamma, di andare al "Mini Palace Hotel", mi sorprese e mi preoccupò in maniera tale che, con la massima sollecitudine, partii per recarmi in loco.
La distanza, tra la mia abitazione ed il luogo dove era la mamma, è breve; altrettanto breve fu il tempo impiegato per giungere sul posto, ma non furono brevi e lievi le preoccupazioni che si accavallarono nella mia mente. Vedevo tutto nero; mi domandai: "Vuoi vedere che mamma si è sentita male?". Invocai il Signore pregandolo di aiutarla. Appena giunto al termine di via Sabotino, nel piazzale antistante l'albergo, intravidi, dietro un' autovettura, la mamma che stava parlando con qualcuno.
Scattò il giallo del semaforo, ma io, stressato dalla tensione, passai ugualmente, non sapendo a che cosa stavo andando incontro. Giunto all'altezza della mamma, il suo bel volto si illuminò con un altrettanto bel sorriso.
Fu un attimo, l'agitazione, che fino a quel momento mi aveva invaso, si trasformò in un pianto al quale fece seguito un abbraccio con mamma ed un caloroso saluto ed una stretta di mano con l'amico Memmo Ferri, proprietario dell'albergo e concessionario della Mercedes.
Tutto fu chiarito da queste parole dette da mamma: "Senti cocco, la mamma ti vuole fare una nuova Mercedes. Visto quello che ti è capitato con l'incendio, considerato quanto ti è accaduto in ferie e, visto che sei andato a Bari, senza la tua Mercedes, sono convinta, che oggi, anche tu, non ti fidi più della tua macchina, quindi sono qui dal signor Ferri proprio per farti una nuova autovettura. Non mi dire di no; anche il babbo sarà contento!".
Non avevo la forza di parlare, l'unica cosa che feci fu quella di distaccarmi un poco da Ferri per dire a mamma: "O ma', ma voi vi rendete conto di quanto costa una Mercedes?".
Lei, candidamente, rispose: "Costerà quanto una macchina, che vuoi che sia!".
Premetto, qualora non lo abbia già fatto, che io mai, e poi mai, ho saputo la disponibilità economica della mamma al momento e prima, quella dei miei genitori.
Bruna ed io, mai abbiamo affrontato discorsi d'interessi, anzi li abbiamo sempre evitati, per noi, vedere i nostri genitori senza preoccupazioni era gioia e vita.
Quel giorno, nella concessionaria Mercedes, vista l'insistenza della mamma, dovetti farla riflettere, perché a me interessava un suo futuro tranquillo, in previsione di una mia, eventuale, dipartita terrena, che ho sempre veduta dietro l'angolo.
Chiesi all'amico Memmo il prezzo della Mercedes, che mamma guardava con insistenza; la risposta fu: "Sessanta milioni, senza accessori". La mamma, angelo mio, sbiancò in volto; si girò verso di me dicendo: "Ma la vita è diventata così tanto cara?".
Notai uno stato di dolore di mamma, come se si fosse veduta sconfitta in un suo programma, ma forte, come lo è sempre stata nella vita, anche in situazioni tragiche; soggiunse: "Di belle Mercedes ne vedo tante, non è che devi girare con una macchina con il prezzo attaccato sul parabrezza; importante che tu abbia una buona autovettura, sicura e di tuo gradimento".
Mentre mamma mi diceva queste cose, guardava con insistenza una bellissima auto "Mercedes 200 D, targata VT 148690, lasciata, in deposito per la vendita, dal signor Tullio Jacchia.
Era veramente una bella autovettura che, per fare felice mamma e me, l'acquistammo, lasciando in conto vendita la vecchia Mercedes, come da procura speciale, repertoriata dal notaio Luciano D'Alessandro in data 31 dicembre 1985, al numero 43339.
Notai subito una differenza fra le due autovetture perché la seconda, alimentata a gasolio, era molto lenta e quindi problematica nei sorpassi; comunque avevo una solida autovettura che mi avrebbe potuto dare garanzie per molto tempo.
Con mamma, non parlai di questa mia sensazione o problema, se poi problema lo si potesse chiamare.
La macchina, per molto tempo, mi ha dato tante soddisfazioni, sia per la sua bellezza che per la sua efficienza; in poche parole era sempre una bellissima “Mercedes", il nome dice tutto.
Tutto, procedeva per il meglio: salute, affetti, lavoro, solo nella Democrazia Cristiana si sentiva, almeno da parte mia, la necessità di dare un scossa alla base elettorale, ma ancor più agli accaparratori di posti di potere che erano pronti a fare alleanze politiche, che per anni erano state evitate, pur di raggiungere il "potere".
Approfittando del Congresso, che era in atto nella Democrazia Cristiana, convocai
l'Assemblea generale degli iscritti, estesa anche ai simpatizzanti della dottrina della Democrazia Cristiana.
I locali della Sezione, in quell'occasione, traboccavano di persone, erano venuti in molti, quasi la totalità, ma la cosa più gradita fu quella di vedere altri segretari di Sezione e vari personaggi politici, fra i quali ricordo, con simpatia, il senatore Onio Della Porta, il sindaco, il vice segretario provinciale e il segretario del Comitato comunale della D.C., vari assessori e consiglieri comunali.
Quale segretario politico della Sezione "L. Sturzo" di Viterbo, presi la parola e dissi:
"Mi sia consentito porgere un caro saluto a tutti voi dirigenti ed iscritti alla D.C. e, a nome di voi iscritti e della Direzione Sezionale, in particolare, porgo un caloroso saluto agli 'esterni' che sono presenti tra noi.
Per chi non fosse aggiornato informo che, a norma delle disposizioni centrali del Partito, quest'anno, e per il futuro, possono partecipare alle assemblee e votare anche coloro che non sono iscritti al Partito, ma che abbiano fatto formale richiesta di entrare nella vita politica sezionale, come elettori della D.C. e quindi aderenti al "Manifesto ideologico del nostro Partito".
Essendo candidato, in queste elezioni, nella lista che si richiama al presidente Giulio Andreotti, per motivi di correttezza, nella veste di Segretario del Partito, evito di fare un discorso di 'gruppo'. Avrei dovuto parlare sul tema del Congresso, visto dal gruppo Andreottiano, ma non lo faccio.
Da dietro a questo tavolo sono il segretario della Sezione "Luigi Sturzo" e, come tale mi corre l'obbligo di rappresentare tutti voi perché, in seno di elezioni sezionali, ebbi la fiducia di tutte le forze qui rappresentate e quindi, fedele a quella fiducia, dirò qualcosa a livello generale. Ci troviamo alle soglie del Congresso Nazionale del Partito e qui a Viterbo siamo in lizza con otto liste.
Ciò non ci deve apparire come divisione interna del Partito, ma come libertà che abbiamo di esprimere ognuno le nostre argomentazioni, tutte intese nel fare il bene della nostra Italia e del nostro Partito.
Quindi l'incontro, che noi abbiamo promosso, vuole essere un dibattito, un contributo dato al Partito in una fase d'intensa elaborazione delle sue tesi politiche, resa più urgente e più impegnativa; non soltanto dalla prossima scadenza congressuale, ma ancor più dalla necessità che di fronte alla molteplicità e complessità dei fermenti che ravvivano la società italiana e alla domanda politica, che ne deriva, corrisponda una risposta adeguata, una maggiore certezza del quadro politico, quale senso di sicurezza di cui il Paese ha bisogno per poter progredire e affrontare i gravi problemi che caratterizzano questa fase della sua vita.
Questi problemi non sono soltanto cose da fare, ma orientamenti ed indirizzi di fondo da definire affinché si abbiano delle certezze su cui contare.
Finora il discorso sul partito è stato "discorso di metodo": cioè vedere in che modo e con quali mezzi favorire la formazione di una maggioranza omogenea che consenta al Partito di esprimere una volontà sicura, capace di rappresentare, almeno essa, un punto di riferimento certo della situazione politica, superando il frammentarsi delle forze politiche da cui discende, inesorabilmente, l'inefficienza del sistema parlamentare.
Del resto la stessa contestazione, la posizione di coloro che mettono in discussione tutto intero il sistema, non trova forse una delle sue giustificazioni nella incapacità dei partiti politici, chiusi in sé e impegnati nella lotta fra i gruppi che li compongono, ad interpretare ciò che vi è obiettivamente giusto nella domanda, a volte confusamente espressa., del Paese; in particolare l'esigenza di rinnovamento e di maggiore e più feconda funzionalità del sistema?
Quando il discorso viene, opportunamente, portato sui problemi da affrontare, dev'essere chiaro dinanzi alla nostra coscienza.
Se le forze politiche, che devono animare e rendere operanti le istituzioni, sono prive di un chiaro indirizzo, di un'adeguata ricerca culturale, esse saranno carenti di soluzioni e soprattutto incapaci di costituire maggioranze in grado di guidarle con continuità ed unità di indirizzo
E' innanzitutto qui che sta la vera crisi del sistema, che bisogna curare, se non si vuole essere travolti o avere alla guida del Paese, come abbiamo, un laico.
Non dobbiamo dimenticare, come spesso capita, i principi di ispirazione del nostro Partito. Ricordate il contenuto del manifesto del gennaio 1982?
In esso era scritto che il Partito della D.C. è una forza politica di ispirazione cristiana che vuole restare fedele alla migliore tradizione spirituale, culturale e civile dell'Italia, fondamento della nostra identità nazionale.
L'insegnamento di don Luigi Sturzo è vasto e complesso. E' impossibile riassumerlo in pochi punti senza rischiare di sviarlo o di falsarlo.
Ma qui desidero sottolineare due preoccupazioni costanti del pensiero e dell'azione del grande Maestro, al quale abbiamo voluto intestare questa Sezione.
L'unità politica dei 'cattolici' ed il senso della libertà, come valore centrale dell'impegno dei 'cattolici in politica', sono due preoccupazioni che sono anche nostre; la loro attualità, mi sembra, è evidente.
Credo che le sorti della nostra democrazia possano correre, oggi, rischi mortali se i cattolici, uniti e concordi, nella loro piena autonomia in un operare ed efficace movimento politico, non operino per il rafforzamento e la difesa delle istituzioni
Il nostro Partito è il Partito da battere, tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, combattono la Democrazia Cristiana e noi dobbiamo essere sempre attenti perché già, per forza naturale, 'il potere logora', ma noi vogliamo fare nostra una battuta di Giulio Andreotti il quale, una volta, disse: 'il Potere logora chi non lo ha'.
La fiducia dei Cattolici italiani non ci è venuta meno e per questo chi è responsabile della cosa pubblica deve fare il tutto per non venire meno a questa fiducia accordatagli e noi, che in vari modi sosteniamo questo grande Partito, tutti uniti, dobbiamo operare per il meglio, sempre pronti a combattere per la nostra libertà e per quella dei nostri figli.
Non possiamo essere assenti alle vicende delle Polonia, del Salvador, dove i princìpi di libertà sono calpestati. Non dimentichiamo la famosa frase che dice: 'La libertà è come l'aria, non la si apprezza, ma quando manca si muore!'.
Quindi, ricollegandomi a Sturzo, voglio ricordarvi cosa scriveva sulla libertà: 'La libertà è come la verità; si conquista e, quando si è conquistata, per conservala, si riconquista e quando mutano gli, eventi e si evolvono gli istituti, per adottarla si riconquista'. Per noi è più facile: 'la liberta l'abbiamo e dobbiamo solo mantenerla, se necessario, combattere'.
La gioia e la passione di aver combattuto e di combattere; ieri, oggi e sempre, per la Democrazia Cristiana, sono riposte nell'animo di chi sà di essere, senza dubbio alcuno, libero da ogni sospetto.
Occorre: ritrovare noi stessi, ricercare i più fedeli, rimanere ancorati ai nostri principi, dobbiamo essere uniti!
E' necessario mostrare i denti e far sentire la nostra voce in ogni settore politico.
Dicevo che è necessario ricercare i fedeli, non per operare solo con loro, ma con loro cercare di allargare le nostre file; scoprire il gioco dei nostri avversari e recepire quello che c'è in loro di bene e farlo nostro per attuarlo nell'interesse della collettività.
Non possiamo dare al Popolo Italiano l'impressione d'essere deboli, stanchi, pronti ad abdicare. Questo è il mio appello!
Mi sia permesso, a questo punto, rivolgere una parola ai giovani; anche se spesso mi dimentico di non essere più giovane, ma l'entusiasmo è giovanile e il piacere di combattere non è mai venuto meno e, se avrò il vostro appoggio sarà, qualora ce ne fosse bisogno, nuova linfa per invogliarmi a fare di più e fare meglio.
Dicevo: 'Mi sia permesso di rivolgermi ai giovani' e, per 'giovani', non intendo solo coloro che hanno la fortuna di avere vent'anni o poco più, ma per giovani voglio intendere anche coloro che sono giovani di vita politica. Essi non sanno quante faticose tappe abbiamo dovuto raggiungere; quanti sacrifici abbiamo dovuto sopportare proprio perché, loro, trovassero una società più giusta, più sana.
Sentirsi rimproverare tutto, senza alcuna concessione, ci amareggia, ci disgusta!
Il linguaggio di molti giovani, se così espresso nelle forme e nei modi finora usati, non ci convince. I giovani vogliono: uomini nuovi, cose nuove; le stesse cose che abbiamo chiesto noi ai nostri "vecchi", quando eravamo giovani.
Solo che noi le chiedemmo sommessamente con il rispetto dovuto a chi aveva costruito un Paese nuovo, con religiosa coscienza; rispettosi del sistema democratico, certi che prima o poi le avremmo ottenute. Ma noi avevamo sofferto, avevamo vissuto una guerra di sangue e di orrori; noi, forse, eravamo più maturi, certo più affamati.
Il compito dei giovani è quello di essere parte attiva, viva, nel nostro Paese, ma non in posizione di aperta violenza, di sciocca ed intollerante arroganza.
Il compito dei giovani è quello di collaborare con noi alla ricerca dei metodi migliori, più giusti, più umani, per soddisfare, non solo, le loro esigenze, ma le esigenze del Paese che guarda a loro come futuri padri della Patria.
Non è possibile voler tutto, e tutto assieme; non vogliamo ricominciare a combattere per salvaguardare principi che ci sono costati sofferenze e privazioni.
E' invece possibile lavorare, lavorare e ancora lavorare all'interno e all'esterno del Partito.
I giovani dovranno migliorare la società, non per mero egoistico calcolo personale, ma per costruire una società più giusta, per fare in modo che i loro figli, i nostri nipoti, possano vivere in un mondo diverso, in un mondo cristiano; lontano quindi dalla violenza, dalla droga, dalle sopraffazioni.
Ecco dunque il loro compito, che fu già nostro, alla loro età.
Ciò non vuol dire che essi devono frenare la loro azione; si tratta solo di prendere coscienza della realtà in cui viviamo.
Noi chiediamo il loro aiuto, senza respingerli, in attesa che l'eredità, da noi accumulata, passi nelle loro mani pulite.
Analogo discorso lo facciamo alle donne, che in questi ultimi anni hanno dato dimostrazione di saper ben marciare a fianco dell'uomo e, lasciatemelo dire, più volte ci hanno dato dei punti, sia per prontezza, che per dinamismo.
Non per ultimo, uno sguardo ed un momento di riflessione lo dobbiamo rivolgere ai nostri Amministratori, nei vari consessi che, tra fatiche, lotte e sacrifici, riescono ancora a portare avanti il discorso della Democrazia Cristiana in momenti, veramente, difficili e con uomini che hanno sete di potere e spregiudicatezza politica.
Abbiamo situazioni veramente da capestro impostaci dal P.S.I. il quale fa la politica della 'convenienza' e cioè, dove gli conviene, pur di stare al potere, sta con la D.C. e, in altri Comuni o come la Provincia o nella Circoscrizione, fa maggioranza con il P.C.I.
E' ora di fare un discorso serio, noi diciamo che non possiamo più tollerare queste situazioni. Ci auspichiamo, quanto prima, il Congresso Comunale per il rinnovo del Comitato perché è scaduto e, lasciatemelo dire, è scadente e, nessuno più di me può fare questa osservazione proprio per il fatto che, di esso, ne faccio parte come Vice Segretario.
Le Assemblee, Cari Amici, dovrebbero essere convocate più spesso perché servono a scaricare quel malore che cova nei nostri animi, serve ad avere una carica di dinamismo. Sì è così, infatti quando si è parlato di organizzare questa Assemblea, ho affrontato l'organizzazione con stanchezza, con apatia; in poche parole non la sentivo Con il passare dei giorni, tra un adempimento e l'altro mi è venuto l'entusiasmo perché sapevo che oggi avrei avuto davanti a me un folto numero di Amici ai quali dovevo pur dire ciò che era nel mio animo.
Quest'oggi, sono soddisfatto perché, anche se ho perduto qualche ora di riposo, mi sono presentato davanti a voi con la speranza di vedere condiviso tutto, o in parte, quanto ho detto; che è frutto di un esame di coscienza e di una riflessione politica che mi porta a dire: 'Amici iscritti, Amici aderenti al 'manifesto', oggi dobbiamo eleggere i Delegati al Congresso; non ha importanza chi sarà eletto; l'essenziale è che colui che ci rappresenterà, ci rappresenti degnamente, perché a lui conferiamo il mandato di scegliere e votare uomini giusti, come giusti sono quelli che risulteranno eletti in questa votazione.
Dunque, concludendo: Avanti con la DEMOCRAZIA CRISTIANA, per il bene del Paese e dei nostri figli... VIVA LA D.C.".
Terminato il Congresso, fu per me come essermi tolto un grosso peso dallo stomaco.
A scrutinio ultimato la lista, da me capeggiata, che faceva riferimento all'onorevole Giulio Andreotti ebbe la maggioranza dei delegati sezionali al Congresso del Partito.
Quell'occasione fu una delle tante prove di "forza politica" che detti; pochi giorni dopo, forse per la tensione a cui mi ero sottoposto, ebbi un piccolo problema di salute, che mi spaventò.
Per fortuna e grazie ai miei genitori, che mi hanno cresciuto con l'amore verso Dio, sono riuscito, sempre, a sorpassare momenti difficili; anche il disturbo di quella volta fu catalogata nel blocco notes dei ricordi.
La medicina chiamata preghiera è veramente un tocca sana.
Ho sempre detto e continuerò a dirlo, a chi ha voglia di ascoltarmi, che nella vita non si deve pregare nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna e i Santi, solo quando si ha bisogno e necessità di un loro aiuto; ma se "si vuol essere ascoltati", bisogna pregare, sempre, sempre; sempre in ogni momento e in ogni luogo.
Potrai, così, costatare che non sarai solo, perché ti sentirai circondato d'amore; di quell'amore che sulla terra hai avuto dai tuoi genitori e che potrai continuare a sentire verso: i tuoi figli, e i figli dei tuoi figli; che sono coloro che, di te, un giorno parleranno, facendoti vivere nel ricordo.
Questo è bello perché, come ho già scritto: "Si vivrà, fino a quando qualcuno, con amore, ti ricorderà".
Mentre scrivo queste parole, sono le ore 18,31 del 21 marzo 2006; alle ore 18,00 ho avuto un forte dolore al petto a causa di una tachicardia, forse dovuta ad uno stato emozionale.
Ho sospeso di scrivere, sono corso a prendere una pasticca di "Carvasin sublinguale"; poi, mi sono sdraiato sopra una poltrona; mentre seri pensieri affollavano la mia mente stanca ed amareggiata.
Da un pensiero all'altro non ho dimenticato però quello verso nostro Signore Gesù, al quale ho detto: "Fai tu, Padre mio, Sei l'unico Medico a cui credo e, solo Tu puoi quel che vuoi".
Ora mi sento meglio anche se vivo sempre con la spada di Damocle sulla testa a causa del mio problema cardiaco; brutto argomento su cui ritornerò in un altro momento.
Non ho dimenticato che il mio adorato babbo ci lasciò a seguito di un infarto miocardico che lo colpì proprio il 25 agosto 1976 mentre era ricoverato, per accertamenti, nel reparto di cardiologia dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo.
Ho sospeso di scrivere, proprio a seguito del disturbo che ho avuto, in attesa di sentirmi meglio e di fare una "coronografia", come mi è stata richiesta dal professore Giovanni Casali, dell'Ospedale San Camillo di Roma.
Oggi, 25 Marzo 2006, compleanno di mia cara sorella Bruna, le dedico due parole di amore, come ce le siamo scambiate in vita; ma la cosa migliore è stata, senza dubbio, averle fatto celebrare, in memoria, una Santa Messa.
Tutto passa e, se l'animo è sereno, tutto è facile dimenticare; con la certezza che, coloro che non sono più sulla terra, sono in cielo; che ci stanno vicini, in attesa di un incontro che non avrà fine.
Questa è la "verità", per chi crede ed io, che credo, ho la certezza di una felice santa riunificazione con i miei cari, nell'amore... per l'eternità.
Per il momento, rimetto i piedi su questa amata terra, raccontando altri episodi.
Nell'arco della mia vita, nel periodo in cui, ero direttore dell'Ufficio tributi, mi si presentò l'occasione di sostituire un collega, malato, nell'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale della Circoscrizione. All'inizio fui titubante poi; visto che accettare significava pure fare una cortesia all'amico Ezio Silvestri, responsabile del settore decentramento del Comune di Viterbo: accettai.
Tale sostituzione doveva durare poche settimane, invece, con il trascorrere del tempo, furono apprezzate le mie doti, sino al punto che fui invitato a rimanere quale Segretario Comunale alla IV Circoscrizione Ellera-Paradiso.
Visto l'ambiente, che apparve subito molto cordiale, stante anche al fatto che presidente del Consiglio era l'amico Ferruccio cavalier Gatta, di buon grado, accettai.
Anche quella fu una bellissima esperienza, oltre al fatto che guadagnavo qualche lira in più, mi servì pure per allargare le mie conoscenze ed amicizie.
Per vari anni ho vissuto i problemi, non solo dei Democratici Cristiani della Sezione "Luigi Sturzo", ma di tutti coloro che si rivolgevano a me per la soluzione dei loro problemi, sotto il profilo della "casa", "amministrativo" e "sociale".
Con Ferruccio Gatta furono organizzate tante manifestazioni per il "Carnevale viterbese"; era un vulcano d'idee, lo si vedeva disegnare dei personaggi e dei carri come lo si vedeva, con il suo grembiule nero, materialmente, lavorare con tavole di compensato, carta, forbici, colla e pennello per la realizzazione di belle figure allegoriche.
Quando il carro di Ferruccio sfilava per le vie della Circoscrizione o della Città era una festa perché, lo stesso, era allietato da tanti figuranti che lo rendevano più vivo e bello.
Conservo, gelosamente, una targa con lo stemma del Comune di Viterbo, donatami da Ferruccio, quale presidente della IV Circoscrizione, con la seguente motivazione:
C O M U N E D I V I T E R B O
"CARNEVALE 1983"
"ALL'AMICO E COLLABORATORE Rag. BRUNO MATTEACCI".
Successivamente, la presidenza della Circoscrizione passò nelle mani di un giovane amico, il ragioniere Giancarlo Bandini, con il quale collaborai, fattivamente, con tanto affetto e amicizia, fino al 1995.
La Circoscrizione volle rilasciarmi un gradito riconoscimento, scolpito su un bel piatto d'ottone, che così recita:
COMUNE DI VITERBO-IV CIRCOSCRIZIONE
Viterbo 28 Maggio 1995
PREPARAZIONE PROFESSIONALE, ESPERIENZA, ONESTA', DIPLOMAZIA,
SAGGEZZA ED AMICIZIA. DOTI DEL Rag. BRUNO Cav. Uff. MATTEACCI
Segretario del Consiglio Circoscrizionale che ha messo, sempre, a disposizione del
Centro Civico
CON GRATITUDINE
Il Presidente
Il 5 settembre1987, mia figlia Patrizia contrasse matrimonio nella Chiesa dell'Eremo di Sant'Angelo in Vetralla, mentre il pranzo fu consumato nel Park Hotel Balletti, in San Martino al Cimino.
Lo splendore della bellezza di mia figlia è rimasto nei miei occhi e nel mio cuore trasferendosi poi, alle sue figlie Federica e Daniela Del Ciuco, vere magnifiche creature della natura, le quali meritano, unitamente al cuginetto Iacopo Matteacci, una particolare citazione che, a tempo debito, "infiocchetterà" questo scritto.
Varie vicende di salute hanno distolto la mia serenità personale, in particolare, per l'età, le maggiori le soffriva mamma a causa di una forte artrosi alle gambe.
Comunque debbo, onestamente, ammettere che mai, poi mai la mamma è stata d'ingombro alla mia persona, anzi, la sua presenza ed il mio interessamento per lei era "gioia di vita".
Ricordo, un giorno mentre stavo in Ufficio, in via Vicenza n. 69, dopo aver parlato, a mezzo telefono, con mamma, sentii bussare alla porta della mia stanza.
Erano tre suore, dell'ordine della Sacra Famiglia, ordine religioso a me noto perché da giovane frequentavo l'Istituto San Tommaso dove era superiora, prima suor Estella Niccoli, poi la sua cugina, suor Santina; due sante sulla terra, alle quali feci qualche favore, in cambio del loro affetto e delle loro preghiere.
Quello più importante fu di far spostare una fontana pubblica che stava nella parte superiore, vicino all'ingresso, che danneggiava lo stabile perché l'acqua che fuoriusciva s'infiltrava nelle mura della casa madre causando umidità permanente.
La fontana la feci spostare al di la del complesso, liberando lo stabile da un dannoso problema che da anni gravava su di esso.
Quindi, riprendendo il discorso relativo alla visita delle tre suore; dopo averle fatte sedere, una di loro notò che avevo gli occhi bagnati da lacrime e a tale proposito mi domandò cosa avevo che mi turbava.
Fu come aprire un rubinetto, scoppiai a piangere dicendo che avevo mamma che stava male e che si trovava in seria difficoltà per la deambulazione.
La suora più alta, che poi seppi essere la superiora mi disse: "La porti da noi, nel nostro Istituto viene un medico, tanto bravo, che segue le nostre ammalate".
"Facciamo in modo di avere un parere da questo dottore!". Domandai chi fosse questo medico; mi fu risposto che era il dottor David Topini.
Non feci trascorrere un solo attimo, chiamai, a mezzo telefono, la mamma alla quale le prospettai quanto la reverenda suora mi aveva proposto.
La mamma, sempre dolce, mi rispose: "Ringrazia le suore poi, se Dio vuole, vedremo".
Dopo aver assolto i desideri delle suore, senza alcuna esitazione, firmai il foglio di uscita, temporanea, dall'Ufficio e mi recai a casa dalla mamma.
Trovai mamma frastornata, più che addolorata dal disturbo alla gamba.
Capii che qualcosa non era stato chiaro, che la telefonata non aveva suscitato l'effetto sperato; qualcosa non aveva prodotto l'aspettativa voluta!
In un batter di ciglio capii che mamma aveva frainteso quanto mi avevano detto le suore o quanto io avevo, forse troppo frettolosamente, riferito per telefono.
A quel punto, commosso, abbracciai la mamma, me la strinsi al petto spiegandole che l'invito di andare all'Istituto San Tommaso, dove normalmente venivano ricoverate persone anziane e giovani disabili, era solo per farla visitare da un medico ortopedico specialista e che il tutto si sarebbe risolto, in mia presenza, entro una mezzoretta.
Ricordo che mamma impallidì ed io, mentre me la stringevo sempre più forte al petto, le dissi: "Mamma cara, come avete potuto pensare, anche se per un solo attimo, quello che avete pensato? Mai, mai, nulla e nessuno ci dividerà, solo Dio lo potrà fare; voi sarete sempre nel mio cuore, come sono certo che io lo sono nel vostro".
Le nostre lacrime si mischiarono, bevemmo un goccio di cognac e, tenendoci per mano, rimanemmo seduti in sala, mentre mamma mi raccontava che aveva veduto, per televisione, un film con Alberto Sordi che, subdolamente, accompagnava la propria madre in una casa di riposo, facendole credere che doveva fare una sola visita, quando invece era intenzionato ad abbandonarla, come poi fu.
In quel momento tutto mi apparve chiaro! Fu un attimo di tremendo dolore e di grande commozione, che rafforzò, qualora ce ne fosse stato bisogno, l'unione tra mamma e me.
L'indomani mattina, alle ore undici circa, con l'auto, accompagnai la mamma nell'Istituto San Tommaso per essere sottoposta a visita medica dal dottor Topini il quale è figlio di una cara signora, conoscente di mamma.
L'accoglienza fu soddisfacente, l'amore delle suore fu encomiabile, la visita medica e la diagnosi del dottor David Topini fu meticolosa e prudente, da essere tenuta nella dovuta considerazione.
Il dottore mi disse: "La situazione è grave, la mamma corre il rischio di non poter camminare più però, se lei Bruno, fa quanto dico, qualcosa otterremo, cioè mi deve portare la sua mamma, tre giorni alla settimana, alla casa di cura di Villa Immacolata, per la dovuta terapia, poi la deve far camminare tutti i giorni, senza farla affaticare; deve fare piccoli tratti di strada... riposarsi... e poi continuare".
La mia risposta fu più che affermativa.
Provai a pagare la prestazione sanitaria, ma non mi fu consentito, ringraziai medico e suore ed uscimmo dall'Istituto con tanta speranza e tanto, tantissimo reciproco amore.
La terapia suggerita "del camminare" la iniziammo la stessa giornata, ricordo che mamma, per fare cento metri di strada, si doveva fermare almeno due o tre volte.
Nulla ci preoccupava, grazie a Dio, le giornate sono state sempre e sempre saranno di ventiquattro ore; pertanto di tempo da dedicare, ad una cara persona, ce ne è tanto, basta volerlo!
Con tanto amore, piacere e devozione ho fatto quello che ogni figlio dovrebbe fare per un genitore.
Mamma era arrivata al punto che, giornalmente, faceva con me una passeggiata, con inizio dal cimitero di San Lazzaro, fino agli Occhi Bianchi, con una sola fermata.
I risultati non sono mancati; con la terapia fatta a Villa Immacolata, con la buona volontà di mamma e con la mia dedizione, nell'accompagnarla, sono riuscito a dare alla persona bisognosa, più amata che mi era rimasta l'autonomia nei movimenti e nei suoi spostamenti, senza farla essere dipendente da altri, se non dall'amore del suo figlio al quale ella ha dato la vita, non una, ma varie volte.
Di ciò, pur non avendo più, sulla terra, la mia mamma, sono orgoglioso di aver fatto tutto quanto ho fatto e, se ci fosse stato da fare, anche per un solo attimo, quello che non ho fatto, mamma, vi chiedo perdono, non era nella mia volontà! Voi lo sapete!
Oggi, 3 ottobre 2006, alle ore 9,55, riprendo a scrivere quello che il mio cuore dice e quello che la mia memoria ricorda.
E' stata una lunga pausa dovuta alla rottura del computer, che ieri, grazie a mio nipote Mauro, mi è stato riconsegnato con un nuovo schermo.
Rileggere, dopo qualche mese, quanto avevo scritto à stato un rinverdire la mia memoria ed un riaprire, maggiormente, qualche ferita, comunque ho ancora molto da dire riguardo a quello che è stato, convinto che: "Senza il passato, non può esistere né il presente né il futuro". Quindi caro Bruno, vai avanti, perché hai tanto ancora da raccontare e c'è chi vuole sapere, quello che tu vuoi dire del passato.
Tanti episodi affiorano alla mia mente, nel ricordarli è come rivederli e riviverli.
Mi viene spontanea la domanda: "Ma è il caso di parlarne?".
La risposta che mi sono dato è: "Ma se sono fatti ed episodi che hai vissuto, è logico che è il caso di parlarne”.
Purtroppo i miei ricordi stanno apparendo sfumati, come se una nube li avvolgesse nel momento che affiorano alla mente; comunque ho tanto da dire, anche in forma non cronologica e un poco confusionaria nei tempi, ma veri e sofferti in alcuni casi, ma belli riviverli in altre circostanze.
AUGURI !
PATRIZIA NOSTRA
10 ottobre 1985
il babbo - la mamma - il fratello
Ricordo, con tanto amore, quella giornata che resterà indelebile nel mio cuore.
Oggi, 9 ottobre 2006, sono le ore 15,27, per una strana coincidenza, mi trovo ad operare al computer. Colgo l'occasione per inviare, per domani, tanti auguri e baci alle mie adorate Patrizia e Daniela.
Per motivi strettamente personali e per l'amore che nutrivo per la mia mamma; sollecitato, poi, dalla incertezza politica sul poter o meno essere collocato in pensione, feci le valutazioni sulla possibilità che avevo per andare in meritato riposo.
Sentii alcuni amici, del Ministero e dell'I.N.P.D.A.P., chiedendo loro consigli e se correvo rischi nel rinviare tale trattamento di quiescenza, per la incertezza legislativa che regnava in quei momenti.
La conclusione fu di andare in pensione il 31 dicembre 1995, con oltre trentotto anni di servizio. Feci i conteggi e vidi che prendevo più di pensione che di stipendio; stando senza lavorare evitando così di prendere pure delle arrabbiature.
Sì perché spesso capitava di dover ingoiare dei grossi "rospi" perché, spesso, chi amministrava, non era all'altezza del posto che ricopriva e pretendeva dare degli ordini che erano assurdi o contro legge.
C'è da tenere nella debita considerazione la delicatezza e la responsabilità che avevo nel dirigere un ufficio come il mio. E' certo che se uno lavora con coscienza e responsabilità, tutti i posti diventano prestigiosi e delicati, basta cercare di soddisfare le esigenze della collettività che si rivolge a quell'ufficio dove cerca la soluzione dei propri problemi e delle varie aspettative.
Certuni occupavano posti di potere solo per il fatto che avevano preso un voto elettorale in più di un altro che, magari, era diplomato o addirittura laureato.
E' stato impressionante vedere, come ho veduto, nella mia storia di politico e di funzionario comunale, l'esistenza di qualche amministratore che aveva appena la quinta elementare, che poi, grazie al posto che ricopriva ed alle aderenze politiche ha ottenuto la licenza di scuola media e titoli di studi vari.
In previsione del mio trattamento di quiescenza inviai, su carta intestata, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, la seguente lettera:
Viterbo, 8 dicembre 1995
Caro/a...,
dal 31 Dicembre 1995 si chiude una parentesi della mia vita.
Sarò in pensione.
Però, prima di varcare la soglia del Palazzo dei Priori verso la via del "riposo", sento il dovere di rivolgerTi un pensiero.
Un pensiero Amico, che mi auguro resti indelebile nei nostri cuori.
Abbiamo trascorso molto tempo lavorando nell'interesse della nostra Città dei suoi abitanti ed in questo frangente il mio impatto con la realtà delle cose è stato delle volte duro, ma grazie alla Tua Amicizia, tutto si è presentato più.
Proprio per questo volevo ringraziarTi augurandomi di poter trovare in Te, nel futuro, sempre disponibilità per la soluzione dei problemi che spesso attanagliano la maggioranza dei nostri concittadini.
Nel mio animo porterò la Tua immagine che mi aiuterà a non invecchiare.
Cordialmente Ti saluto
F.to Bruno Matteacci
01100 Viterbo - via Monte Nevoso, 27 - Tel. 0761342400/0368969259
Il Sindaco pro-tempore di Viterbo, dottor Marcello Meroi, ebbe il bel gusto di consegnarmi una targa recante l'immagine di San Pellegrino con scritto:
"Al Rag. BRUNO MATTEACCI - Dicembre 1995
L'Amministrazione Comunale di Viterbo".
Per festeggiare il collocamento in pensione volli organizzare un pranzo nel noto ristorante "Biscetti" a Bagnaia invitando, logicamente, la mamma, i miei figli Patrizia e Giuseppe con i rispettivi congiunti e figli, i miei nipoti Mauro e Carlo Galeotti con le rispettive famiglie.
Avrei tanto gradito avere, come ospiti, i miei zii Adamo e Ida Cecchetti da Gubbio, che non poterono venire.
Il 17 gennaio era il compleanno della mamma; normalmente offriva il pranzo e invitava gli zii di Gubbio perché zio Adamo festeggiava il suo compleanno il 19 Gennaio.
Il giorno del compleanno della mamma le feci gli auguri e trascorremmo la giornata, insieme perché la ricorrenza, in forma solenne, la volli festeggiare insieme al
mio pensionamento il 21 gennaio, giornata che ricadeva di domenica dando, quindi, a tutti l'occasione per essere presenti, come di fatto lo furono.
Fu una giornata indimenticabile; eravamo tutti, cosa che normalmente capitava solo in occasione dei compleanni della mamma che, caramente, ci offriva sempre il pranzo.
In detta occasione, ad un certo punto, i convenuti mi consegnarono regali di varia natura per festeggiare il mio trattamento di quiescenza; nel contempo vidi la mamma che prese la sua borsa dalla quale estrasse un certo numero di buste rettangolari, di colore bianco, sulle quali era scritto il nome di ognuno di noi.
Per primo consegnò a me la busta che l'aprii e, con stupore, vi trovai un milione di lire.
La mamma continuò a consegnare a tutti la propria busta con la somma indicata per un totale di quindici milioni.
Tutti rimanemmo stupefatti non comprendendo il gesto, anche se mamma è stata sempre generosa nel donare.
Quello che accadde quel giorno lo capii e lo valutai successivamente nel guardare il filmino che fu fatto durante il pranzo. Cosa ho avuto modo di notare?
La mamma, mentre stava a tavola, più volte, portò le mani sul suo bel volto a mo' di sostegno facendo, nel contempo, un gesto come se avesse sentito una scossa di elettrica. Oramai era troppo tardi!
Il giorno successivo, 22 gennaio 1996, riscossi la liquidazione della mia pensione, ma la gioia durò pochi giorni, perché subii un lutto che mi rattristò.
Sulla pagina della mia agenda, il 26 gennaio 1996, leggo: "E' morto, su questa terra, l'amico Enzio Cherchi… ma vive… ti ricorderò sempre… Ciao caro fraterno amico. Bruno”.
Purtroppo altri gravi dolori dovetti sopportare e oggi, a distanza di oltre dieci anni, se avessi potuto, avrei oscurato questo pensiero che ha addolorato, tremendamente, la mia vita e che mi rattrista ogni qualvolta rivivo quegli attimi, che hanno determinato la sua dipartita da questo magnifico mondo dove insieme abbiamo trascorso momenti bellissimi, perché vissuti nell'amore e nell'affetto tra madre e figlio.
Il soggetto principale di detto pensiero è colei che mi ha dato la vita e che, per me, ha vissuto sessant'anni, donandomi tutto il suo amore, le sue attenzioni, la sua vita.
Parlo di mia mamma, Maria Ceccarelli, nata a Gubbio il 17 gennaio 1913 e ritornata alla Casa del Padre il 14 febbraio 1996, all'età di 83 anni, tutti vissuti e nessuno sprecato.
Era il 7 di febbraio 1996, come al solito, al mio risveglio feci una telefonata alla mamma per sentire la sua voce e conoscere il suo stato di salute e il suo umore.
Tutto sembrava normale; non poteva essere il contrario perché la mamma, anche se fosse stata male, non me lo avrebbe detto o tanto meno fatto capire.
Nella prima mattina mi avviai verso casa di mamma, in via Leonardo da Vinci n.17, interno 6; avevo le chiavi, entrai e la vidi seduta in cucina vicino alla finestra, con il corpo rivolto verso la porta d'accesso, pronta a ricevermi e a darmi il tanto atteso e gradito abbraccio accompagnato da un bacio che, per me, è stato sempre il viatico giornaliero.
Mamma era in camicia da notte con sopra una vestaglia, di colore celeste; era pallida anche se i suoi occhi emanavano uno sguardo colmo di amore.
Ci abbracciammo e ci baciammo; sentii un abbraccio più consistente delle altre volte, guardai verso il lavandino della cucina e notai qualcosa che attirò maggiormente la mia attenzione.
Il lavandino era quasi pieno di acqua e mi parve di vedere i fondi del caffè fatto con la Moka; chiesi a mamma il perché aveva fatto il caffè, quando era consuetudine che lo preparassi io, al mio arrivo.
Detti uno sguardo intorno, notai che la macchinetta del caffè era al suo solito posto vuota e non vidi il caffè.
Con discrezione accertai, manualmente, cosa fosse nel lavandino in mezzo all'acqua; mio Dio trovai del sangue coagulato. Ecco perché mamma era pallida; aveva avuto un'emorragia.
Non ci pensai due volte chiamai subito il dottor Vincenzo Cinotti, che ha lo studio medico a pochi metri dall'abitazione di mia madre; il dottore giunse in un batter d'occhi, vide la mamma e dispose subito, tramite il 118, il ricovero in ospedale.
La mamma non voleva essere ricoverata in ospedale a causa del noto disturbo della claustrofobia; io la rassicurai dicendole che non l'avrei abbandonata nemmeno per un secondo e che sarei entrato in ospedale avanti a lei e sarei uscito dietro di lei.
Temporaneamente rasserenata e forte del fatto che, in precedenza, quando stette male e fu ricoverata nel reparto otorinolaringoiatra dell'Ospedale Grande degli Infermi, io stetti tutto il tempo, giorno e notte, al suo fianco, accettò il ricovero.
Fu fatta sedere su una sedia ed accompagnata fuori dell'uscio di casa dove l'attendevano le signore Ilma Forieri e Maria Hudorovich alle quali mamma, sottovoce, disse: "Arrivederci... Dio mi aiuti... vado a morire all'Ospedale!".
Per me fu una pugnalata nel cuore, ma non potevo fare altro, l'unica soluzione era il ricovero in ospedale.
Sento ancora, nelle orecchie, e nel cuore il suono lacerante della sirena dell'ambulanza, che seguivo con la mia Volkswagen, mentre si andava lungo la strada Sammartinese.
Giunti che fummo al pronto soccorso dell'Ospedale Belcolle, volli parlare con il primario del Pronto soccorso, il tanto caro e umano, dottor Luigi Bertini e con il primario del reparto in cui la mamma doveva essere ricoverata allo scopo di avere il nulla-osta e la certezza di poterle stare vicino, giorno e notte, per tutto il tempo della sua degenza.
Per la carenza di posti letto in chirurgia donne la mamma fu, temporaneamente, ricoverata nel reparto Otorinolaringoiatra, in attesa di essere trasferita. Parlai con vari medici allo scopo di sapere quale fosse stata la causa scatenante della emorragia subita dalla mamma; mi fu chiesto di conoscere la terapia che mia madre faceva.
Fra le poche medicine che venivano somministrate alla mamma, su certificazione del medico di base di famiglia, il dottor Vincenzo Cinotti, erano: una compressa per la pressione ed una per il colesterolo; da qualche giorno le fu prescritto il Voltaren, in fiale, che avrebbe dovuto avere la proprietà di lenire il dolore delle ossa.
Mamma, però, aveva una ulcera allo stomaco. Credo che quella fu la causa di tutta la catastrofe, anche se, interpellato il medico, la risposta fu negativa perché, mi fu detto che non poteva essere stato il Voltaren perché somministrato, una sola volta, in via cutanea.
Il giorno successivo, 8 febbraio 1996, era il sessantaseiesimo anniversario di nozze dei miei genitori, ricordai alla mamma la ricorrenza, che le fece piacere; ricordo che si fece il segno di croce e dette un bacio alla fotografia del babbo che portava intorno al collo in un medaglione, attaccato ad una catenina.
Alle ore 0,05 mamma è stata molto male, ha avuto una grossa emorragia, era pallidissima, mi disse: "Bruno mio, la mamma muore"! Mi misi a gridare, chiedendo aiuto, venne un'infermiera che, senza esitare un secondo, salì sul letto di mamma e dopo averla presa per i piedi la sollevò verso l'alto, lasciandole la testa verso il basso.
Fu un momento tremendo, mamma aveva lo stomaco pieno di sangue che espulse, per bocca, grazie all'intelligente pronto intervento di quella signora della quale, purtroppo, non ricordo il nome, ma a cui va ancora il mio sentito ringraziamento e senso di gratitudine.
Quella brava infermiera, ricordo, che inveì contro chi avrebbe dovuto mettere una sonda che avrebbe potuto evitare tale inconveniente.
Mamma fu subito trasferita in chirurgia donne allo scopo di stare il più possibile, vicino all'infermeria e quindi più a contatto con il personale medico e paramedico.
Il giorno 9 febbraio, mamma stava un pochino meglio; certo lo spavento della nottata e la perdita di sangue avevano aggravato, ulteriormente, lo stato di salute di mamma e il mio stato d'animo; comunque ringraziammo il Signore per lo scampato pericolo.
Nei giorni successivi, i medici decisero di fare una gastroscopia allo scopo di vedere la situazione; mamma si rifiutò, sempre a causa del sintomo claustrofobico, mentre io tentai di convincerla ad effettuare tale accertamento, ma non fui ascoltato, né insistetti perché mi interessava vedere la mamma serena.
Il giorno successivo, nel momento in cui passò la visita, in mia assenza, perché ero fuori nel corridoio, la mamma disse al primario del reparto, dottor Giuseppe Capotosti, che dava il nulla-osta affinché fosse fatta la gastroscopia.
Quando l'equipe di medici uscì dalla stanza, il dottor Capotosti mi informò della volontà espressa da mamma circa l'esame gastroscopico da fare; restai allibito e chiesi alla mamma il perché di quella decisione.
Mia madre mi disse: "Vedi Bruno, se io faccio tale esame e succede qualcosa di irreparabile, tu non ti libererai mai dal rimorso di coscienza per avermelo imposto; per questo prendo, da sola, la decisione e... sia quello che Dio vuole".
Era il 12 febbraio, io chiesi a mamma se riteneva opportuno che avvisassi, del suo ricovero, le sorelle Anna, Ida ed il fratello Emilio, cioè la zia di Roma e gli zii di Gubbio oltre, logicamente, i parenti di Montefiascone. La mamma, dopo il rifiuto dei giorni precedenti, accettò la proposta e mi invitò ad avvisare tutti.
Il giorno successivo, 13 febbraio 1996, la prepararono facendole degli esami del sangue e, nella tarda mattinata, vennero i parenti da Gubbio, da Roma e da Montefiascone che poi partirono sul tardi. Mamma fu veramente contenta di aver riveduto tutti.
Nello stesso periodo, il mio amatissimo "Fratello in Cristo", don Armando Marini, era ricoverato in ospedale a Siena, per un problema cardiaco; Armando non sapeva del ricovero di mia madre; glielo tenemmo segreto allo scopo di non aggravare le sue condizioni di salute.
Il 13 mattina ricordo che la mamma mi disse testualmente: "Bruno telefona a Siena, per conoscere le condizioni di salute di quel "figlio" e fammici parlare; dicendo cosi, mamma intendeva parlare con don Armando, il nostro amato sacerdote.
Con il mio telefonino lo chiamai, mi rispose Giacomina, la sorella, alla quale domandai come stava il fratello; fui rassicurato e chiesi di poter parlare con lui, cosa che feci, ci scambiammo un caro saluto e passai, poi, il telefonino a mamma che parlò, molto brevemente con l'amato "figlio", come lo considerava lei.
Mamma la nottata la trascorse serena, mentre io stavo sulla sdraia, tra il suo letto e la finestra, che era alla sua destra.
La mattina del 14 febbraio, festa degli innamorati, regalai alla mamma una rosa; ci scambiammo un bacio, bacio che mamma dette anche alla fotografia del babbo.
Giunta l'ora d'ingresso dei visitatori, vidi arrivare i miei famigliari, fra i quali Mauro che mi invitò a mettermi un poco sulla sdraia, sostenendo che erano sette giorni che non riposavo e mi vedeva super affaticato.
Mi avvicinai verso la porta d'ingresso, dove stava mia moglie e i miei figli, oltre ai miei nipoti, lasciando Mauro seduto vicino alla mamma con la quale si mise a parlare.
Mentre la mamma parlava con Mauro, si girò verso di me inviandomi prima un bacio, lanciato con la mano sinistra, al quale io risposi con analogo modo; poi seppi che disse a Mauro di aprire la finestra; come se avesse voluto dire: "Mauro apri la finestra, che adesso che non c'è Bruno, me ne vado".
Io vidi Mauro alzarsi dalla sedia ed aprire la finestra, vidi poi mamma che mi inviò un secondo bacio, con il caratteristico verso delle labbra, al quale gesto risposi per la seconda volta. Quello fu l'ultimo bacio terreno, datomi dalla mamma!
Vidi, a un certo momento, la mamma che si faceva il segno della croce mentre volgeva lo sguardo, oltre la finestra, aperta, verso il cielo, emettendo l'ultimo respiro.
Fu un attimo, l'attimo più brutto e doloroso della mia vita; la mamma, la mia amata mamma, alle ore 11,45 del 14 febbraio 1996, rese l'anima a Dio, ritornando alla casa del Padre, lasciandomi, solo e addolorato su questa terra, dove abbiamo vissuto bei momenti che mai dimenticherò; sì mai dimenticherò, perché sia la mamma, che coloro che l'hanno preceduta, moriranno solo quando saranno dimenticati ed io con l'aiuto di Dio, non li dimenticherò; continueremo a vivere, insieme, nella preghiera e nei ricordi.
L'ultimo saluto terreno alla mamma lo abbiamo dato, il giorno venerdì 16 febbraio nel Santuario di Santa Rosa, dove tra una marea di parenti, amici e conoscenti, il carissimo don Bruno Marini ha celebrato la Santa Messa.
Il giorno successivo, sabato 17, come di consueto mi sono recato alla Santa Messa nella chiesa di San Lazzaro al Cimitero, dove per molti anni sono andato con mamma. Quel giorno, nel posto che ha sempre occupato mia madre, alla mia destra, nel primo banco a destra della chiesa, era un grosso mazzo di fiori; don Bruno celebrò la Santa Messa ricordando mamma. La partecipazione di lutto la feci così:
Il Buon Dio che tutto vede
benedica chi in lui crede.
Voi, Mamma e moglie cristiana
che tanto, sulla terra, avete dato
un premio dovete aver meritato
Voi che per gli altri avete vissuto
per Voi nulla avete tenuto
Bruno
Passarono giorni tremendi, certo che con il tempo tutto sarebbe stato più doloroso; non avrei però mai immaginato che dopo appena sette giorni dal decesso di mamma un altro colpo giungesse nel mio cuore.
Alle ore cinque del 21 febbraio mi giunse, da parte di una persona di un'agenzia funebre, che preferisco non nominare, una telefonata con la quale mi si chiedeva se don Armando era morto.
Per me fu una pugnalata anche se la domanda era interlocutoria, ma tenuto conto chi l'aveva effettuata mi si gelò il sangue nelle vene.
Telefonai a Siena ed ebbi la triste notizia del decesso del mio amatissimo "fratello".
Non ci sono parole per dire lo strazio di molti Viterbesi che in don Armando vedevano il sacerdote, il vero prete; colui che era sempre disponibile al servizio di tutti, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo.
I funerali, tra una marea di folla, furono celebrati, nella chiesa dei Santi Valentino e Ilario, da don Bruno e altri confratelli.
Nel momento in cui, in processione, il corpo fu portato nel nuovo cimitero ove è la tomba di famiglia dei Marini, io andai in chiesa e mi misi a suonare le campane come se avessi voluto chiamare a raccolta tutte le anime dei defunti, presenti nel cimitero di San Lazzaro, allo scopo di portare in trionfo l'anima di don Armando che per loro, aveva tanto pregato.
Sulla partecipazione da lutto, che ne furono fatte stampare varie migliaia, oltre alla fotografia di don Armando, intento a spiegare il Vangelo ai suoi parrocchiani, nella sua chiesa, sul retro della stessi, si legge:
+ Ha insegnato a vivere e morire
ha vissuto ed morto come ha insegnato.
----------------
Signore, fa' di me uno strumento della tua pace:
Dove c'è odio, io porti l'amore.
Dove c'è offesa, io porti il perdono.
Dove c'è discordia, io porti l'unione.
Dove c'è errore, io porti la verità.
Dove c'è dubbio, io porti la fede.
Dove c'è disperazione, io porti la speranza.
Dove ci sono le tenebre, io porti la luce.
Dove c'è tristezza, io porti la gioia.
----------------
O divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato,
quanto di consolare.
Di essere compreso, quanto di comprendere.
Di essere amato, quanto di amare.
Infatti: dando, si riceve.
Dimenticandosi, si trova comprensione.
Perdonando, si è perdonati.
Morendo, si resuscita alla Vita.
San Francesco
D O N A R M A N D O M A R I N I
N. 3-6-1940 M. 21-2-1996
**********************
Ebbi la sensazione che, veramente, tutto fosse finito, per fortuna, e grazie a Dio, guardando i miei figli e la mia adorata nipotina Federica, capii che non tutto era finito: è la vita, la morte fa parte della vita e solo con la morte si ha, se si merita, la certezza di un domani eterno da trascorrere, in comunione con Dio e con i nostri cari, che ci hanno preceduto in questo, temporaneo, passaggio sulla terra, dove hanno lasciato tanti ricordi, da non dimenticare e tanti esempi, da imitare.
Il giorno 22 febbraio 1996 feci celebrare una santa Messa per mamma e nonno Cesare, che nacque il 22 febbraio 1881; logicamente non dimenticando, in quella celebrazione, gli altri miei congiunti.
A decorrere dal 28 febbraio 1996, decisi di far ricordare, tutti i giorni; durante la Santa Messa, mamma, don Armando con i suoi genitori e gli altri miei defunti. Cosa che è stata fatta, per circa tre anni.
Il 3 marzo 1996, il mio babbo avrebbe avuto novant'anni; io in quella ricorrenza ho voluto lasciare qualcosa di materiale in suo ricordo.
Dalle sapienti mani di Adalberto Vittori ho fatto fare una targa di colore giallo sulla quale ho fatto scrivere:
In questa casa, il 3 marzo 1906 nacque Giuseppe Matteacci Maestro calzolaio.
Il figlio Bruno lo ricorda
3/3/1996
Targa, che ho attaccato, con la collaborazione di mio nipote Mauro Galeotti, sulla parete della casa, a Pietralunga - località Ronzano n. 43, di proprietà dei simpaticissimi Bruna e Giulio Biccheri.
Gli anni trascorrono veloci, la gioia di vivere si trova, come l'ho trovata sempre, guardando e seguendo i figli e i nipoti.
Per quanto riguarda Giuseppe le soddisfazioni si sono accavallate, prima il posto, quale impiegato di banca della Carivit, poi il matrimonio con una bravissima signorina, Delia Filesi, figlia di un vecchio amico di partito Giuseppe, detto Pino, che conobbi a Oriolo nel movimento giovanile della D.C.
Per quanto riguarda la mia adorata figlia, Patrizia, l'8 febbraio del 1999, ci ha fatto il dono di una bellissima bambina alla quale è stato imposto il nome Daniela, che crescerà a fianco della sua splendida sorella Federica ed insieme saranno i miei gioielli, che mi aiuteranno a vivere, amandole sempre di più.
Ho sempre amato i miei famigliari, che tuttora allietano i miei giorni, perché sono stati sempre l'unico scopo della mia vita.
Per quanto riguarda i miei genitori, sorella e cognato, che hanno raggiunto la casa del Padre, lasciandomi nel dolore e nel ricordo di quanto di bello è stato fra noi, ho inteso aderire, in data 22 giugno 1999 all'iniziativa, delle famiglie francescane, del Vescovo del Comune di Assisi e della Assisi Giubileo 2000, intesa a costruire la "via di San Francesco" con il posizionamento di mattoni, personalizzati con il nome e cognome, da sottoscrivere al prezzo di euro 43,90.
A tale proposito ho sottoscritto cinque mattoni e più precisamente i numeri 455 -
456 - 457 - 458 - 459 con le relative scritte: Matteacci Giuseppe - Ceccarelli Maria - Matteacci Bruna - Galeotti Vinicio - Matteacci Bruno.
Dopo varie incertezze sulla fattibilità dell'opera, sono riuscito a vedere questa via e fotografare il riquadro del pavimento con i nomi dei miei cari, con il mio compreso.
Con questo gesto ho inteso ancora una volta ricordare e lasciare, nel tempo, impressi i nomi di coloro che furono, con la speranza di non essere dimenticati per continuare a vivere, almeno nei ricordi, di chi leggeranno quei nomi.
Parole, fatti e ricordi si accavallano mentre, con il trascorrere del tempo, non è che le cose siano migliorate, anzi, potrei dire che "è piovuto sul bagnato".
Ebbi delle sensazioni, dico solo sensazioni e non dolori o malattie, ma sensazioni che mi consigliarono, dopo aver sognato più volte mia madre, di sottopormi a visita specialistica, dopo aver fatto un controllo dell'Antigene Prostatico Specifico (P.S.A.), che risultò di valore elevato. Non persi tempo, feci ulteriori esami a Viterbo, dal dottor Massimo Fattorini il quale, il 21 febbraio 2002, mi diagnosticò un "K" prostatico.
Chiesi al dottor Fattorini, presso il quale andai per una visita privata, che facesse di tutto per evitare l'operazione chirurgica perché sapevo in quali condizioni vivevano certi miei amici che avevano subito l'intervento chirurgico. Ebbi dallo stesso ampia assicurazione, ma il 2 di maggio mi invitò a fare un prelievo di sangue per essere sottoposto, il 10 maggio, ad intervento chirurgico. Provai una grande delusione finché su consiglio di qualcuno, consultai il dottor Micheletti di Terni e altri medici i quali, per la maggioranza, mi sconsigliarono l'intervento ad eccezione di uno di Roma che chiese una grossa cifra per la sua prestazione.
Non ebbi fiducia di quel personaggio che ebbe la meschinità di negarmi la ricevuta del pagamento della visita, sino al punto che minacciai di chiamare la finanza. Con mio figlio prendemmo la strada del ritorno a Viterbo. Mi sentii perso, con il telefonino chiamai l'Ospedale Gemelli per sapere se effettuavano la "terapia conformazionale" per la prostata. La risposta fu affermativa, fui invitato a non piangere perché tutto si sarebbe risolto per il verso giusto, fui invitato a presentarmi l'indomani dalla segretaria del professor Cellini.
Cosa fu a suggerirmi di fare quella telefonata, ponendo quella domanda? Un giorno trovai, in uno studio medico, la rivista del 7 novembre 2002 "l'Espresso" dove era un articolo del professor Umberto Veronesi dove, fra l'altro è scritto: "già abbiamo il Psa che è fantastico: un uomo che ha 60-70 anni trova il Psa alzato, si va a controllare e scopre un tumore di tre millimetri. Basta irradiare la prostata per guarirlo. Ecco la grande rivoluzione: la diagnosi precoce. E' quello che ci ha permesso di ridurre la mortalità in Europa”... “In radioterapia ora esiste ad esempio la terapia conformazionale, cioè il fascio ha una forma che si conforma all'organo o al tumore che vuole colpire. Quindi una precisione assoluta che distrugge il tumore in quella zona e che non provoca disturbi collaterali agli altri organi”.
Veramente il Signore è grande, mi ha messo in condizione di sperare, sino al punto di avermi messo, tra le mani "l'Espresso" e sulla strada del professor Cellini, primario del settore di radioterapia dell'Ospedale del Sacro Cuore "Gemelli" presso il quale sono stato benevolmente accolto, amorevolmente sopportato nelle mie debolezze ed incertezze e magnificamente curato sino al punto della totale guarigione. Ora, nel giro di una o due volte all'anno, mi sottopongo ad una visita dal dottor Giancarlo Mattiucci, di Gubbio, stretto collaboratore medico del professor Cellini al Gemelli, ora mio caro amico.
Grazie a Padre Pio che, su mia preghiera, ha interceduto, verso Dio, ho risolto il caso! Ma il sole non può sempre splendere, un'altra ombra si affacciò verso di me.
La mattina della Santa Pasqua del 2002, mentre stavo leggendo le scritture nella chiesa di San Lazzaro, sentii un grosso dolore al petto che, poi, a seguito di ricovero in ospedale, fu accertato essere un "infarto silente" e bisognevole di un intervento chirurgico per l'impianto di tre by-pass, che a Viterbo non effettuavano e che quindi sarei dovuto andare all'Ospedale San Camillo di Roma, dove purtroppo non c'era posto.
Io avevo fretta di sottopormi ad intervento chirurgico perché amavo e desideravo vedere il mio prossimo nipote, figlio di mio figlio, un Matteacci, che sarebbe dovuto nascere verso la fine di giugno o i primi di luglio.
Stante la precarietà del caso, tentai anche un ricovero d'urgenza al San Camillo, ma la fortuna non fu dalla mia parte, dopo tre ore di ricovero mi dissero che non c'erano posti letto liberi e che quindi dovevo essere trasferito in altra struttura medica, che io non accettai, perché gradivo esser operato dai professori Musumeci e Casali.
Le tappe dovevano essere bruciate il più presto possibile, tutto si poteva risolvere con l'aiuto di Dio, su intercessione di papa Giovanni XXIII, il mio "Papa buono".
Fra le mie preghiere mattutine ne recito una che così dice: "Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto". Io ho sempre chiesto, non solo per me, ma per i miei cari; ho sempre "bussato", per me e per i miei cari e i risultati si vedono.
Non mi stancherò mai di dire: "Pregate, pregate... chiedete e vi sarà dato; Dio è sempre pronto a rispondere e concedere, perché Dio... è buono!".
Quando il 10 giugno 2003 mi sono presentato, con la cartella clinica, all'Ospedale San Camillo, dal caro professor Giovanni Casali, per essere poi ricoverato e operato, dallo stesso mi sentii dire che non c'era più bisogno dell'intervento chirurgico perché le coronarie si erano riaperte.
Tra una lacrima di gioia ed un imbarazzo totale salutai il professore e di volata mi recai alla Basilica di San Pietro per ringraziare chi aveva intercesso in mio favore e chi aveva deciso la soluzione del mio caso.
Giunsi nella Basilica e, indegnamente, mi inginocchiai, davanti al Santissimo esposto; mi fermai tanto, quanto fu sufficiente per colmare la mia emozione e successivamente mi spostai, sul lato sinistro, dove era, ad attendermi, il "Papa Buono", Giovanni XXIII davanti al quale mi inginocchiai, tra la balaustra, senza avere degli impedimenti o delle sollecitazioni a spostarmi e, tra una lacrima e l'altra rimasi in adorazione e preghiera per oltre trenta minuti, fino a quando un cerimoniere si avvicinò a me dandomi una benevola pacca sulla spalla, pronunciando le seguenti parole: "coraggio, coraggio, il Beato Giovanni XXIII gli sta vicino"; mentre pronunciava queste parole mi mise in mano un santino del "Papa Buono" che, gelosamente, tengo sempre con me, che prego ringraziandolo tutti i giorni.
Il 1° luglio 2003, alle ore 19,43, è nato il "Re di casa", grazie all'amore di Giuseppe e Delia. E' un bel "maschione"; è Iacopo Matteacci figlio di mio figlio; è mio nipote!
Come ho fatto per la nascita delle nipotine, nel terreno sotto casa, ho messo a dimora delle piante e precisamente: per Federica un albicocco, per Daniela una pianta con fiori, per Iacopo un prugno; oltre, per entrambi, una pianta di rose ad alberello che si trovano sul mio terrazzo.
Non ci sono parole per descrivere la gioia che esiste nella nostra famiglia.
Iacopo Matteacci è stato battezzato, da don Salvatore Currò, nella chiesa di San Pietro attorniato da nonni, zie, zii e cugini; la cena, l'ottima cena, è stata offerta da Delia e Giuseppe nel ristorante Monteparadiso, dove abbiamo trascorso, intorno al "cocco di casa", una splendida, indimenticabile, giornata.
Giuseppe e Delia hanno raggiunto il massimo della felicità, felicità che si è estesa a tutti i nonni e parenti.
Non voglio fare torto alle due nipotine che già allietano la nostra vita, loro già sono due signorinette che insieme a noi tutti hanno amorevolmente aspettato la nascita del "re di casa" e questo "arrivo" lo hanno vissuto intensamente.
Per molto tempo le cose sono andate per il verso giusto, anche se io sono apprensivo, ma mi avvalgo molto del mio Medico, un Medico che non si vede, ma che fa vedere gli effetti; un Medico che non c'è università che possa vantarsi di averlo laureato. E' il Medico dei poveri, degli oppressi, delle persone buone del mondo! è Dio!
Il tempo passa inesorabile ed io che ho subìto un "K" prostatico, che grazie a Dio, su intercessione di Padre Pio, ho risolto; un infarto silente del quale devo ringraziare il Papa Buono; ho qualche altro acciacco, che mi assilla, l'“annite”! Sarà poi l'“annite”?
Ho un grosso problema nella deambulazione a causa di una somarata fatta, all'Ospedale Bel Colle di Viterbo, il giorno che fui ricoverato, a causa di una caduta, con la conseguente rottura di un muscolo.
Era il 10 luglio, ricorreva il mio compleanno, con alcuni amici mi recai nel locale "Buco bar" sito in viale Trieste; dove consumammo degli aperitivi. Nell'uscire, sotto il gradino, era uno strofinaccio bagnato sul quale, inavvertitamente, appoggiai il piede con la conseguente scivolata.
Lì per lì non detti tanto credito alla botta; comunque con l'ambulanza del 118, chiamata dai miei amici, fui trasportato all'ospedale dove non dettero il necessario peso all'accaduto; il medico, mio ex medico di base ed amico che mi guardò, dico "guardò" e lì tutto finì, mi disse: "a Bru' non è niente puoi andare a casa". Cosa che feci, ma durante la notte, la gamba sinistra divenne tutta nera chiamammo, prima, la guardia medica che disse di non poter venire, consigliandomi di prendere un Aulin, poi telefonammo al 118 che purtroppo non venne, limitandosi a consigliare di prendere un Aulin. Innervosito al massimo richiamai la guardia medica dicendo, alla persona che rispondeva al telefono, che l'indomani avrei fatto denuncia per omissione di soccorso.
Il dottore, dopo aver sentito quanto detto, venne nel mio domicilio e vista la gamba, dispose l'immediato ricovero in ospedale; dove mi hanno trattenuto per vari giorni diagnosticando, volgarmente, come lo è il dottore che pronunciò la frase: "Bruno non ti preoccupare, è solo una culata".
Per non avermi aspirato il sangue, che avevo libero nella gamba, come mi disse il bravo dottor Brescia che mi fece un'ecografia, nel momento in cui stavo ritornando a casa, oggi ho una "colata di sangue calcificato" che è stata diagnosticata, con risonanza magnetica, fatta in un centro radiologico di Roma.
Alla data di oggi, 19 ottobre 2006, sono in spasmodica attesa di essere ricoverato, al San Camillo di Roma, per un controllo al cuore perché, purtroppo, l'intervento fatto nel mese di giugno, al Belcolle di Viterbo, non è andato per il verso giusto, perché si è rotta la macchina proprio nel momento in cui stavano tentando di portare a buon fine l'esame coronaroventricolografico.
Alla luce di questa situazione, per me incerta e pericolosa, penso che sia il caso di stringere i tempi e raccontare quanto di importante manca nella storia della mia vita che è stanca, scoraggiata ed afflitta.
Con la speranza, per non dire con la certezza, che il mio amato don Armando Marini non mi abbandonerà voglio, come avevo già pensato, parlare di lui e di suo fratello Bruno per la loro quotidiana missione pastorale esercitata nel cimitero San Lazzaro di Viterbo oltre, logicamente, a quella primaria svolta in un "deserto" dove egli ha creato la parrocchia dei SS. Valentino e Ilario.
Quanto sto per fare, non vuole essere un parlare né laudativo né restrittivo su i due personaggi. Loro hanno operato, a vasto raggio, sul territorio della provincia e di persone che possono emettere giudizi ce ne sono a iosa; pertanto, mi limiterò a dire solo quello che è stato fatto al San Lazzaro. Per il resto, tutta la popolazione di Viterbo è a conoscenza di quanto ha fatto don Armando, con la sua famiglia, nel costruire il centro parrocchiale di Villanova. dove le pietre, che sono "testata d'angolo" allo stabile, sono ancora bagnate dal sudore della fronte di don Armando.
Sì perché lui, materialmente, ha costruito pareti e pavimenti, su quel terreno arido per il quale firmò l'atto d'acquisto stando sotto lo spiombo del sole appoggiato, per la firma sul sedile della sua malconcia "Lambretta".
A seguito di una convenzione fatta con l'Amministrazione Comunale di Viterbo, quale proprietaria della Chiesa di San Lazzaro, il parroco don Armando Marini poteva celebrare la Santa Messa in detta Chiesa, che appariva, nei primi tempi, tetra sino al punto da incutere paura a chi, velocemente, si affacciava sull'uscio, per salutare il nostro Signore Gesù Cristo.
Ricordo che quando entrai in chiesa con lo scopo di fare qualcosa per rendere più accogliente l'ambiente, svolazzarono due piccioni che mi misero una paura da non dire; i piccioni, entrati da una finestra con il vetro rotto, non erano in grado di uscire fuori.
Con l'arrivo di don Armando e con l'assidua assistenza, da parte mia, siamo riusciti a rendere gradita, in detta chiesa, la sosta per pregare; il mio compito, ambito e gradito, era quello di effettuare le sacre letture e, in sostituzione di qualche volontaria, raccoglievo le elemosine.
Don Armando celebrava la santa Messa tutti i giorni e nelle festività ne celebrava due: alle ore 9 ed alle ore 16. Spesso, allo scopo di soddisfare le richieste dei fedeli, celebrava Sante Messe straordinarie a qualsiasi ora, pur di accontentare e soddisfare le richieste, che erano sempre maggiori, come le continue richieste di benedizione delle tombe.
Da poche persone che iniziammo a frequentare la chiesa, giungemmo al punto di dover acquistare altre sedie onde evitare che i fedeli restassero in piedi durante la santa celebrazione perché erano in loco solo dieci banchi con una capienza di quaranta persone, oltre a qualche sedia rotta.
Con tanta buona volontà, riuscii a mettere una grossa lampada dietro al tabernacolo con lo scopo di illuminare l'abside, magnificamente pitturata da Pietro Vanni con un bellissimo Crocefisso e uno stormo di angeli festanti.
Successivamente misi due faretti che illuminavano verso l'ingresso e un terzo faro lo misi al centro della navata, allo scopo di illuminare l'altare e il celebrante.
E' da evidenziare che sull'altare erano e sono sei candelabri a cera e che le uniche due lampadine elettriche, a basso voltaggio, erano collocate in due porta-lampade, posti ai margini del sacrato, a destra e a sinistra, sorretti da catenelle.
Mentre lavoravo, per mettere il faretto dietro al tabernacolo, mi venne pensato di modificare i sei candelabri che, dopo averli fatti cromare, a mie spese, li trasformai in "candelieri" elettrici.
Pensato, riferito a don Armando, e fatto. Acquistai: del filo elettrico, sei canne di legno di colore rosso, delle spine e degli interruttori e quant'altro necessario riuscendo a fare sei lampadari elettrici, di un certa bellezza.
Con l'occasione, dopo richiesto il permesso a don Armando, con un vecchio lumino a cera, di colore rosso, feci un portalampade elettrico con una lampadina a fiammella, che rimane sempre acceso, onde attestare la presenza di Gesù nel tabernacolo.
L'aspetto della chiesa cambiò, non solo per la presenza di un sacerdote del livello di don Armando e quella saltuaria di don Bruno, ma anche per l'arredo e la pulizia del pavimento, delle pareti, dei banchi e della sacrestia.
Don Armando, visto che l'altare era diventato più illuminato e sull'esterno del tabernacolo apparivano delle macchie, decise, con una sostanziosa spesa, tutta a suo carico, di far ricoprire, con piccole lamine d'oro, il sacro tabernacolo.
Con l'andare del tempo, in detta chiesa, si notò la presenza di Viterbesi di una certa levatura sociale che, unitamente al "fedele" più umile, erano la vita, il lustro, la grazia di Dio; manifestata nella Chiesa di San Lazzaro, grazie alla forza traente ed il carisma di don Armando che, con le sue parole, riusciva ad entrare nei nostri cuori ed alleviare, i nostri animi, in un posto di dolore, come era ed è il cimitero.
I giorni passavano nella gioia e nel dolore; l'unica cosa sicura, attesa e soddisfatta, era la presenza di don Armando; sempre vicino pronto ad alleviare dolori e dare a tutti conforto e una buona parola consolatrice.
Con il tempo si presentò la necessità di acquistare alcune sedie, allo scopo di rendere agevole la presenza di tanta gente in questo sacro luogo; dieci sedie furono acquistate con una colletta fatta tra i fedeli; dieci le feci acquistare dal Comune e dieci le acquistai con mia madre.
La cosa che ci ammutolì fu il furto di dieci sedie prese dentro alla chiesa, la scomparsa di una scala di metallo e di una bicicletta, che aveva regalato l'amico Vittorio Ranaldi ai custodi del cimitero.
Dopo aver fatto varie indagini si venne a conoscenza che il furto era stato effettuato da una certa persona che, da chi di dovere, fu avvicinata e invitata a trovare una soluzione atta ad evitare strascichi e conseguenze più gravi, del gesto che aveva fatto.
Gli anni trascorsero in un clima sereno ed in un posto, al cimitero, dove potevamo incontrarci e "silenziosamente", come diceva don Armando, "potevamo fare del bene". Iniziammo, in vista del mese di novembre, ad effettuare: la pulizia delle tombe più abbandonate; a dare l'assistenza a qualche persona anziana, impossibilitata a pulire la tomba dei suoi cari o a trasportare un secchio d'acqua a chi non aveva più la forza fisica, se non per pregare ricordando i propri cari.
Tutto era normale, al cimitero di San Lazzaro, grazie a don Armando si era creata una "associazione silenziosa".
Un merito che non si può disconoscere a don Armando fu quello di effettuare una particolare cerimonia religiosa nel giorno della Commemorazione dei Defunti, con la presenza del Vescovo, oltre alla processione, attraverso i viali del cimitero.
Un giorno manifestai a don Armando il desiderio di poter scrivere sul retro dei candelabri, da me modificati e posti sull'altare, i nomi dei miei defunti e per la precisione: Giuseppe, mio padre; Bruna, mia sorella; Vinicio, mio cognato; Letizia e Salvatore, miei zii paterni.
Ebbi il nulla-osta e da tanto tempo questi nomi sono stati scritti sul retro dei predetti candelabri.
Le vicende della vita si modificano, i fatti si susseguono e le disavventure si accavallano, fino al punto che con l'andare del tempo, purtroppo altri due nomi, a me molto cari, li ho scritti sull'altare dove don Armando, per tanti anni, ha celebrato la Santa Messa.
Nel 1996 nel mese di febbraio il giorno 14 ho perduto la mamma, la mia adorata mamma e il giorno ventuno ho perduto don Armando, il mio caro fratello.
In quel mese è come se fossi morto anch'io.
A tale proposito, con il permesso dell'amatissimo don Bruno Marini, parroco della Chiesa dei SS.Valentino e Ilario e cappellano del Cimitero, in sostituzione del tanto, caro fratello don Armando, che improvvisamente ci lasciò, sulla croce di metallo che si trova sopra al tabernacolo ho scritto, nella parte posteriore, in memoria, i loro nomi, come appresso rappresentato: MARIA ARMANDO e sul sesto candelabro ho scritto BRUNO, il mio nome, stante la gravità dello stato di salute e il mio prossimo arrivo, in quel luogo di pace dove ogni giorno, grazie a Dio, per ora, oltrepasso il cancello, nell'andata e nel ritorno.
Nella Chiesa, da oltre trent'anni, occupo sempre il solito posto nel banco della prima fila di destra, verso il centro; la mia mamma sedeva alla mia destra.
Il mio compito, da nessuno sollecitato, ma gradito ed apprezzato da don Armando, prima, da don Bruno poi e, per ultimo, da don Gianluca Scrimieri era quello di fare tutto quanto necessario per onorare, con la preghiera, le gesta, le azioni la casa del Signore.
Spesso capitava di avere la visita dei ladri i quali, per impossessarsi di qualche spicciolo, rompevano le cassette dove venivano lasciate le offerte dai fedeli.
A volte, di notte, i ladri attraversando la finestra che si affaccia sopra ai fornetti costruiti in via provvisoria, entravano nel locale dove si tenevano attrezzi e strumenti vari, avendo poi la libertà di fare quello che volevano, come quando di notte rubarono le due grosse acquasantiere, scolpite da Pietro Vanni, che erano conficcate nel muro, ai lati dell'ingresso.
Una volta subimmo veramente un affronto non indifferente, rubarono un calice, una pisside e la patena, fortunatamente erano vuote.
Più volte chiesi di mettere le inferriate alle finestre onde impedire simili fatti, ma chi di dovere non recepiva il suggerimento, fino a quando l'amico Marcello Meroi, sindaco di Viterbo, in poche ore, fece fare quanto da me richiesto.
Il furto fatto, specialmente, in chiesa era un gesto che faceva tanto male, in particolare a don Armando, il quale era sempre disponibile a fare donazioni in danaro a chi manifestava necessità o stato di bisogno.
Posso ben testimoniare che spesso si pagavano le bollette della luce, del gas e dell'acqua, intestate a persone indigenti, che ne facevano richiesta o vagamente accennavano il loro problema trovando don Armando sempre pronto ad aiutarli.
Per quanto riguarda lo stato di manutenzione della chiesa, in particolare degli affreschi, abbiamo avuto sempre problemi; sebbene in una certo periodo, su pressante sollecitazione di don Armando, il Comune incaricò una certa ditta per dare una buona sistemata agli affreschi. Ricordo che, per oltre tre mesi, la chiesa fu occupata con una impalcatura che creò solo disagi ai fedeli senza avere avuto i risultati sperati sul restauro degli affreschi.
Tutto procedeva per il meglio, la frequenza dei cittadini era sempre maggiore, quindi fu molto apprezzata e necessaria la collaborazione data a don Armando, in forma continua, da parte di don Bruno, con il quale allacciai un ottimo rapporto.
Don Bruno, che poi succedette a don Armando, volle donare alla chiesa un bel tavolo sul quale celebrare la Santa Messa secondo il rito moderno, cioè con il celebrante rivolto verso i fedeli.
Poiché il tavolo era leggermente basso, quindi poco adatto per la sacra funzione, ebbi l'idea di alzarlo mettendo sotto due tralci di legno con un scannellatura sulla quale adagiai il tavolo, rendendolo più alto di circa venti centimetri.
In quell'occasione la comunità fece una colletta per acquistare un bel tappeto che si può vedere sotto il tavolo e don Bruno acquistò l'ambone che, con il tempo, si è dimostrato più che utile, necessario. Acquistai un faretto che collocai dietro alla colonna in modo da illuminare, sufficientemente, quanto deve leggere il lettore e il sacerdote durante la celebrazione delle funzioni religiose.
Una persona, a me molto cara, nel gennaio del 1996, volle fare dono alla chiesa di una serie di stole di colore verde, bianca, blu e rossa; di un calice, una pisside, una patena, un ostensorio, un turibolo, un secchiello per l'acqua santa, l'aspersorio, le ampolle e due tovaglie per l'altare.
Il tutto, purtroppo, don Armando non fece in tempo a indossare e usare.
Fu don Bruno a indossare, per la prima volta, quei paramenti, fino a quando venne don Gianluca Scrimieri, anch'egli mio carissimo amico, con il quale ho continuato a collaborare, come feci nel passato.
Il primo giorno che ci incontrammo con don Gianluca al cimitero egli chiese a don Bruno se poteva celebrare, in loco, qualche Santa Messa.
Don Bruno lo invitò a concelebrare la Santa Messa in occasione di un funerale che si teneva in quel momento. Da quel giorno, don Gianluca è rimasto vicino a don Bruno che, purtroppo, ebbe dei problemi di salute e che, grazie a Dio, si sono risolti benevolmente.
La missione di don Gianluca svolta nella parrocchia dei SS. Valentino e Ilario ed al Cimitero, nella Chiesa di San Lazzaro, in sostituzione di don Bruno, fu molto apprezzata dai fedeli che, sempre numerosi, frequentavano la chiesa.
Per non essere invadente e per non intralciare l'attività di tanti bravi volontari della chiesa di Villanova, mi limitai a frequentare solo il Cimitero anche se, una volta, in occasione di un pellegrinaggio, organizzato a Villanova, andai a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio. Di quella giornata ho un magnifico ricordo che è sempre vivo in me.
Durante il periodo in cui don Gianluca era il cappellano del Cimitero acquistammo: la via Crucis, che io poi misi a dimora; un bellissimo Crocefisso, che oggi si può ammirare alla sinistra dell'altare, un microfono piatto per meglio udire la parola del celebrante.
Don Gianluca volle acquistare, in un negozio sito in via Cavour, il cero pasquale per il quale io feci fare, artigianalmente, un treppiedi, dall'abilissimo fabbro Alberto Lombardo, mio amico, con laboratorio in via Maria SS. Liberatrice, su cui mettere il cero.
Ricordo che Alberto si sentì inorgoglito di aver fatto un lavoro per la Chiesa e, a tale proposito, chiese come pagamento appena il costo del materiale.
Don Gianluca volle acquistare la bellissima statua della Madonna Immacolata che ora troneggia sopra una bella colonna di peperino che io acquistai dalla ditta Luigi Paccosi.
Proprio a maggio, mese della Madonna, la statua fu messa sulla sinistra, guardando l'altare e, in quell'occasione don Gianluca, a braccio, fece veramente un bel discorso che commosse tutti i presenti.
Per Natale, pensai di costruire, con le mie mani, una culla artigianale per adagiare il Bambinello, nel centro della chiesa, davanti all'altare..
Per rendere più difficoltoso il furto di danaro, da parte dei ladri, pensai di acquistare al Brico, della ditta Aquilanti, una piccola cassaforte nella quale feci fare, dall'amico fabbro Alberto, una imboccatura larga quanto le cento lire che fuoriusciva dalla parete, dove feci murare la cassaforte dal muratore, Emilio Mancinelli, che opera nel cimitero.
Le attenzioni dei ladri si rivolsero verso le cassettine dei candelabri che venivano accesi dai fedeli. Con il tempo la gente capì, che se voleva fare un'offerta la doveva depositare nella feritoia della cassaforte la quale dava maggiore garanzia, data la sua struttura.
Poiché le visite dei ladri continuavano tutte le settimane; allo scopo di scoraggiare le loro azioni, mi venne pensato di collocare, nell'alto della cripta, due palline di albero di natale che, vedute da lontano e in forza di quanto segnalato, sembravano due telecamere.
Infatti, affissi sulle pareti dei fogli con i quali avvisavo la cittadinanza della messa in funzione di due telecamere. Che ciò non era vero lo sapevano solo i sacerdoti ed io.
All'inizio tutto andò per il meglio, non c'erano più furti perché i cassettini dei candelieri li lasciai aperti; l'unico modo per fare un'offerta era l'utilizzo della cassaforte che ha resistito fino al mese di settembre 2006 perché, anche quella, è stata forzata.
Relativamente ai furti effettuati nella chiesa del Cimitero ci sarebbe tanto da dire come per esempio quando nel mese di novembre del 1996 stavo in sacrestia a sistemare le ampolle e quanto altro era stato usato per la celebrazione della Santa Messa; sentii un fruscio, derivante dall'apertura della porta, pensai che qualcuno stava entrando in chiesa, poi sentii un rumore metallico che mi insospettì, mi affacciai e vidi un energumeno che stava scassinando la cassetta delle elemosine con un ferro, staccato dallo "Yale" della porta.
Mentre lui usciva, con il telefonino, chiamai il 113 con lo scopo di avvisare di quanto stava accadendo. Mi fu chiesto di seguire il ladro e di non perderlo di vista.
Sebbene mi sentissi male, perché il 2 novembre ebbi una paresi facciale da freddo, seguii, a distanza, l'individuo fino a quando, a mezzo telefonino, seppi che le forze dell'ordine l'avevano fermato. Pensai: "Un ladro di meno!".
Dopo pochi minuti mi incontrai con i rappresentanti della forza pubblica che mi dichiararono che il tizio in questione era un abitudinario del furto; un drogato che ogni volta che veniva preso, dopo poche ore era libero e derideva chi, con tanti sacrifici, faceva rispettare l'ordine a tutela del cittadino.
Dei vari furti effettuati in chiesa e dello stato di abbandono degli affreschi ne detti notizia sul quindicinale "La Citta", diretto da mio nipote Mauro Galeotti.
E' stato bello, l'aver avuto la possibilità di stare, per tanti anni, al servizio di sacerdoti della levatura di don Armando, don Bruno e don Gianluca, ma la cosa più importante, è l'aver potuto servire il Signore con azioni, anche se piccole, ma sincere manifestazioni d'amore, nel ricordo di chi ci ha preceduto lasciandoci un buon esempio per un vivere migliore.
Con il tempo ciò che era bello vivere è venuto meno: don Armando, il più fortunato, perché gode, senza alcun dubbio, della gioia di vedere Dio; don Bruno, per motivi di salute e per mancanza di un collaboratore, che avrebbe potuto alleviare tante preoccupazioni, è stato costretto a chiedere l'anno sabbatico e lasciare la Parrocchia per potersi curare.
Don Gianluca, che era il mio ultimo scoglio a cui potevo aggrapparmi in momenti di sconforto, fu trasferito prima a dirigere la Parrocchia di Santa Maria del Paradiso, in sottordine a don Pietro Concioli, vicario del Vescovo. Comunque, era don Gianluca a fare e disfare, nell'interesse superiore della Curia e dei parrocchiani.
Io gli sono stato sempre vicino, non perché lui avesse bisogno di me, ma ero io che avevo bisogno di stare, il più possibile, al servizio del Signore, in particolare nel periodo in cui frequentavo la parrocchia del Paradiso dove oltre cinquant'anni prima avevo fatto il chierichetto.
Ritrovarmi nella Chiesa Santa Maria del Paradiso, girare attraverso quei banchi, anche se rinnovati; ripercorrere quei corridoi, quella sacrestia è stato per me ricordare tanti, tanti bei momenti, della mia infanzia.
Nel periodo che don Gianluca era parroco al Paradiso andammo a Roma, in udienza dal Papa, per far incoronare l'immagine della Madonna con il Bambino in braccio.
Dal 15 al 18 giugno 2000, in occasione dell'Anno Santo, don Gianluca ed io ci aggregammo agli amici della Parrocchia del Sacro Cuore del Pilastro, sotto la guida del carissimo don Flavio Valeri, coadiuvato dall'infaticabile Arduino Troili, e dal caro "Peppino" ed altri quaranta che, a piedi, siamo andati pellegrini a Roma.
Anche questo avvenimento, unico della mia vita, rimarrà incancellabile nel mio stanco cuore che, solo al ricordo sussulta e ringrazia Iddio e coloro che lo hanno permesso e consentito.
Successivamente, per esigenze della Curia Vescovile, don Gianluca fu trasferito a Grotte Santo Stefano dove fu accolto con lo stesso entusiasmo che manifestarono, nella Parrocchia Santa Maria del Paradiso, il giorno del suo arrivo.
Nella Chiesa di San Lazzaro del Cimitero di Viterbo, si sentì moltissimo la mancanza di don Armando e di don Bruno prima, e di don Gianluca poi.
Ricordo un episodio che mi dette molto fastidio; fu un fatto che dava ancora una volta ragione a don Armando quando diceva: "Per qualcuno Dio non è trino, ma quattrino".
All'epoca del fatto era parroco don Gianluca Scrimieri al quale una signora chiese se poteva portare un sacerdote di altra parrocchia, per celebrare la Santa Messa in memoria del figlio; dato il parere favorevole, venne il giorno della ricorrenza.
Ricordo che, in quell'occasione, si dovevano ricordare i nominativi di alcuni defunti oltre, logicamente, al nome del bambino per il quale venne il sacerdote.
Ricordo che mi telefonò a casa la signora Scorzosi, che era malata, la quale mi chiese se potevo far celebrare, in sua assenza, la Messa in memoria del marito e del figlio, deceduto a seguito di un incidente stradale. Ricordo pure che, poverina, la signora si preoccupava per il fatto che non poteva dare un'offerta, a tale proposito la rassicurai dicendole che non era il danaro che apre le porte del Paradiso.
Pochi attimi prima dell'inizio della Messa, ricordai al sacerdote i nomi dei defunti da menzionare; erano nove, sei dei quali ricorrenti.
Sul tavolo della sacrestia, era ben visiva, una certa somma alla quale si doveva aggiungere, l'eventuale, offerta della madre del bambino.
E' da evidenziare che don Armando, don Bruno e don Gianluca, mai, dico mai, hanno chiesto offerte in compenso di Messe celebrate.
Dicevano e mi fu detto, come loro collaboratore: "Chi ha, se vuole, dia; chi non ha non dia, a nessuno si può negare la celebrazione di una Santa Messa".
Quel sacerdote sbirciò dove erano le offerte, visto che erano undici mila lire, leggendo i nominativi, disse: "ma che è una squadra di calcio?". Spiegai quanto necessario, ma egli soggiunse: "Ma qui ci sono solo undici mila lire!".
Rimasi schifato nel sentire ciò, gli dissi che l'offerta della madre del bambino, sarebbe stata effettuata, sicuramente, alla fine della Messa e che lui si doveva comportare da ospite perché a lui competeva soltanto l'offerta fatta per il motivo per il quale era stato chiamato e che nella Chiesa di San Lazzaro mai si sono chieste somme per la celebrazione delle Messe. Veramente quella fu un'amara esperienza!
Oggi nella chiesa al cimitero è giunto don Mauro, parroco di Villanova, il quale ha riscosso simpatia e affetto.
Io continuo, con amore, a frequentare la Casa di Dio, sita nel Cimitero di Viterbo, entro, mi siedo al solito posto dove, spiritualmente è mia madre, prego e a volte, se necessita, partecipo alla lettura delle sacre scritture.
In quel momento non posso e non devo pensare ad altro perché l'attrazione maggiore del mio spirito, oltre a Gesù, sono i miei cari, che mi fanno corona ed insieme a me ascoltano la parola di Dio, certi di una nostra riunificazione, in un mondo migliore!
I pensieri si accavallano, sono pensieri belli e brutti; gli acciacchi si fanno sentire; attendo, con trepidazione, la chiamata da Roma per fare un'angioplastica; ho paura di non fare in tempo a vedere risolto il problema.
Il 7 ottobre 2006, nello spostare una vecchia lavatrice ho avuto un grosso dolore al torace; ho avuto paura, ho capito che il mio povero cuore è stanco!
Il giorno 4 novembre 2006, in occasione della via crucis lungo "l'itinerario della fede" voluto da don Armando Marini, mi sono sentito male, ho avuto il solito disturbo al cuore; ho rinunciato ad effettuare il percorso a piedi, per giungere sul luogo dove, normalmente, don Bruno, celebra la Messa.
Nel momento che ritornavo verso l'auto, le signore Ascenzi e Rovidotti, accortesi che non stavo bene, volevano soccorrermi, le ringraziai rifiutando perché non volevo rovinar loro la giornata. Presi un "Carvasion" e salii sulla mia auto; feci il giro, giunsi sul luogo dove avvenne il martirio dei SS. Valentino ed Ilario, per partecipare alla Messa; intanto il dolore al petto diminuiva, mentre il mio pensiero volava, più del solito, a don Armando e ai miei cari.
Ho provato a contattare, a Roma, il professor Giovanni Casali, ma tutto è stato vano, allora ho parlato con il caro amico, dottor Francesco Serra, che mi ispira fiducia, il quale mi ha prenotato per fare l'angioplastica a Viterbo, stante il fatto che i dolori erano frequenti e quindi non c'era tempo da perdere.
Il 6 novembre 2006 alle ore 15,30 mi sono ricoverato e il giorno 8 mi hanno sottoposto all'intervento necessario per aiutarmi a vivere.
I medici sono stati: la dottoressa Cesari ed il dottor Irini ai quali vanno, i miei ringraziamenti, visto che a giugno la cosa non andò per il verso giusto a seguito della rottura dell'apparecchio radiologico. Logicamente, in primis, ringrazio chi tutto può e tutto concede, senza nulla chiedere, se non amore verso il prossimo, Dio.
Dopo vari giorni dall'intervento angioplastico sono stato sottoposto a visita medica cardiologica dal dottor Claudio Marcolini il quale mi ha trovato in buone condizioni. Ancora grazie al buon Gesù e a tutti i Santi, che mi ascoltano, unitamente ai miei cari babbo, mamma e sorella presso i quali, spesso se non sempre, mi rivolgo certo di un loro aiuto che, come sempre, me lo hanno dato sulla terra, dove le cose sono più difficili.
Giunti ad una certa età, per non dire ai miei settant'anni, è fatto obbligo stare con i piedi per terra e vivere di ricordi, di ricordi ed ancora di ricordi e di qualche rimpianto.
Intanto quello che è più vicino ad oggi, 17 Dicembre 2006, è la nascita della mia amata nipotina, Viola Matteacci, che ha veduto, per la prima volta, questo magnifico mondo nell'ora notturna dell'una e ventinove. E' un fiore di bambina di chilogrammi tre e cinquecento; il nome lo ha scelto il "padrone del mondo", mio nipote Iacopo Matteacci, figlio di mio figlio Giuseppe e della dolce nuora Delia Filesi, nonché fratello di Viola.
Dire oggi che sono felice potrà sembrare che prima non lo fossi, non è così; ad ogni nascita di figli e nipoti è stato ed è "un toccare il cielo con le mani" e di ciò ringrazio Iddio per la grazia concessa!
Viola Matteacci, il 1° aprile 2007, nella Chiesa di San Pietro in Viterbo, ha ricevuto il sacramento del Battesimo, attraverso le mani di don Salvatore Currò, parroco che ha unito in matrimonio Giuseppe e Delia, nella Chiesa delle Farine; giornata che ricordo ancora con tanto amore!
Allo scopo di fare, ad entrambi i figli, lo stesso trattamento Giuseppe e Delia hanno organizzato la cena nello stesso ristorante "Monteparadiso" in località Monterazzano; zona veramente bella e locale prestigioso, per non soffermarmi ulteriormente sull'ottima cucina ed eccellente servizio.
A questo punto, con quattro magnifici nipoti e due super figli, anzi devo dire tre super figli perché nel numero devo includere anche mia nuora Delia, per la quale non ho parole per descrivere la sua bontà e l'affetto che ha verso di me.
Di ciò ringrazio Dio!
A volte mi viene spontaneo pensare se mi merito tutta questa benevolenza del Signore; spero che la risposta sia affermativa e che io possa ancora rendermi utile ai miei figli e nipoti, unico scopo della mia vita.
Fra le tante soddisfazioni che, giornalmente, provo e il seguire la Santa Messa per televisione, il sentire telefonicamente, se non è possibile vederli, i miei figli Patrizia e Giuseppe i miei adorati nipoti: Federica, Daniela, Iacopo e Viola.
Altra soddisfazione la provo quando collaboro con Mauro per la redazione del giornale "La Città" dove, puntualmente, si può leggere un mio, pur modesto articolo, nell'interesse di questa magnifica città, Viterbo, scelta da mio padre, nel 1937, allorquando si trasferì da Gubbio per motivi di lavoro senza mai, però, dimenticare la "terra natia".
L'amore per Gubbio, senza dubbio, è rimasto in me.
Ogni tanto sento la necessità di fare i 320 chilometri, tra l'andata ed il ritorno, per respirare l'aria dei miei avi tra Gubbio, Pietralunga, Montone e Pisciano dove fui "sfollato" in tempo di guerra, senza dimenticare la periodica visita nei santuari di Sant'Ubaldo, Canoscio, la Madonna dei Monti e la Madonna dei Rimedi.
Logicamente non dimentico "coloro che furono", nonni e zii che riposano nei luoghi dove vissero e furono felici tra l'affetto di tutti.
Affetto, amore e felice ricordo che, oggi, io ho verso loro e che, con i miei ricordi, intendo farli vivere, finché vivrò!
In una vita, durata oltre settant'anni, come la mia, si possono contare tanti avvenimenti belli e tant'altri brutti, che hanno lasciato un segno incancellabile.
Ognuno di noi dovrebbe avere una bilancia per poter determinare da quale parte, della stessa, il piatto si abbassa, nel senso di vedere se su di essa certi avvenimenti sono maggiori di altri. Alla fine della valutazione, la speranza è, che dopo un meticoloso esame ed un'equa ponderazione delle situazioni, gli avvenimenti migliori siano superiori a quelli cattivi.
A dire la verità si deve mettere nel conteggio dei "guai" il fatto che siamo in questa terra solo per un breve periodo e che certe prove di sofferenze sono i "ticket" che consentiranno poi l'ascesa verso l'eternità.
A volte un brutto avvenimento ci abbatte, ma solo perché non lo si colloca nella realtà della vita; ad esempio: il decesso, di una persona cara, deve avere diverse valutazioni, anche se il distacco è sempre doloroso. E' importante valutare: la permanenza della persona su questa terra e la circostanza che le ha tolto la vita.
Sì, la sofferenza è diversa, come è diversa la rassegnazione; importante è che mai, dico mai, un padre "seppellisca un figlio"; mentre è "normale" che un figlio seppellisca un padre!
E' pur vero che predico, forse bene, ma "razzolo" male; per questo chiedo scusa a chi mi leggerà, ma sono un essere più facile alla commozione e al dolore e, meno alla gioia.
Di gioie, in una lunga vita, se ne provano tante; basti pensare quella di diventare padre prima e nonno poi. Non ci sono gioie che possono sostituirle.
Ogni qualvolta si guarda un figlio o una figlia; un nipote o una nipote, si prova una sensazione indescrivibile, loro sono in noi come noi siamo in loro.
Infatti, sono loro che proiettano, nel domani, quelli che furono, i nostri genitori!
Ricordo, con piacere, la gioia che provò mia madre nel divenire bisnonna e, nello stesso tempo, con somma gioia, ricordo nonna Assunta che, contemporaneamente a mamma, divenne trisavola.
C'è motivo per poter dire: "voglio vivere serenamente con la speranza di poter essere, sempre, in grazia di Dio e non curarsi dei beni materiali, se non per poter sopravvivere e far felici i figli".
Si “nasce nudi”, ci si affanna per tutta una vita e non si calcola, che si "muore nudi", non si porta via nulla se non, nel ricordo, le buone azioni!
Fra le gioie, derivanti da attività spirituali o religiose, che ho provato nella mia vita, voglio ricordarne alcune, la prima è il pellegrinaggio fatto a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, organizzato da don Gianluca Scrimieri, parroco della parrocchia dei Santi Valentino ed Ilario in sostituzione di don Bruno Marini che, purtroppo, era malato e si era trasferito a Rimini.
Da Villanova partimmo, di buon ora, con un pullman sul quale avevo trovato un ottimo posto, dietro al posto di guida.
Il viaggio fu ottimo, la compagnia non di meno, l'organizzazione fu eccellente. Giungemmo per primo a Pietrelcina; facemmo un vasto giro nei luoghi in cui visse l'adorato Padre Pio.
Ricordo che, volutamente, rimasi in fondo alla comitiva perché cercavo una maggiore concentrazione per godermi i luoghi sui quali Padre Pio aveva vissuto, volendo camminare lungo le vie sulle quali lui era passato.
Su Padre Pio avevo letto dei buoni libri, mi sembrava di aver già visto quei luoghi, tanto fu dettagliata e precisa la descrizione fatta dagli autori.
Da Pietrelcina ci spostammo a Sant'Angelo, dove non partecipai alla visita del luogo sotterraneo perché soffrivo di claustrofobia.
Di quello stralcio di gita ricordo le impervie strade e le tremende curve che si dovettero affrontare per arrivare in cima a monte Sant'Angelo.
La bellezza del pellegrinaggio fu quella di arrivare a San Giovanni Rotondo e partecipare alla Santa Messa nella vecchia chiesetta e nella immensa chiesa dove è la tomba del Santo Frate; dove don Gianluca concelebrò con altri tre sacerdoti.
Sono stati momenti di vera serenità, ho provato delle strane sensazioni che mi hanno commosso sino al punto di dovermi appartare e dare sfogo alle mie lacrime, perché mi sentivo solo; avrei voluto avere vicino qualcuno di casa.
Ricordo che partecipai a tre Messe, due delle quali, stando vicino alla tomba di Padre Pio, anche se al termine di ogni celebrazione, il pubblico veniva invitato ad abbandonare la chiesa per poter consentire l'accesso ad altre persone.
La notte, dopo aver mangiato in un buon ristorante, collegato con l'albergo, la trascorremmo in una camera occupata da don Gianluca, e dagli amici Amleto Scrimieri e Antonio Talotta.
Poveri amici cari, al mattino mi risultò che nessuno riuscì a dormire perché russai tutta la notte. Comunque l'amicizia che mi fu manifestata quel giorno ha rafforzato certi rapporti che ancora sono vivi e che, mi auguro, continuino per il futuro.
L'altra bella esperienza fu quella avuta e vissuta dal 15 giugno al 18 giugno 2000 in occasione del "pellegrinaggio dei giovani", per il "Giubileo 2000", con la marcia da Viterbo a Roma.
Il grande merito di detta gioia la devo attribuire a due sacerdoti, per primo al caro reverendo don Flavio Valeri, parroco della mia ex parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, del Pilastro, che ha organizzato la manifestazione, con la stretta collaborazione degli amici Arduino Troili e Giuseppe (Peppino) Valeri; ai quali si è unito, don Gianluca Scrimieri, parroco f.f. di Santa Maria del Paradiso, che estese a me l'invito di partecipare che, con tanto entusiasmo, accettai.
Alla mattina del 15 giugno ci trovammo nel cortile sella parrocchia da dove poi ci dirigemmo in chiesa per ascoltare la Santa Messa, celebrata da don Flavio.
Il caro amico Peppino, che conobbi in occasione di un corso neocatecumenale, mi presentò ai partecipanti che, con tanto simpatia, mi accolsero tra loro, come un "vecchio" amico.
Devo premettere che, il giorno precedente partecipammo, nella Chiesa di San Francesco alla Rocca, ad una sacra funzione presieduta dal vescovo di Viterbo monsignor Lorenzo Chiarinelli, il quale, al termine della stessa, ci rivolse parole di plauso per l'impresa programmata e ci impartì la santa benedizione.
Non sono in grado di ricordare i cognomi dei partecipanti, penso che ciò abbia una importanza relativa, racconterò i fatti ed indicherò i nomi, quelli che ricordo, e le zone dove siamo passati, dove abbiamo fatto sosta, dove abbiamo dormito e così via.
Eravamo: don Flavio, don Gianluca, Arduino Troili, Giuseppe (Peppino), Valter, Andrea, Rossella, Girella, Lorenzo, Renato, Mattia, Rita, Katia, Bruno, Armida, Marika, Jacopo, Eleonora, Alberto, Valentino, Fabiana, Maurizio, Enrico, Adriana, Giustina, Massimiliano, Maria, Chiara Aquilani, Simone (il più piccolo), Bruno, (il meno giovane o, come si vuole, il più anziano "io", Emanuela, Viviana, Roberto, Gloria, Clotilde, Flavia, Luisa, Silvia, Roberto, Marika, Mario, Adriana, Roberto, Rita, Serenella, "R", Francesco, Annamaria. Questi nomi li ho rilevati dalle firme che, parte dei partecipanti, hanno apposto sul mio cappellino giallo sul quale era scritto "Giubileo 2000" con il marchio pubblicitario delle "Terme di Viterbo" che, grazie al cavaliere del lavoro Socrate Sensi e figli, abbiamo avuto, in omaggio, unitamente alla maglietta bianca con le scritte "Giubileo pellegrinaggio dei giovani", "Un cammino di fede”.
Con tanta carica nel corpo e nell'anima partimmo dalla Chiesa del Sacro Cuore al Pilastro, avviandoci verso Roma. Davanti al gruppo era, a turno uno di noi che portava la Croce. Canti religiosi, preghiere e tanto entusiasmo erano il carburante che faceva muovere le nostre gambe e "mietere" chilometro su chilometro.
Attraversammo la città di Viterbo seguendo questo itinerario: via Bruno Buozzi, via Signorelli, piazza San Faustino, via Cairoli, piazza del Sacrario, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via san Pietro, via Salicicchia, via Armando Diaz, la strada nazionale Cassia, strada Tobia fino a Tre Croci, dove ci siamo rifocillati e fatto uso dei servizi igienici, messi a disposizione dal Parroco del luogo.
E' da dare atto all'Arma dei Carabinieri che, molto gentilmente, una pattuglia ci ha scortato per tutto il tragitto fino a Bassano Romano; in poche parole avevamo dietro di noi una jeep dell'Arma che con la sua presenza evitava il nostro tamponamento perché camminavamo, sebbene in colonna, sempre su una strada nazionale, di grande frequenza. Dopo una fermata e una bevuta a Tre Croci, la seconda vicinissima tappa l'abbiamo fatta a Cura di Vetralla dove, dopo una scontata, visita in chiesa con la gradita ospitalità del parroco del luogo, ci siamo fermati nel ristorante "Il giardino" dove abbiamo consumato un frugale pasto, a base di spaghetti. La sosta fu breve perché ci aspettava una buona camminata per giungere a Bassano Romano, dove avremmo fatto la tappa notturna e, quindi, avremmo dormito.
Il percorso che abbiamo seguito, per giungere a Bassano Romano, è stato ripercorrere un tratto della via Francigena, tra i floridi campi di nocciole che, a perdita d'occhio, ricoprivano la zona.
Giunti a Bassano Romano, sede dell'Istituto San Vincenzo, abbiamo goduto di una bella doccia, di un cambio d'abito e di un buon piatto di spaghetti, piatto umile, ma buono che sazia facilmente e di un buon secondo con un gustoso contorno e un dolce, offertoci dai religiosi dell'Istituto; il tutto servito a tavola dal simpatico Arduino Troili e da Roberto. Dopo la cena e dopo, una piccola sosta per lo scambio di pareri e dopo aver preso possesso della camera per la notte, ci siamo recati in chiesa dove, tra canti suoni e preghiere abbiamo ascoltato la Santa Messa, celebrata da don Flavio e da don Gianluca, nell'austera chiesa, dove sopra all'altare, è il bellissimo quadro raffigurante il Sacro Volto di Gesù.
Facemmo la Santa Comunione comunitaria, nella forma "Pane e Vino".
Sono stati attimi che resteranno scolpiti nel mio animo, fino a quando Dio mi darà la forza e la possibilità di ricordare. E' un bel ricordare!
Al mattino successivo, dopo aver consumato la colazione, ci incamminammo verso Bracciano, facendo una breve sosta a Oriolo Romano dove il parroco, don Giorgio, ci accolse con affetto e ci dette la possibilità di rinfrescarci e di fare uso dei servizi igienici ivi esistenti.
Una volta giunti a Bracciano, dopo una breve sosta in un locale messoci a disposizione dalla Comunità parrocchiale del luogo, ci fermammo a pranzare; mangiammo dell'ottimo risotto e un secondo, offertoci dalla parrocchia.
Dopo una breve e necessaria sosta ci avviammo verso Cesano dove trascorremmo la nottata in una palestra usando, ognuno, il proprio sacco a pelo. In quell'occasione molti di noi fecero la doccia grazie ad una presa d'acqua per innaffiare il giardino, esistente fuori la struttura che ci ospitava.
Colui che "gestiva" il tubo era, il sempre dinamico Arduino Troili, mentre, di nascosto, c'era un altro amico che ci ha immortalato con la cinepresa.
All'indomani, dopo una buona camminata, attraversando Anguillara, Monte Mario, e giù per la via Trionfale.
Giungemmo in piazza San Pietro dove, con la carica vitale dei giovani appartenenti al gruppo, molti dei quali esperti suonatori di chitarra, attraemmo l'attenzione di molti pellegrini, che fecero cerchio intorno al nostro gruppo.
Prendemmo subito possesso di un spazio sotto il porticato di San Pietro dove ci soffermammo per consumare un pasto a base di pane e mortadella.
A pochi metri dalla piazza, uscendo lungo via della Conciliazione, sulla destra ha sede l'istituto religioso che ci mise a disposizione la palestra dove avremmo poi trascorso la nottata.
Dopo una rifocillata, ci recammo a San Paolo dove abbiamo ascoltato la Santa Messa, facemmo poi ritorno, a mezzo metropolitana, a San Pietro.
Il breve tragitto sulla metropolitana fu disturbato da un furto, subito da alcuni di noi.
Ricordo che avevo un bellissimo marsupio, regalatomi dalla mia figlia Patrizia e dalla nipotina Federica, nel quale avevo messo la macchina fotografica, il portafogli e documenti vari; ad un certo momento sentii uno strappo in direzione della macchina fotografica, che avevo fissato al marsupio, con una doppia legatura. Gridai "al ladro, al ladro" e cercai di afferrare la mano della donna che aveva tentato il furto. In quel momento il treno si fermò, ci fu un certo parapiglia; molte persone scesero nascondendo le persone che avevano tentato il furto.
Solo dopo venimmo a conoscenza che due amici del gruppo avevano subìto il furto del portafogli con somme non modeste.
Questo fatto rattristò, anche se per un attimo, i nostri animi. Al mattino successivo, da Viterbo, ci raggiunsero i genitori di alcuni giovani, facendo così aumentare, sensibilmente, il gruppo che si recò poi a Santa Maria Maggiore, dove ascoltammo la Santa Messa. In quell'occasione alcuni di noi furono intervistati dalla giornalista (L.C) dell'Osservatore romano del 20 Giugno 2000, articolo che riporto integralmente.
"A San Paolo fuori le Mura dopo, tre giorni dalla partenza".
"DA VITERBO A PIEDI 45 RAGAZZI PER UN INTENSO CAMMINO DI FEDE"
"Un cammino di fede, quello percorso dai ragazzi viterbesi lungo le strade del Lazio: un cammino di fede durato tre giorni, durante i quali sono stati percorsi centodiciotto chilometri. Partiti da Viterbo all'alba di giovedì quindici giugno, dopo aver fatto tappa a Bassano Romano prima, e a Cesano poi, nel pomeriggio di sabato i quarantacinque pellegrini hanno raggiunto la loro prima meta: la basilica di san Paolo fuori le Mura. Qui alla vigilia della solennità della Santissima Trinità, seguendo la croce che li ha accompagnati lungo tutto il percorso, la processione dei pellegrini varca la Porta Santa della Basilica ostiense, all'insegna dello slogan che li ha guidati fino a Roma, e che è stampato sulle magliette indossate dai romei: "un cammino di fede, pellegrinaggio dei giovani Viterbo - Roma".
"Lungo tutto il cammino abbiamo fatto una profonda catechesi sul significato della Porta Santa, sul gesto che compiamo, quando decidiamo di ritornare a Cristo", afferma don Flavio Valeri, uno dei promotori dell'iniziativa.
"Abbiamo voluto compiere questo cammino per riscoprire le radici della nostra fede, e ci siamo resi conto che i nostri giovani cercavano proprio questo: in loro, c'è una profonda sete di verità, un forte bisogno di riscoprire e aderire con più fermezza a Cristo - spiega il sacerdote, che ha coinvolto moltissimi giovani in questa impresa -. Il pellegrinaggio è stato organizzato dalle parrocchie del Sacro Cuore al Pilastro e santa Maria del Paradiso, ma si sono aggiunti molti giovani che frequentano parrocchie diverse dalle nostre e anche ragazzi lontani dall'ambiente ecclesiale. Così si è formato un raggruppamento eterogeneo, per età e per esperienza, che in soli tre giorni di cammino si è trasformato in un gruppo di amici veri, di fratelli in Cristo".
Accanto a chi torna in chiesa dopo mesi di lontananza, c'è chi ha scelto di entrare in seminario, alla giovane età di quindici anni: "Ho pensato che forse volevo chiedere a Dio cosa volesse da me... e mi sono messo in ascolto", dice Roberto Vincenti, e la dolcezza della sua voce stupisce quanto la maturità delle sue affermazioni, "non ho ancora deciso di abbracciare la vita sacerdotale, ma se il Signore mi chiama, noi rispondiamo come Maria: eccomi, io vengo!".
Passo dopo passo, la solidarietà ha stretto in un unico abbraccio tutti i pellegrini, dal più piccolo al più grande. "Certo, è stato faticoso seguire il cammino di Gesù, però quando ero stanco, Maurizio mi incoraggiava", racconta la mascotte del gruppo, Simone Cristofari, dodici anni, guardando il ragazzo alle sue spalle. E alle parole di Simone, fa eco la testimonianza di Bruno, uno degli adulti che si sono uniti al pellegrinaggio: "Nel cammino di fede si sono rafforzate l'amicizia e l'affetto con qualcuno che conoscevo, ma soprattutto è nato un legame con fratelli e sorelle veri... in ognuno di loro ho incontrato Cristo". "Loro hanno riempito qualche vuoto che avevo nel cuore, un vuoto creato dalla solitudine. Proprio questa mattina, parlando con il mio amico Peppino, mi sono detto: "Peccato che sia finita!", commenta Bruno Matteacci, sessantaquattro anni, il più "maturo" dei pellegrini.
"Certo il nostro cammino di fede continuerà anche a casa, ma probabilmente si perderà questa sensazione di vera fraternità. Avevo bisogno di esperienza nuova, e l'ho trovata grazie a don Flavio e don Gianluca, i due sacerdoti che hanno reso viso il cammino, con la preghiera, i canti, l'Eucaristia...". La giornata dei pellegrini, infatti, scandita da momenti di preghiera, si concludeva ogni sera con la celebrazione della Messa, vivacemente animata da sei chitarristi, dai cembali, dai bonghi. E domani ci raggiungeranno i nostri cari: i genitori dei ragazzi, i nostri figli per concludere con una cornice stupenda questo magnifico quadro", conclude Bruno, ricordando che il pellegrinaggio continua per le strade di Roma, coprendo a piedi la distanza che separa le basiliche patriarcali di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Pietro, in compagnia di nuovi pellegrini che si aggiungeranno al gruppo.
Mentre la maggior parte dei genitori si ricongiungeranno ai propri ragazzi nella mattinata di domenica, un padre ed una figlia hanno percorso insieme questo cammino di fede: "Ho fatto questo pellegrinaggio perché volevo cambiare, anzi, perché volevo che Dio mi cambiasse nel cuore", afferma Maria Troili. Per lei, quattordicenne dallo sguardo candido, questo viaggio segna in ogni caso un cambiamento, una crescita nel rapporto con papà Arduino: "E' stata veramente un'esperienza meravigliosa, che non dimenticherò mai!".
Non è retorica, ma sentimento d'amore e gratitudine, che fuoriesce spontaneo dal mio cuore, verso don Flavio Valeri e don Gianluca Scrimieri e tutti, dico tutti, i cari partecipanti che mi hanno dimostrato affetto simpatia e fratellanza; è a loro che va il mio sentito ringraziamento, che estendo ai miei cari genitori che hanno, gettato le basi della mia fede religiosa.
L'entusiasmo e il desiderio di stare, il più possibile, con la preghiera vicino ai miei cari mi ha sempre spinto di guardare, serenamente, avanti e di pregare, pregare, pregare; perché questa è la "medicina" che non sbaglia, perché l'unico vero dottore, di cui mi fido, è Lui, Gesù.
Sentendo questa necessità ogni tanto partivo da Viterbo per andare a Roma, a San Pietro; lasciavo la macchina a Porta Romana e con il treno partivo per giungere, dopo cento minuti circa, alla stazione di San Pietro. Fatta una breve camminata giungevo, sereno, in chiesa dove mi soffermavo, in adorazione, davanti al Santissimo, poi giro dopo giro, m' incamminavo verso la stazione per fare ritorno a Viterbo. Fra le tante visite fatte ne ricordo due che hanno lasciato un segno particolare: quella dell'8 novembre 2000 fatta con la parrocchia dei Santa Maria del Paradiso alla guida del reverendo don Gianluca Scrimieri che portò, al Santo Padre Giovanni Paolo II, il quadro della Madonna, esistente nella chiesa per la incoronazione. In quell'occasione avevo il permesso personale n. 27516, rilasciato dalla Prefettura della Casa Pontificia.
Altra visita, che ricordo con tanto piacere, fu quella relativa all'Udienza Generale di Sua Santità Giovanni Paolo II, del 27 ottobre 2004 che feci, grazie al biglietto numero 17112 che mi fu procurato da un sacerdote, che conobbi a San Pietro.
Un'altra volta che sono stato a Roma, a San Pietro, fu in occasione della traslazione del corpo di S. Giovanni XXIII, il Papa buono, quel giorno partii appositamente per assistere alla traslazione dalla tomba, ubicata nei sotterranei di San Pietro, alla basilica, dove ora ogni tanto mi reco a "trovare" il mio Papa buono.
Tanto per rimanere in argomento, ricordo di essere stato un giorno, con don Gianluca a trovare Padre Chiti nell'abazia di Orvieto dove l'ex generale dei Granatieri prima, poi frate cappuccino, aveva riversato tutto il suo amore, la sua fede e la sua pensione, per rendere sempre più accogliente un luogo che andava in malora perché la vetustà dello stabile causava danni a non finire.
Altra bella scoperta la feci, grazie a don Gianluca che mi invitò ad andare, al santuario di Collevalenza che si trova nella mia Umbria, vicino a Todi.
Per cercare la serenità, il silenzio, la pace e la vicinanza a Dio non posso dimenticare il Monastero delle suore della Madonna del deserto e di San Bruno che si trova, nel comune di Gubbio, a Pisciano di Camporeggiano, dove negli anni quaranta, con la mia famiglia ho trascorso, a causa della guerra, due anni della mia infanzia e dove ho frequentato la seconda elementare ed un periodo della terza classe perché frequentai parte dell'anno scolastico a Gubbio e lo terminai a Viterbo.
Comunque non c'è poi tanto bisogno di allontanarsi da Viterbo per trovare luoghi di preghiera di una certa importanza; a pochi chilometri dalla città di Viterbo, in località Palanzana, è l'eremo dei Cappuccini fatto ristrutturare dalla signorina Tommasa Alfieri.
Altro luogo di preghiera l'ho trovato, grazie a don Gianluca, nella chiesa del santissimo Crocefisso che si trova lungo la strada che va da Canepina a Fabrica di Roma, dove ho ritrovato, dopo circa quarant'anni, padre Giuseppe Mercuri, che conobbi a Monterazzano perché era parroco della zona.
Che dire poi della serenità, della bellezza del silenzio che si sente stando in preghiera davanti a Santa Rosa o davanti a sant'Ubaldo?
Comunque, alla base della mia fede religiosa, è la educazione che i miei genitori mi hanno dato sin dalla prima infanzia.
Ricordo la bella tradizione che avevamo, Bruna ed io, nel chiedere ai nostri genitori, prima di andare la letto, la santa benedizione; benedizione che ci veniva data, con l'apposizione delle mani, congiunte, appoggiate sulla testa, con la frase: "Il Signore, che è Dio, vi benedica: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". La benedizione l'abbiamo continuata a chiedere fino a grandi, l'ultima volta fu poche ore prima del nostro matrimonio.
Erano anni in cui tutto si apprezzava, perché poco c'era.
Fino agli anni quaranta avevamo la corrente elettrica a forfait; cioè se si consumava poco, tanto o non si consumava, si doveva pagare sempre lo stesso importo; in più c'era un accorgimento che consentiva di avere, contemporaneamente, l'illuminazione, nelle altre stanze con il predisposto sistema dell'abbassamento di intensità di luce, parziale o totale, in tutte le camere.
In poche parole: se si accendeva la luce in una sola stanza si aveva una forte illuminazione che veniva ridotta, sulla base degli interruttori che si "giravano".
Io che avevo circa quattro anni ed avevo paura di trovare qualcuno sotto il letto, ricordo che appena aprivo la porta della camera accendevo mezza luce; avendo quindi la camera in penombra e poiché, come detto, avevo paura, facevo un salto per andare a nascondermi sotto le lenzuola e, con il cuore palpitante, mi mettevo a pregare; sulla base delle sollecitazioni avute dai miei genitori, che venivano puntualmente a darci il bacio della buona notte e a rimboccarci le coperte.
Era veramente bello; a volte penso che sarebbe stato magnifico essere rimasti "sempre bambini" per continuare ad essere coccolati dai genitori.
Oggi alla mia età, sarò infantile, ma sento che mi manca, tremendamente, una carezza, un bacio, una parola dei miei genitori.
Spesso mi commuovo quando vedo, nei programmi televisivi, l'abbracciarsi di figli con i genitori che da anni non si vedono; dico tra me: "Saranno trascorsi anni, ma oggi hanno avuto la gioia di riabbracciarsi"; io dovrò attendere la mia dipartita, con la speranza di salvarmi, per poterli incontrare!
Questo è uno dei motivi della mia vita, anche se il motivo primario è fare il tutto per i miei figli e nipoti che sono la sicura continuazione della mia vita, della vita dei miei avi che, tramite loro, faranno vivere noi tutti!
Quello che ho pensato e scritto è bello e rasserena il mio animo perché sono più che convinto che i miei cari li rivedrò ed insieme continueremo a vivere per l'eternità, nella gioia, con Dio.
FINE