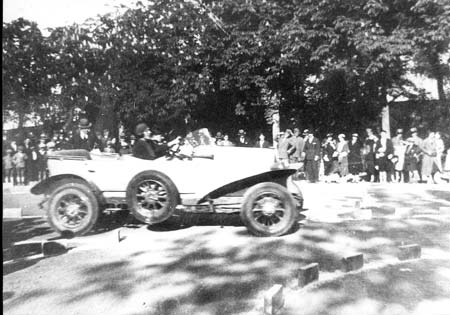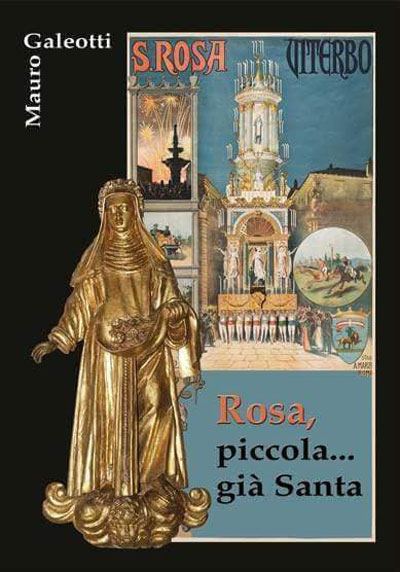Torino STORIA
Oreste Carosi
Avevo già pubblicato una parte di questo interessante racconto, ora lo ripropongo al completo con qualche bella foto. (m.g.)

Il s.ten. Carosi con uno scoiattolino sul braccio caduto dal nido
a Malga Belprato (anno 1952, area Brennero)
Oreste Carosi, autore di questo racconto, è nato a Viterbo ma fin da giovane è emigrato a Torino città in cui ha prestato servizio nelle truppe alpine con il grado di tenente. Successivamente è stato chiamato dalla Società CEAT in cui ha svolto diverse attività finendo la sua carriera come consulente per la materia concernente la sicurezza sui posti di lavoro. Raggiunta l’età della pensione ha dedicato il suo tempo a ripercorrere in lungo e in largo le Alpi Occidentali che sono ancora oggi teatro delle sue lunghe escursioni che prendono il via dal suo rifugio alpino del Sestrière. Non ha dimenticato la vita militare, che ha vissuto con il grado di Primo Capitano, per la quale ha organizzato attività militare di supporto con gruppi di lavoro provenienti dai vari Paesi della Comunità Europea; i risultati ottenuti gli hanno valso il titolo di Cavaliere.
LA VITA MILITARE
Il corso della mia vita attiva è stato quasi per intero occupato dal lavoro in fabbrica e per una minima parte dal servizio militare che, tra prima nomina e richiami, mi ha impegnato per nulla più che quattro anni e tre mesi. Pure, in quel periodo tutto sommato breve mi accade di ricordare più luoghi, fatti e persone di quanti me ne possano essere rimasti attaccati alla memoria di tutto il restante periodo lavorativo.
Non posso dire certamente che uno di quei due periodi abbia lasciato tracce più o meno memorabili dell’altro ma quei pochi anni trascorsi per la gran parte sulle Montagne che adoro (con il cappello in capo con la penna d’aquila che venero) a stretto contatto con ragazzi di leva che ad ogni quadrimestre venivano a riformare l’organico della mia compagnia mortai reggimentale, scaglione dopo scaglione.
Essi hanno arricchito la mia memoria di luoghi fatti e persone di gran lunga più interessanti questi, vivaci e giovani, di quanti abbiano potuto fare successivamente i miei vecchi operai inamovibili dal loro posto di lavoro, un anno dopo l’altro, anche se sempre tanto cari.
Ho parlato di scaglioni riferiti alle classi di leva ma forse avrei dovuto incominciare raccontando, come si faceva con le favole, che in un tempo non tanto lontano da noi i giovani di sesso “inequivocabilmente maschile” giudicati “abili arruolati” dall’apposita commissione e quindi non lasciati da parte perché “scarti di leva” partivano, attorno ai venti anni d’età più o meno allegramente per la Naja e rimanevano per quindici mesi al suo servizio; per la precisione si trattava di quindici mesi a partire dalla metà degli anni cinquanta del secolo scorso. Prima erano diciotto mesi e prima ancora tre anni se non addirittura cinque.
Ho qui sul mio tavolo il libretto personale del Caporalmaggiore furiere Oreste Lupi classe 1864 (mio Nonno materno) che di anni ne trascorse tre presso il 64° Reggimento di fanteria ad Alba di Cuneo, dal 1884 al 1887, mentre so, dopo averlo letto e riletto per la ventesima volta che Edmondo De Amicis nel suo libro intitolato “La vita militare” dice di aver prestato servizio di leva per ben cinque anni al tempo delle Guerre d’Indipendenza sulla metà del diciannovesimo secolo.
Lasciate ora che spenda due parole per presentarvi il De Amicis al quale mi sono permesso di prendere in prestito il titolo all’inizio. E’ più conosciuto da tanti di noi italiani per averci regalato quello che è sicuramente il suo capolavoro intitolato semplicemente “Cuore” in cui si parla di Enrico, giovane studente che è quel che si dice l’io narrante, nonché dei suoi compagni di classe di una scuola torinese, dal buono e saggio Garrone al pessimo Stardi. Sul “Cuore” si possono leggere i cosiddetti “Racconti mensili” dai titoli arcinoti come “Il tamburino sardo”, “La piccola vedetta lombarda”, “Dagli Appennini alle Ande”, “Il piccolo scrivano fiorentino”, “Sangue romagnolo” e altri.
Ogni volta che vado al Roseto della Memoria (luogo ove, come si sa, vengono disperse le ceneri dei cremati) vedo vicinissima, attraverso un cancello divisorio, la tomba della Famiglia De Amicis caratterizzata da una statua che riproduce lo scrittore in piedi, snello ed elegante nonostante le cronache del tempo lo descrivano come un “omaccione dalla testa michelangiolesca, con cappello a larghe tese, baffoni ed una espressione di sereno ottimismo stampata sul viso”. Amava passeggiare sotto i portici di Via Pietro Micca dove i torinesi amavano incrociare i suoi passi per vederlo ed ossequiarlo poiché era già molto conosciuto ed apprezzato come prolifico scrittore tanto che la stessa cronaca non esita a riferire che i suoi libri, soprattutto di viaggio andavano letteralmente a ruba. Nacque a Oneglia nel 1846 e morì a Bordighera anche se, come abbiamo visto riposa a Torino, città ove prestò il suo servizio militare penso come ufficiale di complemento.
Facciamoci dire da lui, per parlare dell’argomento che più ci interessa, come fosse articolata la Naja ai suoi tempi e quanto fosse quella diversa da questa come la ricordiamo noi del ventesimo secolo che l’abbiamo vissuta e sperimentata nei suoi ultimi anni di esistenza e siamo ancora vivi per raccontarla.

Il ten. Carosi osserva la catena del Monviso dalla cima del Monte Palavas (anno 1954)
“La Vita Militare” non è un libro a trama unica ma una raccolta di racconti che potremmo definire bozzetti tenuti assieme da un “filo rosso”, appunto la Naja, con figure, sfondi e sensazioni omogenee.
Prendiamo il racconto intitolato “La madre” dove si parla del fortissimo desiderio di ritrovarsi dopo quattro anni, quattro anni senza l’ombra di un “congedo” (noi diremmo permesso, licenza breve) tra madre e figlio. Lui è partito dal paesello natio del settentrione d’Italia da cui è sceso fino alla Sicilia per rimanervi due anni di stanza col suo reggimento. E’ passato poi nelle Calabrie (si diceva così a quell’epoca) per un anno e successivamente per un altro anno nel Lazio. Adesso sa che la sua adorata mamma viene a raggiungerlo presso la caserma della città in Lombardia entro cui il suo Reggimento rientra stabilmente e lo fa, povera donna anziana e di salute malferma scendendo a piedi dal suo casolare, spinta dallo struggente desiderio di riabbracciare dopo ben quattro anni il suo figlio adorato.
Naturalmente oggi noi non troveremmo accettabile un distacco totale così lungo e sofferto ma se leggiamo il racconto dal titolo “Una marcia d’estate” ci si stringe il cuore pensando alla pesantissima maniera di effettuare a quell’epoca i trasferimenti di unità di fanteria a piedi, per chilometri e chilometri su e giù per l’Italia. Comprensibile l’impossibilità di potersi servire di reti ferroviarie (ancora di là da venire o quantomeno di completare) nonché l’assoluta impossibilità di mezzi stradali (ancora da inventare) e non possiamo toglierci dalla testa l’idea che le lunghissime trasferte del nostro soldatino siano state sperimentate anche da lui, dalla Sicilia alla Lombardia, tanto perché non gli fosse risparmiata nessuna delle tante delizie della Naja.
Senza contare che ci passa per la mente l’idea che quelle terribili trasferte a piedi, d’estate con il solleone e la polvere , d’inverno con il freddo e soprattutto la pioggia, di notte meglio non parlarne, fosse un brutale modo di tenere lungamente impegnati i soldati senza doverli lasciare a bighellonare per i cortili delle caserme o fare “ordine chiuso” in piazza d’armi. Queste situazioni le troviamo confermate in altri due dei racconti che stiamo leggendo insieme: “Una marcia notturna” e “Ospitalità”.
Per fare un timido confronto con i giorni nostri e le nostre esperienze permettetemi di ricordare che in fatto di marce diurne o notturne anche noi del secolo ventesimo ne abbiamo fatte tante: neve, acqua a secchiate in Va Maira o in Val Sarentino; tribolazioni e crisi di sonno a Cappella Hofer in Alto Adige come a Perosa in Val Chisone o in tante altre occasioni e sono sicuro di non essere il solo. All’epoca del De Amicis non si trattava di giornate singole ma di settimane e mesi.
Per quel che mi riguarda personalmente non posso fare a meno di sorridere pensando a quanto lo spirito dei due periodi sia stato diverso dal nostro: per i nostri Nonni sottrarsi all’obbligo di quelle massacranti, interminabili marce equivaleva a rifiutare di avanzare e combattere ostentando vistose uniformi e offrendo il petto al nemico in battaglia e spavaldamente ritti in piedi; per il nostro, nel quale abbiamo imparato a sfruttare il terreno sapientemente e con indumenti mimetici stando defilati quanto più possibile per arrivare nelle migliori condizioni al combattimento.
Se poco fa mi sono sorpreso a sorridere è perché mi tornavano alla mente tanti episodi: di una certa marcia di trasferimento da Borgo San Dalmazzo a Sambuco in Valle Stura da farsi proprio a piedi ma risolta allegramente, direi di nascosto, a bordo di un autobus civile noleggiato per l’occasione; di quell’altra volta che anziché pestare asfalto da Vipiteno a Braies in Val Pusteria per i tre giorni previsti dai programmi ufficiali la mia Mortai prese allegramente il treno e se la cavò con un piacevole viaggio di mezza giornata in ferrovia (sia pure in “terza classe”, che allora esisteva); e ancora a Bardonecchia dove per salire al Colomion da Campo Smith si approfittò della comoda ed economica seggiovia locale.
Naturalmente quei furbeschi episodi non furono mai realizzati di fronte al nemico; eravamo negli anni ‘cinquanta’ e quindi felicemente in pace altrimenti nessuno mi avrebbe salvato dagli arresti in fortezza con l’accusa di debolezza mentale.

La mula ‘provata’ con il suo conducente, alpino Francesco Rosa Clot (anno1954, area Monviso)
Sul libro del De Amicis trovo ora un racconto di carattere autobiografico che mi fa sentire l’Autore, anche lui ufficiale di complemento come sono stato io tanti anni dopo di lui, vicino come se lo ascoltassi parlare con la voce dei vivi e non con quella da lui scritta su queste pagine.
S’intitola “L’ufficiale di picchetto” e nel leggere le sue frasi ritrovo con un certo senso di disagio tutto il fastidio che era legato a quell’incarico periodico cui ero tenuto essendo sottotenente.
Alla Caserma Monte Grappa di Torino di ufficiali subalterni ce n’erano pochi e quindi anche i marescialli erano costretti a fare i turni come noi, due, anche tre volte in un mese e siccome le tabelle degli avvicendamenti le combinava alla Maggiorità un impiegato con il loro grado, inutile dirlo: a me capitava con fastidiosa frequenza il sabato e tutte le feste comandate a partire dal Santo Natale.
Avevo un bel protestare ma con il fatto che ero “giovane” e soprattutto non ancora sposato non avevo via di scampo. Anche dopo il matrimonio la situazione non cambiò di molto e dovetti adattarmi ad accogliere la sposina che usciva dall’ufficio e passava a trovarmi ogni sera per poi proseguire da sola verso la nostra casa. Ci appartavamo per qualche ora nel deserto circolo ufficiali sempre e comunque col timore che l’ufficiale d’ispezione o il colonnello comandante avessero bisogno di me. A parte questa situazione di fondo però, non mi capitò mai di farmi sorprendere “in mutande” (come s’usava dire) da nessuno, specialmente durante le ore notturne durante le quali la stanchezza o il freddo mi tiravano nella stanzetta riservata al mio servizio; al massimo mi concedevo pochi minuti di pausa sopra quel letto senza assolutamente spogliarmi, con stivaletti, cinturone, pistola , sciarpa azzurra addosso ed il cappello alpino appoggiato sul naso. Di quei fugaci decubiti serba tracce evidenti la sciarpa azzurra che mi ostino a conservare per ricordo anche se oggi è ridotta ad uno straccio. Lasciato ordine perentorio al piantone (che dopo il contrappello ha abbandonato la sua garitta fuori del portone e con fucile a ‘bracci-arm’ trascorrerà le due ore del suo turno a passeggiare su e giù lungo l’androne) di avvertirmi tempestivamente perché io possa far fronte a qualsiasi evenienza, vispo e arzillo come richiesto dal regolamento secondo il quale è mio compito girare quasi tutta la notte per i circoli e le camerate, controllare che i cancelli e le porte che dovrebbero essere chiuse lo siano senza eccezione e non mancare di passare dalle scuderie dove dormono in piedi, secondo il loro costume, i nostri bravi muli (ne ricordo ancora tanti per nome: Provata, Quero, Quassio, Quanomala, Girone, Indacono, Etrusco ed altri ormai dimenticati (e me ne dispiace); ritti in piedi e come loro un alpino “conducente” con la ramazza in pugno, come prescritto dal regolamento, per tenerli d’occhio perché i muli hanno il vizio di farsi dispetti e magari si scambiano calci sotto le stanghe che li tengono divisi.
Al levar del nuovo sole l’ufficiale di picchetto ha controllato che il piantone si sia trasformato in sentinella sulla pedana davanti alla garitta fuori del portone e impugni il fucile, con la baionetta in canna, sulla posizione di ‘pied-arm’ pronto a scattare sull’‘attenti’ o sul ‘presentat-arm’ a seconda del grado di chi comincia a presentarsi per entrare in caserma. Naturalmente il nostro ufficiale di picchetto ha provveduto in perfetto orario a far suonare la sveglia dal trombettiere che fa parte del corpo di guardia e che successivamente si deve tenere pronto a scandire a suon di tromba tutti i segnali relativi alle varie attività della giornata: dall’ ‘alza bandiera’ al ‘silenzio’ e se necessario a trasmettere ordini rivolti alle singole compagnie presenti in caserma ciascuna della quali ha la propria sigla (la sigla della mia Compagnia era espressa da una breve sonata che tutti interpretavano come “Mortai vien giù- Mortai vien giù” e l’eco di quelle note lontane che nessuno suonerà mai più mi dà il magone). Naturalmente subito si provvedeva a spedire qualcuno al corpo di guardia per sentire cosa ci fosse di nuovo.
Il racconto di De Amicis che qui ho finito di leggere si chiude con la figuraccia che il giovane protagonista fa al cospetto del capitano d’ispezione che lo ha sorpreso beatamente svestito dentro il letto di cui ho parlato poco fa e, mi dispiace per lui ma doveva essere molto giovane e inesperto per comportarsi in maniera tanto ingenua; poteva prendere esempio da me anche se il secolo e mezzo che ci divide vale all’incontrario e soprattutto è troppo lungo.
Lascio il libro che ha dato il titolo a questa nostra chiacchierata e rientro in caserma per dilungarmi un po’ col vostro permesso a parlare del fucile che la sentinella (il ‘piantone’) di cui ho fatto cenno poco sopra ostentava il possesso. Per quanto oggi sia fuori moda e di pessimo gusto parlare di fucili ed affini non posso nascondere che di simili manufatti m’interesso con grande piacere da tempo immemorabile, forse da sempre, ed amo imparare a conoscerli anche nella più intima loro essenza, magari più da meccanico orologiaio che da fuciliere.
Ecco la nostra arma che abbiamo visto in mano alla sentinella del corpo di guardia al tempo di De Amicis: un lungo e pesante Vetterli, vale a dire un’arma a retrocarica a ripetizione ordinaria e colpo singolo, che alla metà dell’ottocento si poteva dire moderna dopo l’infinita successione di tentativi e di brevetti che, partendo dalle prime armi da fuoco portatili ad avancarica (come schioppi, archibugi, focili e simili) lo avevano preceduto. Ovviamente più moderno di quello fu il fucile Mannlicher-Carcano, più noto a noi come “Novantuno” con cui il nostro esercito si equipaggiò alla fine dell’ottocento e che fece il suo bravo dovere, sia pure con alterne vicende, nel corso delle due Grandi Guerre fini al termine della seconda di esse nel 1943 dopo di che fu mandato a riposo.
Presto uscì dalla nostra memoria fino a quando un esemplare del suo modello, il moschetto “91/38”, servì ad un attentatore americano per uccidere il Presidente americano Kennedy.
Per quanto riguarda la mia esperienza personale, se v’interessa saperlo, ho “giocato” da ragazzino come balilla nel suo formato ridotto calibro 22 con tutto il suo rosario di descrizioni tecniche che avevamo imparato a recitare da dodicenni ai campi-scuola: ‘cane con guida’, ‘manubrio con noce’, ‘tubetto con nasello’, ‘molla a spirale con trentadue giri e mezzo’, ‘cassa calcio’ e fornimenti vari.
Ritrovai il novantuno alla Scuola Allievi Ufficiali di Lecce ma solamente stampato sulla dispensa di Armi e Tiro giacché nella realtà mi fu assegnato un nuovissimo Enfield che gli inglesi, dopo averci vinti in guerra, avevano dismesso e lo avevano rifilato a noi italiani: tanto nuovissimo che il mio esemplare aveva incisa sul castello la data 1918. Comunque andassero le cose la carriera del fucile inglese presso il nostro Esercito si esaurì nel giro di pochi anni fino a quando nella primavera del 1952, mentre per fare una cosa nuova ero di picchetto alla Monte Grappa, giunse l’ordine di mettere in soffitta l’Enfield e di armarci con il Garand americano. Era il giorno della Santa Pasqua, incongruo messaggio di pace.
Per quel che riguarda le uniformi posso dire di aver assistito nei pochi anni di permanenza sotto la Naja ad una radicale e soprattutto razionale evoluzione dell’uniforme da indossare in marcia, in addestramento o in libera uscita; lasciato il grigioverde “dei nostri padri” (ma anche dei nostri fratelli maggiori) con le ‘fasce gambiere’, le ‘pezze da piedi’, il ‘chepì’ prima e la ‘bustina’ poi, alla Scuola A.U.C. di Lecce ci trovammo a vestire esattamente come il maresciallo inglese Montgomery così come ce lo mostrarono in tutta la sua gloria i documentari alleati all’inizio degli anni quaranta con una divisa di panno caki con giubbetto stretto in vita, un paio di ghettine di tela sopra i pantaloni a tubo e in testa non proprio un basco come aveva lui ma una bustina come quella dei pizzaioli italo-americani. Niente più buffetterie in cuoio (‘cinturone’, spallacci’ e ‘giberne’) ma tutte di tela anche quelle; in compenso per l’addestramento non avevamo bisogno di sporcare nessuna delle due uniformi in dotazione (da fatica e da libera uscita) perché c’era la tuta da combattimento allorché si doveva strisciare “tatticamente” sul terreno facendo il passo del leopardo, del gatto, del gattino e di tanti altri animali (che cerco di dimenticare) per confonderci con la natura secondo i fondamenti del mimetismo. Peccato però che i suoi colori sfacciatamente rossicci finivano per ottenere l’effetto opposto rendendoci più visibili che mai e poi c’erano i due tasconi sul petto privi di patta e aperti a tutte le intrusioni: ad ogni strisciata si riempivano di terra e sassolini come può fare la pala di una ruspa.
Chiudo l’ultima pagina del libro di De Amicis dedicato alla Vita Militare per l’ennesima volta, poiché ho cominciato a leggerlo e rileggerlo che ero ancora bambino visto che era uno dei miei preferiti tra quelli delle libreria di casa e parlava con una lingua - italiana - assolutamente in accordo con lo spirito “patriottico” che allora aleggiava nel nostro Paese (ben prima del cosiddetto ’ventennio’).
A partire per fare il soldato, ovviamente a otto o dieci anni d’età, non ci pensavo affatto né le vicende conosciute nel leggere quel libro in fatto di reclute , ufficiali di picchetto e gravose marce mi lasciarono mai rattristato, tutt’al più curioso e curioso rimango dopo tanti e tanti anni nel chiedermi quando e quanto i giovani d’oggi (e le loro “mamme vincitrici”) si renderanno conto di aver perduto rinunciando al privilegio di andare di leva. Tendo l’orecchio e mi pare di sentir provenire dalle parti di Alba di Cuneo un canto di voci giovanili: “Piùre, piùre fje – c’a l’éve bin rasùn – ‘l susanteset va vie - piùre per dabùn” (Piangi, piangi figlia, ché ne hai ben ragione, il ‘sessantasette’ va via, piangi davvero…)
Sono le voci dei coscritti della classe 1864/67 insieme con quella di mio nonno Oreste che tornano a casa in congedo “illimitato” dopo tre anni di Naja.
Dai cinque anni deamicisiani ai quindici della mia generazione il peso della vita militare sulle spalle degli italiani usciti di adolescenza è andato gradatamente allontanandosi fino a scomparire del tutto a partire dal primo gennaio 2005.
Adesso chi dei giovani sente il bisogno di recidere il cordone ombelicale che lo trattiene alla famiglia può scegliere di farlo di propria iniziativa purché non gli manchi il coraggio di affrontare la vita contando solamente sulle sue sole forze. Naturalmente il tepore delle coltri domestiche esercita una forza d’attrazione assai dura da vincere e poi fuori “piove”, fa freddo e bisogna munirsi di ripari adeguati, mentre “dentro” basta allungare una mano e trovare un letto accogliente e una tavola imbandita.
Niente di più facile quindi ignorare quella tale legge di natura che è alla base della maturazione animale e vegetale che spinge l’albero a spargere lontano da sé, per facilitarne l’indipendenza, i semi che formeranno la sua discendenza.
Per completare il quadro delle considerazioni sui fattori positivi o negativi della leva militare che interessano il nostro giovane è necessario pertanto avere ben presente l’entità della rinunzia ad allacciare contatti umani fuori della ristretta cerchia natale. Purtroppo la nostra relativamente recente unità nazionale non ha provveduto a facilitare tale importante scelta mentre sentiamo purtroppo il bisogno di cantare tuttora nel nostro Inno le parole dell’esortazione ad unirci contro un passato che ci vide“…calpesti e derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi” e talvolta non è raro scorgere sotto il soprabito un lembo del vestito di Arlecchino che ne affiora.
Oreste Carosi