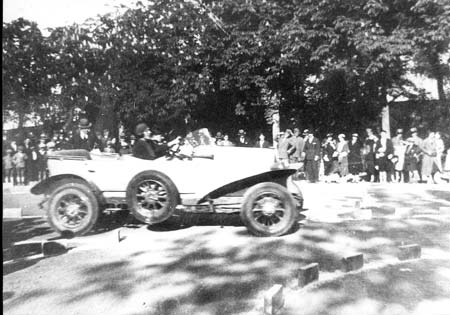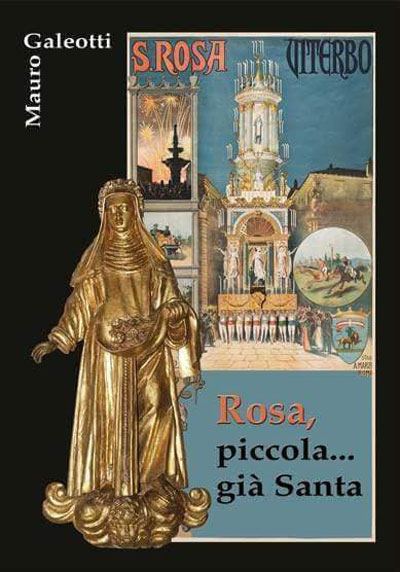Viterbo STORIA
Andrea Allegranti

Caro Mauro,
dalla lettura de “lacitta.eu” mi sono reso conto che gli anni della Seconda guerra mondiale stanno interessando oltre me, che li ho scelti per un racconto, anche molte altre persone che ti inviano storie e documenti per la pubblicazione.
Fra queste persone c’è il triestino Andrea Allegranti, persona di notevole esperienza e cultura, che ho conosciuto mentre in agosto era turista nel viterbese e del quale mi pregio di essere diventato amico.
Il signor Allegranti, coinvolto in una conversazione proprio sugli anni 1943/1945, ha condiviso con me considerazioni e giudizi sugli avvenimenti di quel periodo e, qualche giorno fa, su mia sollecitazione, mi ha dato da leggere una sua personale interpretazione del testamento spirituale di suo padre, uno che gli avvenimenti della Seconda guerra mondiale ha vissuto direttamente. Quel racconto mi ha affascinato per l’efficace sobrietà, per la ricchezza delle notizie, e per la capacità di coinvolgermi.
Si tratta di un ottimo brano di narrativa che merita di essere conosciuto. Ho chiesto l’autorizzazione per pubblicarlo e, avendola ottenuta, te lo invio sperando che tu lo gradisca e che lo leggano volentieri anche gli utenti del tuo giornale.
Agostino G. Pasquali
Mio padre, racconto in forma di testamento spirituale, di Andrea Allegranti
“Caro bambino mio, sento le forze abbandonarmi e vorrei lasciarti nella maniera più chiara un pensiero che mi sta a cuore. Posso dirti che lo ritengo importante perché è il risultato della più profonda analisi che son riuscito a realizzare in vita mia e che voglio trasmetterti perché tu possa, se lo riterrai, farne tesoro. Nulla di originale, ma una considerazione presa in piena coscienza.
Come di certo sai, nacqui con una malformazione cardiaca che hai ben conosciuto per le lunghe degenze a cui mi ha costretto una volta avanti con gli anni. Un difetto che per tutta la vita mi ha causato dolori e sofferenze a intermittenza, un paio d'anni tranquilli, seguiti da lancinanti dolori articolari che svanivano improvvisi, infiammazioni ovunque che poi sparivano senza lasciar traccia.
Anche da bambino ne soffrivo, ma mi lasciò crescere come crescevano tutti, tra scuola e pallone, esercitazioni da balilla e le storie di mio padre, nonno Armando.
Da eroico caporale sul Carso, nel '16, egli “”con sprezzo del pericolo andò solitario all'assalto di un nido di mitragliatrici nemiche neutralizzandole col lancio di due precise granate”” come dice la motivazione, si guadagnò una grossa medaglia.
Due bombe le cui schegge però lo costrinsero a lunghi mesi d'ospedale, all'uso di un bastone e, ogni due anni finché visse, a dolorose operazioni per l'estrazione dei frammenti che riaffioravano sui glutei e sulla schiena come minuscoli nei bruni.
Storie impressionanti per un bambino impressionabile com'ero.
Nonno Armando è stato un fascista della prim'ora che nella lotta coi rossi a Firenze ci rimise il salone da barbiere in piazza, distrutto dal fuoco di una rappresaglia. Convinto a cambiar aria, con moglie, una figlia e due maschi, decise per l'Egitto, imbarcandosi a Trieste.
Destino volle che un'epidemia di colera nell'Egitto in subbuglio di quegli anni lo costrinse ad attendere nella città giuliana che le acque si placassero e che l'epidemia si esaurisse.
Un ufficiale conosciuto in guerra, in servizio in una caserma cittadina, lo incontrò e gli offrì la gestione della barberia della caserma. Così, questi fiorentini in fuga si stabilirono a Trieste e vissero il “”fascismo di frontiera””, violento ed “”eroico””, votato a misurarsi con gli ostici vicini slavi e la forte loro “”minoranza”” che nei territori appena conquistati in realtà costituiva ampie maggioranze quasi ovunque.
Lo sai, son nato nel '19 e per me Firenze è solo un vago ricordo di bimbetto.
A Trieste crebbi. Scuole, giochi, ristrettezze come per tutti.
Ricordo al panificio di via S. Michele la “zonta di pan de fighi” per me piccino e goloso.
Mio padre si pavoneggiava col suo bastone con il pomello d'argento e i suoi modi raffinati. Nonna Ida ci accudiva e il negozio ci manteneva. La Luisa, la mia amata sorella, con sei anni più di me, si impiegò in un negozio di stoffe contribuendo al bilancio famigliare.
Ricordo innumerevoli sfilate e tante medaglie alle Olimpiadi. Fummo Campioni del Mondo per ben due volte. La Triestina ci esaltava e competeva alla pari con Milan e Juve.
Trieste sportiva vinceva nel basket e nel nuoto. Io, preferivo stare in porta ed ero abbastanza bravo e tuo zio Luciano, il mio fratellino minore, nato a Trieste nel '23, all'attacco.
Ci difendevamo sui campi di calcio e in atletica coi lanci, ma i miei dolori mi tormentavano ad ondate e, in quei momenti, ora le mani non riuscivano a trattenere il pallone e a lanciare il giavellotto, ora erano i piedi a farmi urlare. L'Italia era grande e si faceva valere nei cieli e sul mare.
Il Duce arava, forgiava e mieteva, illuminava un popolo pronto al riscatto. Io ci credevo perché in casa, a scuola, in città e alla radio era tutto un tripudio esaltato.
Le folle immense era tutto ciò che conoscevamo e nessuno sembrava dubbioso o contrario e le nostre teste guardavano, ma non vedevano, ascoltavano, ma non capivano. Eravamo una sola onda spinta da un forte vento che sembrava non trovare ostacoli, e che sarebbe andata ad infrangersi su solidi scogli non lo sospettavamo.
Vennero i primi lavoretti e le prime esperienze adulte, ma la cartolina mi richiamò in Puglia nella mitica Aeronautica che mi fece marconista e mitragliere sui bombardieri. Un corso supplementare mi istruì sulle previsioni del tempo e mi sentivo felice di consultare qualche strumento, di guardare il cielo e le nubi, le stelle e il vento, ma soprattutto di giocare d'intuito e di sognare ad occhi aperti.
Quel fatidico 10 di giugno, il giorno della dichiarazione di guerra consegnata agli ambasciatori di Francia e della “”perfida Albione””, quel dì avrei quasi finito i miei due anni di leva, ma fui trattenuto in servizio, felice a quell'annuncio di potermi dedicare alla grandezza d'Italia.
Furono missioni di pattugliamento sul Mediterraneo centrale partendo dalla Sicilia, quindi voli di protezione ai convogli per la Libia e per la guerra d'Africa. Lo stormo operò su Malta e su obiettivi strategici in Cirenaica e fu attaccato parecchie volte dai validi e temuti caccia Hurricane inglesi. Praticamente in ogni missione perdevamo un paio di apparecchi e la carlinga di tutti tornava perforata in più punti.
Vennero tempi duri e lo stormo fu ricostituito più volte con nuovi aerei e nuovi equipaggi.
I BR20 presero il posto dei vecchi Aermacchi, ma nulla cambiò; quel ronzio assordante nella carlinga era lo stesso e io, il marconista, continuavo a pigiare i tasti del Morse, a comunicare alla radio e a usare la mitraglia ausiliaria coadiuvando i piloti e il mitragliare del bombardiere mentre lo sportellone centrale si apriva seminando morte e paura.
Incominciò a farmi male il petto. Sentivo un'oppressione allo sterno, una stanchezza abissale e una certa difficoltà a respirare. Ma non marcai mai visita perché sentivo come mio dovere non tirarmi mai indietro. Scrivevo il mio diario e mi sentivo fortunato per ciò che facevo e che mi veniva richiesto di fare.
Il mio fratello maggiore, tuo zio Pino, era nella Brigata Sassari e Luciano, il “”triestino””, divenuto centravanti della giovanile della Triestina stava per essere arruolato in Marina e per imbarcarsi su un incrociatore di scorta ai convogli per Tripoli.
Tre fratelli, tre armi e tre storie per un'unica guerra multiforme e globale che ha messo a nudo la miseria dell'uomo, l'incertezza dei suoi valori e la disperazione della sua condizione.
Attaccammo la Grecia, occupammo l'Albania e dagli aeroporti pugliesi lo stormo martellò Joannina, Patrasso e l'Epiro. Gli obiettivi adesso erano le stazioni ferroviarie, le caserme, i concentramenti di truppe. Ma vennero anche i bombardamenti indiscriminati in cui scaricavamo le bombe ovunque, sulle città e sui paesi.
Nel diario iniziai a trascrivere opinioni meno entusiaste. Alcuni cenni infatti fanno trasparire ombre di dubbi e i toni usati sembrano andar smorzandosi.
Venne l'attacco alla Jugoslavia e l'occupazione della Slovenia e del Montenegro.
I bombardamenti cambiarono gli obiettivi a sostegno dell'amica Croazia unendo gli sforzi con l'alleato tedesco con cui condividevamo anche gli aeroporti. Missioni miste assieme ai micidiali Stukas per contrastare e contenere l'insolita guerra partigiana che in quei Balcani vedeva un po' tutti contro tutti.
Non vidi, né sospettai le carneficine che quella guerra provocava. Non seppi di come noi occupatori ci macchiammo di crimini efferati e indiscriminati su tutto quel fronte privo di prime linee e diffuso ovunque; “”banditen””, stragi e rappresaglie. Ma bombardare villaggi e città senza un nemico con una divisa, ma un popolo con mille divise e solo una stella rossa a distinguerlo non è una guerra, è qualcos'altro e incominciavo a rendermene conto.
Credo di possedere una specie di record. Ho partecipato a un numero notevole di missioni di guerra, senz'altro molte più della media di un aviere che ha elevate probabilità d'essere abbattuto. Il mio stormo è stato decapitato almeno una decina di volte, ma il mio aereo, sebbene crivellato e talvolta anche con principi di incendi, è sempre rientrato alla base e alcune volte con amici a bordo feriti e anche morti. Ero o forse eravamo come baciati dalla fortuna e ho accumulato parecchie croci di guerra, croci che venivano “”guadagnate”” ogni tot di missioni portate a termine, medaglie alla fortuna, direi, non certo al coraggio.
Fui destinato all'aeroporto di Grobnico, vicino a Fiume, dove, senza assolutamente saperlo, vidi colei che cinque anni dopo sposai e divenne tua madre, quindi fui trasferito vicino a Mostar in un aeroporto condiviso con la Luftwaffe.
Era l'estate del '43.
Il fascismo cadde e l'aeroporto passò al comando tedesco.
L'8 settembre ci sorprese impreparati e il 10 i tedeschi ci disarmarono e pieni di disprezzo ci fecero prigionieri.
Ti confesso che provai vergogna per il salto di campo e per i modi di quel voltafaccia, ma il dubbio insinuatosi di essere stato in qualche modo ingannato da tempo e di non essere stato in grado di pensare da me, quel qualcosa che era poco più di una sensazione incominciò ad attutire il disagio, quasi accennando a un lieve moto di orgoglio per la scoperta che anch'io potevo farmi un'idea su quella catastrofe in cui mi sentivo più che avviluppato. Eravamo in una situazione spaventosa, ma in un certo senso benvenuta.
Iniziò un vero calvario.
Il tempo si fece cupo e il sole sembrava non voler più portare tepore.
Fummo rinchiusi nei carri bestiame - cento per carro - e le porte furono piombate. Una settimana, forse, di viaggio senza sapere dove si stava andando.
Soste continue e una brodaglia come cibo. Una puzza incredibile e urla e pugni per i bisogni e per vuotare il bidone che ci ammorbava. Mancava l'aria e tutti eravamo con gli occhi sbarrati a guardare la nostra miseria con la testa come svuotata. Scoprimmo di riuscire a dormire anche stando in piedi, schiena contro schiena. Eravamo tutti nella nostra propria divisa e con solo poche cose nelle tasche, nella giubba e in uno straccio annodato a mo' di sacco.
Ci dissero che eravamo arrivati a Bad Horb, in Assia.
Il campo si rivelò una metropoli con migliaia di prigionieri di ogni provenienza, torturati dalla fame, dopo qualche settimana, dal freddo e, fin da subito, dal lavoro cui erano destinati. Quelli trattati peggio erano i russi, ma anche con noi italiani non si scherzava.
Venivamo affittati o venduti o assegnati a ditte, istituti, imprese che si assumevano la responsabilità del nostro controllo, non sempre coadiuvati da militari, ma da una specie di milizia civile che a sera ci riportava al campo.
Ricordo quando la gente ci riconosceva come italiani, gli sguardi di sprezzo e anche gli sputi di una giovane donna con gli occhi spiritati. Ricordo la voce di quel vecchio caporale che ci svegliava al mattino urlando in dialetto “”Austen! finf'hur moje”” - “”alzarsi! sono le 5””.
E ricordo come un incubo le lunghe attese per l'appello mattutino e per quello serale, la lotta per il pane, la minestra e la patata al giorno che ci veniva assegnata.
Ricordo la lotta per raschiare il barile della brodaglia.
La fame era attutita solo dal caso. Succedeva infatti che quando si era assegnati alla rimozione delle macerie, a Francoforte o in altre città colpite dai continui devastanti bombardamenti, diurni da parte degli americani e notturni ad opera degli inglesi, ed era stato colpito un edificio con un forno o un negozio o un deposito e si trovavano i resti di qualche “”mattone”” di pane nero o qualche patata, la si nascondeva e la si portava a sera alla baracca per cuocerla nella stufa, accanto alle braci.
Un tozzo di pane o poche patate o qualche barbabietola da poter usare come merce di scambio in alternativa a quel denaro “”ufficiale”” costituito dalle poche sigarette che venivano distribuite, cicche che servivano per i baratti e così per la nostra sopravvivenza.
Sigarette pestilenziali che costituivano l'unico svago e lusso ammesso in quei tristi frangenti.
C'era gente che si toglieva i ponti d'oro dalla bocca per un pacchetto di quella schifezza.
Ricordo anche l'esaltazione quando si catturava un topo e finalmente c'erano proteine di cui la nostra “”dieta”” era carente riservandoci solo mezza salsiccia alla settimana.
Ti sembrerà strano, ma grazie a una convenzione internazionale rispettata dai tedeschi potevamo scrivere a casa e ricevere pacchi e lettere. Ovviamente tutto era censurato e quelle poche cose che arrivavano erano come una manna.
Fino alla primavera del '44 potei far sapere a casa che ero vivo e prigioniero e due pacchi di generi di conforto mi giunsero inattesi.
Vennero i repubblichini fascisti e cercarono di arruolarci, ma sui circa 5000 italiani del campo solo un paio si convinsero a tornare a combattere e tutti gli altri si rifiutarono.
Ad aprile, assieme agli altri fui trasferito in Francia, in Alsazia, prima a Toul quindi a Remeringen per costruire ostacoli anticarro in supporto a una linea difensiva al di là del Reno.
Il mio piede sinistro iniziò a farmi assai male e quasi non potevo muovermi che saltellando sull'altro piede, aiutato dal mio amico Giordano Miloch, un altro triestino con cui ho condiviso lunghi momenti di quella prigionia.
La primavera con la sua aria pulita, i suoi profumi e i suoi fiori contrastava col mio stato d'animo sfiduciato.
Dopo il 6 di giugno sapemmo dello sbarco e si iniziò a parlare della necessità di un ennesimo trasferimento verso est. Il mio piede mi angosciava. Durante una sosta del lavoro, io e Giordano, conoscemmo una famiglia di contadini francesi e concordammo con loro l'eventualità di essere nascosti nel caso ci fosse stata una possibilità di fuga.
Gli alleati avanzavano lentamente e verso ottobre arrivò l'ordine di sgombero. Ci attendeva una marcia forzata di giorni o settimane, uno sforzo che per me sarebbe stato fatale. Non potendo seguire gli altri sarei stato sicuramente eliminato.
Un giorno brumoso, fatto l'appello ci fu intimata la partenza.
Ero terrorizzato.
Passando vicino a quel campo, il campo di quei contadini, io e Giordano ci scostammo furtivamente, nascondendoci non visti dietro un muretto e lasciammo così la compagnia.
Tremanti raggiungemmo la fattoria e quei benedetti contadini che senza dir parola ci nascosero in un pagliaio e ci rifocillarono per più di una settimana.
Si era alle porte dell'inverno e al mattino il freddo era pungente.
All'arrivo degli americani ci presentammo nella nostra bella lacera divisa come prigionieri italiani fuggiti dal lavoro coatto.
Il risultato fu che ci misero in un campo di concentramento alleato assieme a migliaia di altri prigionieri, tedeschi, ucraini, bulgari, rumeni, ungheresi, polacchi, croati, serbi, cechi, slovacchi, anche russi e altri italiani, un vero campionario di occhi, idiomi, stature e culture, tutti combattenti del Reich o sfuggiti alle grinfie tedesche come noi due. Con tutti costoro dividemmo una prigionia inoperosa, ma altrettanto terribile della precedente e per certi aspetti anche peggiore.
Una mancanza al campo tedesco era punita severamente, anche con la morte. Nel campo americano, dove la fame era la stessa, ma aveva un altro sapore, si moriva legati a un palo, nudi, anche con parecchi gradi sotto zero in quel freddo inverno continentale, per le stesse mancanze di prima.
Non ci massacrava il lavoro, ma l'inazione forzata, il vegetare senza senso con la tortura delle adunate, degli appelli, delle punizioni e delle urla, ora sbraitate in inglese.
Non ho ricevuto pacchi né lettere e non ho potuto scrivere a nessuno. Di me a casa non si aveva notizia alcuna.
La guerra è finita a fine aprile, agli inizi di maggio, quando le pergole profumano di glicini ed esplodono i lillà e noi italiani, considerati prigionieri di guerra degli alleati, siamo tornati a casa a fine estate dopo più di un mese passato al Brennero come bestie all'ingrasso, rimpinzati di pasta e cioccolata per riportarci al nostro peso.
Son tornato a casa con 60 kg. Il limite a cui ero giunto credo fosse attorno ai 50 kg. A fine anno ho ripreso il mio peso forma, 70 kg buoni.
Che emozione il ritorno! La città in quell'agosto torrido era un'altra ed era governata dagli inglesi. Feci fatica ad orientarmi e a trovare la strada di casa.
Scorsi mia madre alla finestra e le corsi incontro. Luisa era sposata e via da casa.
Pino era già tornato dalla Jugoslavia sul finire del '43. Papà lavorava con lui all'Arsenale. Di Luciano non si sapeva nulla.
Lucianino non dava sue notizie ormai da anni, ma tornò nel '46 come un miracolato, a gennaio.
Era stato fatto prigioniero dagli inglesi dopo l'affondamento del suo incrociatore e tenuto in Sardegna fino allora. E' tornato robusto e comunista, una vera forza della natura e fu soprannominato Ursus come l'enorme gru che operava al porto fino a pochi anni fa.
Ecco mio caro figliolo, uno spaccato di quasi otto anni della mia vita, dai 18 ai 26 anni. Anni difficili e terribili che mi hanno cambiato insinuando nelle mie assolute certezze quei sani dubbi che soli possono formare veramente un uomo.
La cosa che mi preme dirti sta proprio nel valore del pensiero critico, nella fiducia nel proprio spirito di osservazione, nella certezza della propria analisi intellettuale pur nella coscienza dei suoi tanti propri limiti.
La verità non viene impartita come una benedizione, ma va conquistata sforzandosi di comprendere le dinamiche degli eventi.
Un'educazione che trascura lo sviluppo di questi strumenti non aiuta il formarsi delle opinioni, ma rende passivi e pronti ad assumere quelle più urlate e quelle di tutti.
Così, se un giorno sarai genitore ricorda che la cosa più importante che potrai donare sarà l'esempio che saprai dare e se genitore non sarai mai, poiché i figli son di tutti e ci vengono solo affidati, a maggior ragione oggi che nessuno saprebbe vivere da sé essendo la conoscenza pratica un patrimonio collettivo, ciò che sarai sarà comunque quell'esempio che saprai dare e la coerenza sostanziale del tuo agire.
Quel dubbio che iniziò a insinuarsi quando mi resi conto di quanto stavo facendo e stavamo facendo sganciando bombe sui nostri simili che si voleva vedessimo come nostri nemici non ha cambiato le mie convinzioni, ma le ha create.
Prima, semplicemente, non ne avevo di mie, ma le prendevo in prestito acriticamente.
Da quel momento sono cresciuto e sono quello che sono, con i miei pochi pregi e i molti difetti come si deve dire, ma sono io, sono le mie di idee, quando ci sono, idee che non voglio più mi siano date, ma che voglio scegliere.
Papà“