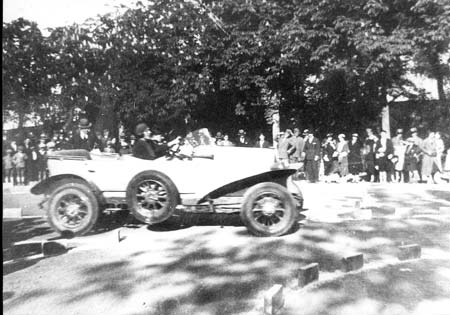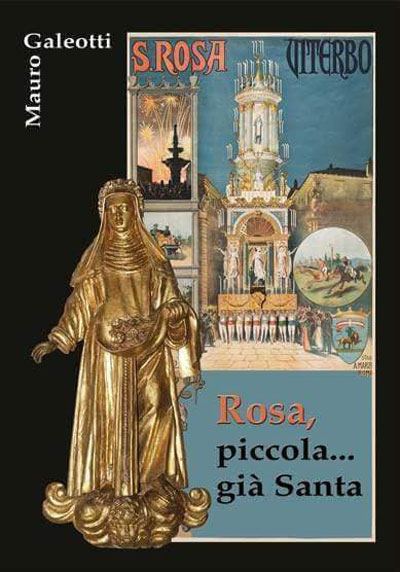Viterbo IL RACCONTO
Viterbo IL RACCONTO
Agostino G. Pasquali

IL RACCONTO: Schüttelbrot a Natale 1943 – Seconda serie. Prima puntata – Seconda puntata - Terza puntata - Quarta puntata - Quinta puntata - Sesta puntata - Settima puntata - Ottava puntata - Nona puntata
In viaggio verso casa
Mi ero allontanato una decina di chilometri da Neunhäuser quando il silenzio della campagna deserta, appena disturbato dal cigolio della mia bicicletta, fu sostituito progressivamente da rombo di motori, fischi, richiami urlati in lingue diverse. Quella congerie di rumori mi segnalava chiaramente che la stradina che stavo percorrendo andava a confluire in una strada statale grande e trafficata.
Mi fermai a una cinquantina di metri di distanza dall’incrocio per osservare e capire meglio.
Vidi un viavai di automezzi militari con la stella degli U.S.: camion, qualche corazzato e le Jeep della MP (polizia militare); andavano tutti a gran velocità, incrociandosi nelle due direzioni, strombazzando, rischiando di scontrarsi tra loro e di investire i civili.
C’erano infatti diversi civili soprattutto a piedi, alcuni in bicicletta, che andavano nella stessa direzione verso est portando valigie, zaini, sacchi in spalla, e quindi si capiva che erano gli sfollati che tornavano alle loro case in città; andavano seri e silenziosi, alcuni singoli, altri a gruppetti familiari di tre, quattro persone: uomini anziani donne e bambini; tenevano lo sguardo abbassato, attenti a non inciampare sulla strada rovinata dalle bombe e dall’incuria degli anni di guerra. Leggevo sui loro volti l’ansia di arrivare e insieme la paura di arrivare e trovare saccheggiati, o peggio distrutti dalle bombe, gli appartamenti, i negozi, i laboratori, che avevano lasciati incustoditi. Alla paura delle bombe si era sostituita, altrettanto spiacevole, l’incertezza del futuro.
Gli appiedati camminavano disciplinatamente ai due lati della strada. Si rivelava, ancora una volta, il diverso atteggiamento comportamentale dei tedeschi che sono sempre disciplinati anche nella mala sorte, nella sconfitta e nella rassegnazione alla disgrazia; un atteggiamento che contrastava con la disordinata allegria e l’esuberanza dei vincitori.
Non avrei voluto correre il rischio di essere fermato dai militari, ma ora non potevo tornare indietro e ripresentarmi a casa di Erich. Neppure potevo avviarmi per i campi per cercare un’altra strada perché, essendo il terreno scoperto, la visione del mio insolito comportamento avrebbe probabilmente insospettito gli agenti della MP che mi avrebbero inseguito e forse sparato. Quindi decisi di proseguire in bicicletta mescolandomi al traffico e cercando di darmi un’aria tranquilla e sicura, ma non era facile perché andavo ovviamente verso ovest e mi muovevo dunque in senso contrario al flusso della gente.
Feci così alcuni chilometri fino a quando incappai in un posto di blocco presidiato da militari alleati. Presentai i miei documenti a un soldato che li guardò dubbioso e li passò a un sergente. Costui aveva l’aspetto del classico sottufficiale di carriera, sicuro di sé, ma annoiato e desideroso di evitarsi problemi e grane. Mi disse qualcosa in una lingua biascicata che mi parve inglese. Feci segno di non capire. Allora il sergente dette alcune istruzioni al soldato che mi afferrò per un braccio e mi fece intendere a gesti che dovevo seguirlo; costui mi caricò su una Jeep dove c’era già un altro militare al posto di guida. La Jeep partì di colpo e per poco non caddi fuori. Il soldato che mi aveva preso in consegna si mise a ridere: evidentemente quel modo di partire era abituale e forse era anche uno scherzo. Finito di ridere estrasse dal taschino tre piccole stecche ricoperte di stagnola e ne offrì una all’autista e una a me, tolse l’incarto dell’altra e si mise in bocca il contenuto. Avevo già visto al cinema quell’azione e capii che si trattava di chewing-gum, ma non l’avevo mai assaggiato. Scartai anch’io, masticai e sentii un buon aroma di menta. Dunque il soldato non aveva intenzioni cattive. Ma dove mi stava portando?
Dopo qualche chilometro la Jeep uscì dalla statale e si avviò per una strada sterrata che più che strada era un fosso: buche, sassi, avvallamenti, pozzanghere d’acqua alta mezzo metro. Il motore ruggiva e la Jeep correva, saltava, si immergeva e riemergeva schizzando acqua e fango come in un gioco di ragazzi scavezzacolli. In quei momenti, aggrappato strettamente al sedile per evitare di essere catapultato fuori, capii perché gli americani avevano vinto la guerra. Quel mezzo di trasporto semplice e scarno ma incredibilmente robusto e maneggevole era la prova della loro superiorità industriale. Ovviamente sapevo qualcosa della loro superiorità aerea e navale, ma non ero mai stato su un aereo B-17 o su una nave da guerra, e quindi non ne avevo un’esperienza diretta, mentre sulla Jeep ci stavo e costatavo direttamente la differenza con le nostre Fiat 508CM derivate da auto civili e pure con le Kübelwagen tedesche, migliori delle nostre ma decisamente inferiori alle americane.
Alla fine di quella stradaccia un cartello con freccia indicava:
U.S. ARMY – Foreing Collection Center
Conoscevo pochissimo la lingua inglese, però mi sembrò di capire che mi stavano portando in un campo di concentramento. Di nuovo! Sembrava proprio che la sfortuna si accanisse contro di me, tuttavia sperai che gli americani mi trattassero un po’ meglio dei tedeschi.
Entrammo in un grosso recinto di filo spinato.
Era proprio un lager, simile a quello di Babelsberg. C’erano le solite baracche tipiche dei campi di concentramento, e tale doveva essere stato quel posto, ma gli americani lo avevano ripulito e adattato a un nuovo uso, come si poteva leggere su un grande cartello che specificava in diverse lingue, compreso l’italiano, che si trattava di un centro di smistamento. Seppi in seguito che serviva per identificare i prigionieri liberati e smistarli verso i loro paesi, ma anche per individuare e trattenere i tedeschi che dovevano eventualmente essere processati. Era cominciata la caccia ai criminali di guerra.
Venni portato nella baracca comando, in un ufficio con una scrivania dove, tra mucchi di fascicoli, un cartello chiariva che il suo titolare era il “Sergeant Paul John Cirino”.
Il sergente esaminò di nuovo i miei documenti e mi parlò in un italiano approssimativo, misto a inglese, e con un forte accento napoletano. Mi disse più o meno così:
“Paisà, tu italiano, primme priggioniero dei tedeschi e poi civilo. Va buo’, accussì te ne poi turnà in Italia. Nuie ci pensammo: io viene da Little Italy… do you know Little Italy in New York? Io me sient’ nu poco italiano perché my family, father and mother, came in U.S. from Napoli.”
Mi abbracciò, mi dette una pacca sulla schiena come si fa con un caro amico smarrito e ritrovato, quindi mi riconsegnò al soldato che mi aveva accompagnato, gli dette alcune istruzioni e si disinteressò completamente di me. Venni condotto in una baracca dove c’erano altri militari italiani liberati da poco dai lager della zona.
Adesso, in pratica, ero di nuovo un prigioniero perché non potevo uscire dal recinto di filo spinato, ma ero trattenuto degli americani che erano alleati della nuova Italia, quindi amici, e tuttavia trattavano gli italiani con sufficienza e un certo disprezzo. Però nel campo non si stava male, c’era poco controllo, nessuna disciplina, e soprattutto il vitto era buono.
Restai lì dentro per circa un mese che sembrò lungo un anno a causa della noia. A parte l’adunata della mattina per il controllo delle presenze e le eventuali istruzioni, poi non c’era nulla da fare per tutto il giorno. In una di quelle adunate venne dato l’avviso che i rimpatri sarebbero avvenuti appena possibile per ferrovia, mezzo che al momento non era ben funzionante per le interruzioni delle linee: per noi italiani era in particolare del tutto inagibile il tratto del Brennero. E questo era l’unico motivo per cui si restava trattenuti, scontenti noi e scontenti loro. Se a me e agli altri rinchiusi la permanenza dava fastidio, altrettanto fastidio dava agli americani che dovevano in qualche modo provvedere alle nostre necessità.
All’adunata mattutina del 7 giugno ci fu detto che la ferrovia del Brennero era stata finalmente riattivata. Il giorno dopo fui caricato con altri italiani su un camion e portato alla stazione ferroviaria di Braunschweig. Da qui partì un treno merci verso l’Italia.
Si ripeteva a ritroso quel viaggio che avevo fatto quasi due anni prima, e come allora nei carri-merci. Questi però erano stati attrezzati con panche che erano di legno ma avevano lo schienale e quindi, messa una coperta sul sedile, ci si stava abbastanza comodi. Comunque lo spirito era decisamente diverso, aperto alla speranza; e il cielo lattiginoso, com’è spesso in Germania, mi appariva comunque simpaticamente chiaro.
Fermata a Fortezza-Franzenfeste
“Tu-tun - tu-tun - tu-tun…” Di nuovo quel rumore dei carrelli sulle giunzioni dei binari, di nuovo quel dondolio interminabile, un po’ ossessivo e insieme soporoso.
Ci vollero tre giorni per arrivare in Italia. Il treno si fermava sovente nelle stazioni dove aspettava per dare la precedenza ad altri convogli e rallentava continuamente perché alcuni tratti dei binari erano stati ripristinati di recente e in modo alquanto approssimato, per cui si udivano talvolta, specie in curva, stridii sgradevoli e si avvertivano sballottamenti più accentuati. Passammo: Kassel… Würzburg… München… Innsbruck… per citare soltanto i centri principali e infine al terzo giorno arrivammo al Brennero.
Fu emozionante sapermi in patria, leggere cartelli scritti in italiano, vedere un paesaggio familiare… No, quello no! Veramente il paesaggio della valle del fiume Isarco, dal Brennero a Bolzano, non era italiano, ma tipicamente austriaco. Mi ritornò in mente il viaggio dell’andata con la fermata a Fortezza-Franzenfeste e mi ricordai di K2, il carabiniere Klaus Kurzschwarzer e l’aiuto che ci aveva dato il ferroviere Alois, suo zio.
Il treno, come all’andata, si fermò proprio a Fortezza-Franzenfeste ed ebbi l’impulso di scendere per avere notizie di K2. Forse era già tornato, forse Alois ne sapeva qualcosa. Però non ero autorizzato a scendere perché quella non era la mia destinazione, sul foglio di via c’era scritto: Orte. Ma nessuno controllava, specialmente dopo l’entrata in Italia, perché praticamente ognuno poteva sentirsi a casa e abbandonare il treno dove gli faceva comodo. Scesi e cercai Alois.
Lo trovai subito, era uguale a come l’avevo visto nel settembre 1943, in divisa da ferroviere e impegnato a manovrare le leve degli scambi. Non mi riconobbe. Lui no, non era cambiato, ma io dovevo essere parecchio diverso: intanto non ero in divisa, in più ero dimagrito, i capelli già radi si erano anche ingrigiti, e in tutto il mio essere fisico mostravo l’invecchiamento causato dai patimenti e dai brutti eventi che avevo subito.
Quando gli ricordai l’episodio di cui lui era stato protagonista e io testimone, si commosse e mi strinse la mano, forte e a lungo.
Gli chiesi subito se il nipote Klaus fosse già tornato o almeno se ne aveva notizie. Mi rispose con un groppo in gola che aveva saputo proprio pochi giorni prima che Klaus era morto a Babelsberg nel bombardamento del 14 aprile.
Mentre gli facevo le condoglianze il treno cominciò a muoversi. Salutai in fretta e feci per avviarmi, ma Alois Kurzschwarzer mi trattenne con una stretta imperiosa al braccio destro e ordinò:
“Aspettate. Dobbiamo parlare di Klaus. Non preoccupatevi del treno. Ve ne farò prendere un altro.”
Ubbidii, non sentii l’impulso di contraddire come mi era successo con Nina, perché lui aveva l’autorità per ordinare, aveva l’autorità morale che gli veniva dall’affetto per un parente morto da poco che intendeva commemorare con me.
Mi fece accomodare nella sala d’aspetto in attesa della fine del suo turno di lavoro, poi mi accompagnò a casa della cognata che era la madre di Klaus, una signora anziana che mi apparve chiusa nel suo dolore per la morte del figlio, ma composta in una dignitosa rassegnazione. Era anche vedova e ora viveva sola con i suoi tristi ricordi, ma dimostrava una grande forza d’animo.
Tornando in Italia fu la prima madre che incontrai che pativa per la morte di un figlio in quella orrenda guerra. In seguito ne incontrai tante e notai sempre la dolorosa rassegnazione di tutte, una rassegnazione generata dalla tragedia generale che aveva colpito la popolazione italiana per cui ogni madre lamentava il suo morto. Non diverso era l’atteggiamento di chi aveva perso un altro congiunto, un marito, un fratello, però questo appariva meno tragico. Il legame madre-figlio è il più diretto per natura e perciò la sofferenza per una innaturale rottura è la più grande.
Quando seppe chi ero, cioè il comandante della stazione dei carabinieri in Grecia dove era stato mandato Klaus, riuscì a manifestare una parvenza di sorriso; mi disse che Klaus le aveva scritto di me parlando di un buon comandante che considerava quasi un padre, che gli ricordavo appunto il padre, e mi chiese di raccontarle quel che sapevo del figlio dopo la cattura in Grecia e la deportazione in Germania. Klaus le aveva scritto diverse volte da Babelsberg, ma più che altro per dire che era vivo ma affamato e per chiederle di spedire pacchi di viveri.
Le raccontai qualcosa, omettendo il peggio che avevamo dovuto sopportare. Non volevo accrescere la sua pena. Le descrissi la messa di mezzanotte a Natale, il bellissimo canto del figlio e il particolare dello Schüttelbrot che lui aveva offerto al sacerdote per consentirgli di celebrare il rito eucaristico. Si commosse e lasciò che molte lacrime le scorressero sul viso. Fu l’unica volta che manifestò apertamente la dolorosa commozione che controllava sempre con forte dignità. Ci tenne a precisare che era stata lei stessa a preparare quello Schüttelbrot ed era orgogliosa che fosse stato consacrato e divenuto il Corpo di Cristo.
Volle che rimanessi suo ospite per la notte. La sera radunò un po’ di gente, la famiglia di Alois e pochi altri parenti. Si cenò tutti insieme, e durante la serata, si parlò della guerra e dei lutti: ognuno aveva perso qualche familiare, mentre qualche congiunto era ancora disperso o internato nei campi di concentramento dei russi.
La conversazione fu talvolta difficile perché alcuni non parlavano italiano e notai che proprio questi lasciavano trasparire una malcelata avversione per l’Italia. Stava già in incubazione il movimento che avrebbe, di lì a pochi anni, insanguinato quelle terre con gli attentati terroristici per rivendicare l’appartenenza all’Austria, e noi carabinieri saremmo stati tra gli obbiettivi degli attentatori. Allora non ne ero pienamente cosciente, né quelle persone furono esplicite perché stavano organizzando in clandestinità le azioni dinamitarde. Però ebbi già quella sera un brutto presentimento.
Un certo pessimismo, che ho maturato con l’esperienza, mi porta a pensare che l’uomo può essere amichevole e altruista soltanto nei rapporti tra singole o poche persone, e ciò avviene anche quando esse sono estranee e contrapposte per cultura e tradizione, e di questo ho avuto personalmente prova nel lager di Babelsberg, a Potsdam e a Neunhäuser. Quella sera, a Franzenfeste, la famiglia Kurzschwarzer mi era amica perché ero un singolo italiano, ma mi avrebbe considerato un nemico nei successivi anni degli attentati terroristici del BAS (Comitato per la liberazione del Sudtirolo) perché sarei stato il popolo italiano.
Come mi ha spiegato mio nipote in quello scritto che ho già riportato, quando gli uomini si fanno popolo e nazione, quando alimentano il nazionalismo, nascono le rivalità e, prima o poi, le guerre; non si fa in tempo a finirne una che già se ne prepara un’altra. Finirà mai questa orrenda catena?
Domenica prossima: ultima puntata