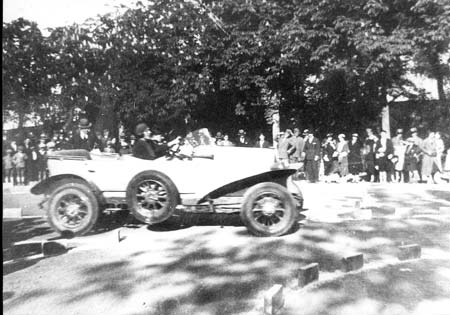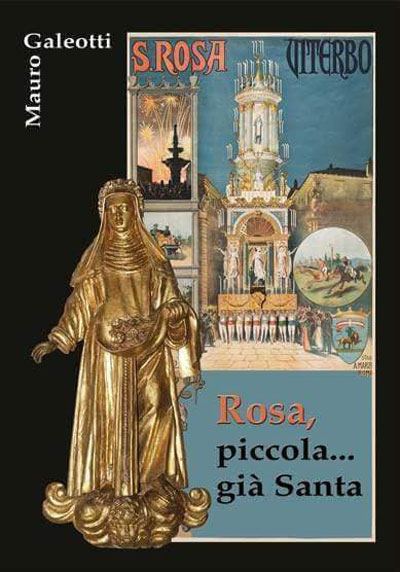Viterbo IL RACCONTO
Agostino G. Pasquali
IL RACCONTO: Schüttelbrot a Natale 1943 – Seconda serie. Prima puntata – Seconda puntata - Terza puntata - Quarta puntata
 Nemmeno ai miei otto colleghi piaceva l’eventualità di tornare nel lager.
Nemmeno ai miei otto colleghi piaceva l’eventualità di tornare nel lager.
Dato che io ero quello che parlava un po’ di tedesco, mi incaricarono di chiedere consiglio e aiuto a Herr Mayerfeld, il direttore dello stabilimento di Babelsberg, che si era dimostrato così benevolo nei nostri confronti nel corso del processo.
Gli parlai. Ascoltò cortesemente la mia richiesta, scosse la testa e chiese:
“Warum wollt ihr so streng nicht zurückkommen? Die Fabrik hat immer Platz für euch.” (Perché non volete, così ostinatamente, tornare? In fabbrica c’è sempre posto per voi.)
Tradussi la domanda del direttore e i miei compagni mi incaricarono di spiegargli che sarebbe stato inopportuno convivere con quei due ignobili personaggi che ci avevano denunciato e fatto rischiare la morte. C’era molto risentimento e qualcuno di noi avrebbe potuto creare un incidente per vendicarsi. Inoltre dovevamo pure mettere in conto che i guardiani non ci avrebbero accolti con simpatia.
Herr Mayerfeld ci pensò un attimo, capì che avevamo ragione e trovò la soluzione:
“Der Besitzer des Werks Babelsberg besitzt außerdem eine Fabrik hier in Potsdam. Mochtet ihr da arbeiten? Ich kann erbitten.” (Il proprietario della fabbrica di Babelsberg ha pure uno stabilimento qui a Potsdam. Accettereste di lavorare qui? Posso chiedere.)
Accettammo molto volentieri. Mayerfeld chiese e il proprietario della fabbrica acconsentì. E avvenne proprio come dice il proverbio: “Non tutto il male vien per nuocere”. Infatti dalla nostra disavventura derivò un grande miglioramento perché ci trovammo a lavorare come dipendenti, stranieri sì, ma regolarizzati ed esonerati dai controlli del lager.
In quel periodo c’era grande necessità di operai per i lavori pesanti dato che gli uomini stavano al fronte, mentre nelle fabbriche, che pure lavoravano a ciclo continuo, c’erano soprattutto donne.
Ci venne proposto di lavorare a turno, tre per volta, e il nostro compito era quello di carrellisti, cioè dovevamo spingere a mano i carrelli dei semilavorati (pezzi di lamiera e tubi), distribuire il materiale alle operaie, ritirare i pezzi finiti (ricambi per auto) e metterli in magazzino.
Il primo giorno avevamo qualche apprensione perché non si sa mai come si viene accolti in un ambiente estraneo e probabilmente ostile; temevamo di dover lavorare con donne che avevano padri, mariti, fidanzati, fratelli, i quali stavano rischiando la vita al fronte mentre noi, traditori dell’alleanza, ce ne stavamo al sicuro lontani dalla guerra. Certo, non saremmo stati accolti con simpatia. Ma, contrariamente alle previsioni pessimistiche, non ci sentimmo particolarmente discriminati: cioè eravamo stranieri ma utili e quindi rispettati pur nella diversità sociale che era, questa sì, ineliminabile.
Come operai ci fu assegnata un’abitazione vera, voglio dire un appartamento in una costruzione in muratura che era annessa allo stabilimento. Non era né elegante né aveva il calore di una casa familiare, ma almeno aveva un gabinetto bene attrezzato pure con la doccia e - proprio incredibile - l’acqua calda, e c’era pure una cucina. Inoltre ognuno ebbe un permesso di soggiorno e una tessera annonaria per gli acquisti di generi alimentari. Dunque abitammo in ambienti confortevoli e, possibilità tutt’altro che trascurabile, eravamo in grado di prepararci da mangiare all’italiana.
Che sogno: la pastasciutta nostrana! Il sugo di pomodoro! La spolverata di formaggio! Basta con le brodaglie del lager che sapevano soltanto di cavolo e di scarti di carne affumicata.
Riuscimmo a trovare della farina e ci ingegnammo a preparare la pasta. Presi dall’entusiasmo decidemmo dunque di farci gli spaghetti all’amatriciana, cioè una delle più semplici ricette di pastasciutta. Ovviamente gli spaghetti non c’erano, ma li facemmo noi. Impastammo acqua e farina ottenendo una massa collosa che era poco lavorabile e si appiccicava dappertutto, al tavolo, alle mani e al coltello con il quale cercavamo di ottenere dei bastoncini per poi tirarli e renderli sottili.
Con parecchio impegno e altrettanta pazienza riuscimmo a ottenere delle cordicelle irregolari del diametro di 7/8 millimetri, che erano rozze e irregolari e somigliavano agli spaghetti come una patata somiglia a una ciliegia. Ottenemmo una specie di ‘lombrichelli’ della cucina laziale, ma con quegli ingredienti e in quella situazione nemmeno Gualtiero Marchesi avrebbe potuto far meglio.
Rosolammo dei ritagli di pancetta, aggiungemmo del pomodoro e ne risultò un sugo che, con un po’ di fantasia, si poteva definire all’amatriciana. Mancava il formaggio ma, come ho detto, avevamo la fantasia, nonché molto appetito e un discreto spirito di adattamento. Mangiammo con un piacere che non avevamo mai provato prima, perché in definitiva è la fame il migliore ingrediente per trasformare un cibo approssimato in una preziosa leccornia.
Chi è anziano come me e ha vissuto quel tempo di guerra, anche se non era militare o deportato in un lager ma semplicemente un civile affamato, può capire che, quando il cibo scarseggiava o non si trovava affatto, quella specie di pastasciutta, impastata male e condita peggio, era comunque un rimedio per lo stomaco vuoto e un ristoro per lo spirito depresso.
Ho un nipote che spero leggerà questi miei ricordi. A lui che è giovane, nato e cresciuto nel dopoguerra al tempo del miracolo economico, vorrei dire:
“Beato te, anche se non ti rendi conto di quanto stai bene. E non ti lamentare per qualche piccolo inconveniente: se talvolta il termosifone non è caldo abbastanza, se la bistecca è un po’ dura, se l’ascensore è fuori servizio, se le bevande non sono fredde il giusto, se il treno ritarda, se c’è una coda in autostrada…”
Ma non mi illudo. Penso che lui, giovane dell’epoca del benessere diffuso, magari leggerà questi ricordi mentre degusta un whisky. Allora, atteggiando il viso a un sorrisetto di sufficienza, userà il suo gergo irriverente per dire: “Che palle! ‘sto zio matusa!”
Sotto i bombardamenti
Passarono i mesi e venne la primavera dell’anno 1945.
Ci eravamo adattati a quella vita lavorativa, che sarebbe stata monotona e insignificante, anzi quasi piacevole, se non ci fossero stati i bombardamenti. Almeno due o tre volte la settimana, a volte durante il giorno ma per lo più di notte, suonavano le sirene e si doveva correre ai rifugi. Il nostro rifugio era un sotterraneo della stessa fabbrica dove lavoravamo; era comodo e facile da raggiungere dall’interno dello stabilimento scendendo per una scala a chiocciola, ma ci si poteva arrivare anche dall’esterno, però in questo caso si doveva percorrere una stradina che, scavata nel terreno, scendeva progressivamente incassandosi e poi diventava un tunnel.
Comunque, tra un allarme e l’altro, si aspettava la fine della guerra.
Sopravvivere era l’unica cosa importante. Non ci curavamo più della politica, di Mussolini, di Hitler; e neppure dei russi e degli americani che, si diceva, stavano chiudendo a tenaglia le ultime logore armate tedesche. Sapevamo che gli americani o i russi ci avrebbero liberati fra qualche giorno, ma a quel giorno dovevamo arrivare vivi. E quindi l’importante era mangiare, dormire e risvegliarci.
Sopravvivevamo noi italiani passivamente nel più completo disorientamento circa il nostro futuro perché isolati dall’Italia e nell’assoluta ignoranza di sapere come stavano le nostre famiglie; tiravamo avanti, giorno dopo giorno, non avevamo speranze però non eravamo neppure disperati in quanto ormai ci eravamo assuefatti a quella situazione; vivevamo rassegnati e remissivi, quasi stolidi come gli animali da lavoro aggiogati o caricati con una soma su misura.
Né stava meglio la popolazione tedesca che sopravviveva stanca e delusa, ma non ancora rassegnata perché continuava ad illudersi con la speranza che Hitler riuscisse a rovesciare l’esito infausto della guerra utilizzando un’arma segreta, formidabile, irresistibile, che si diceva fosse quasi pronta. Così affermava con sicumera la propaganda del Reich.
* * *
Sospendo ancora una volta la narrazione perché mi chiedo come sarebbe cambiata la storia se Hitler avesse potuto disporre in tempo e usare l’arma atomica, perché di questa si trattava.
Gli Stati Uniti d’America furono i primi a costruirla e a usarla proprio in quell’anno 1945, e dominarono il mondo nel bene e nel male per parecchi anni, ossia finché ebbero l’esclusiva della bomba ovvero finché ne mantennero almeno la supremazia numerica. Adesso che la supremazia non ce l’hanno più, gli USA fanno ancora paura, ma hanno anche paura, e quindi contano sempre di meno.
Se fosse andata diversamente, come staremmo oggi?
Ovviamente è una domanda assurda dato che “la storia non si fa con i se e con i ma”, come disse uno nella Tv in bianco e nero degli anni ’60, mi pare Alessandro Cutolo. Era evidentemente uno spiritoso dalla battuta facile, ma superficiale. Infatti è vero che i se e i ma non fanno la storia, ma possono aiutare a capirla.
Sono tante le svolte della storia, talvolta sono variazioni piccole, talaltra grandi; oppure corsi e ricorsi come disse un altro, questo lo ricordo bene: fu Giambattista Vico, che però non mi convince perché la storia non è affatto meccanica come un orologio a pendolo.
E allora poniamoci qualche se. Se la flotta persiana avesse vinto a Salamina? se Bruto e Crasso avessero vinto a Filippi? se Napoleone non fosse stato battuto a Waterloo? se Mussolini non si fosse legato a Hitler? se… se… se… Domande alle quali si possono dare risposte, ma arbitrarie e partigiane.
Piuttosto mi pare evidente che le grandi domande riguardano sempre l’aggressività e la guerra. E allora è per me più importante questa domanda: “Perché l’uomo è fondamentalmente aggressivo? Perché si occupa soprattutto di lottare e combattere?”
Infatti aggressivo lo è sempre, e non solo in guerra ma anche in pace. Sì anche in pace, perché allora esercita e sfoga la sua aggressività nella rivalità spicciola, nella corsa al successo, nella competizione politica ed economica. E poi combatte con grande impegno, da protagonista o da tifoso, quelle battaglie metaforiche che sono gli incontri sportivi. Ma sarebbe meglio chiamarli scontri.
Mi azzardo a parafrasare e rovesciare un celebre detto di von Clausewitz: secondo me la politica della pace è la prosecuzione della guerra con altri mezzi meno appariscenti ma altrettanto aggressivi. Infatti la pace viene logicamente e cronologicamente dopo la guerra e non viceversa.
La risposta alla mia domanda potrebbe trovarsi nelle massime che ci sono nel quadruccio di mio nipote, quelle massime di cui ho già parlato, che si riassumono nel pessimistico detto: “Homo homini lupus”. E però se questa è la risposta, non è una risposta esaustiva in quanto spiega il “come” ma genera ulteriori domande sul “perché”.
Se l’uomo è stato creato da Dio, perché Dio l’ha creato aggressivo? E se invece l’uomo si è fatto così da sé per evoluzione naturale (Darwin), perché è passato dalla innocente aggressività animale alla cosciente e dolosa aggressività umana?
Non basta dire, con l’anonimo del quadruccio, “mala vitae vi” cioè per la violenza della vita.
E dunque ecco l’ultima domanda, la più importante:
“L’uomo è l’unico essere che ha consapevolezza e sa distinguere il bene e il male. Infatti gli uomini decidono liberamente di compiere azioni buone (poche?) o cattive (molte?) e se ne rendono conto. E allora perché non scelgono di essere buoni, o almeno non aggressivi?”
Continua domenica prossima